“ODISSEA”, UNA VIA CRUCIS IN CHIAVE LAICA

Versione interattiva http://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-aprile-2021/
Archivio sito http://www.lavoroesalute.org
Un viaggio nelle fatiche e nelle sofferenze di chi vive la disabilità mentale, attraverso le voci e le storie degli attori del Teatro patologico di Roma.
Odissea: metafora del viaggio umano, del cammino esistenziale nella sofferenza e nelle difficoltà. Per tornare a casa, come Ulisse nel poema omerico, che vuol dire trovare una stabilità, un porto sicuro, degli affetti, un sostegno. Oggi, l’odissea è quella di chi, a causa della pandemia, si è ritrovato a terra, senza un lavoro e un sostegno, di chi deve provare a ricostruirsi una vita da zero raccogliendo le macerie della sua esistenza, di chi ha perso familiari e amici, o ha vissuto sulla sua pelle la solitudine imposta da un virus. I moderni Ulisse sono coloro che fuggono dalle guerre, che attraversano i deserti, i confini, solcano i mari per cercare una nuova casa. Le odissee sono quelle chi vive la disabilità mentale, una condizione di estrema vulnerabilità che le restrizioni della crisi sanitaria hanno drammaticamente peggiorato. Sono loro, le persone con disabilità mentale, i protagonisti del film-documentario L’Odissea, ideato e realizzato da Domenico Iannacone, andato in onda su Raitre in prima serata venerdì 2 aprile. Sono gli attori del Teatro patologico di Roma, un’ associazione nata nel 1992 grazie all’ impegno di Dario D’ Ambrosi, attore e regista, che promuove e sviluppa attività teatrali per persone affette da gravi problemi psichici, facendo del teatro uno strumento per uscire dall’ isolamento.
Un viaggio nel viaggio un grande evento sulla spiaggia di Ostia, dalla compagnia del Teatro patologico. Una libera rivisitazione del celebre poema omerico in cui emergono con forza i temi del disagio, dell’ emarginazione, dell’integrazione. «Le odissee che racconto», «sono quelle di Paolo – che sulla scena veste i panni di Ulisse – un ragazzo di meno di 40 anni affetto da una depressione profonda, molto grave. E poi c’ è Marina – Penelope sulla scena -, una donna di circa 50 anni che ha subìto tantissimi ricoveri in ospedali psichiatrici, una persona con una grandissima vitalità, che vive con il padre, ed ha raccontato tutto ciò che le è successo quando è stata rinchiusa. Carlo, che interpreta il capo dei proci, ha 35 anni, è nato prematuro e ha un ritardo cognitivo. Ma è un genio dei numeri: tu gli puoi indicare qualunque data e lui ti snocciola immediatamente tutto quello che è successo quel giorno. È incredibile, non gli sfugge nulla. Claudia, che interpreta Circe, è una ragazza con sindrome di Down appassionata di chiese e di fantasy. E poi Fabio, uno dei proci, che oltre ad avere un ritardo nell’ ambito della sfera autistica, è investito da ricorrenti crisi epilettiche, e tanti altri».
Iannacone non si è limitato a osservare e narrare è entrato nelle storie, nei viaggi esistenziali, li ha presi su di sé, li ha fatti propri. Certe vicende ti segnano, ti restano incise nella pelle. Non puoi semplicemente guardarle, devi assimilarle, farle tue, non abbandonarle, seguirle nel corso del tempo. E l’ odissea degli attori, allora, diventa anche la sua personale odissea. «Nel documentario, ad un certo punto Dario porta Iannaccone in un deposito costumi in presa diretta. Cerca la camicia di forza, quella che avevano fatto indossare a Dario quando si era fatto ricoverare per tre mesi all’ istituto psichiatrico “Paolo Pini” di Milano per studiare il comportamento dei pazienti, la fa mettere ad Iannaccone. È un momento fortissimo. Gliela lega dietro e gli dice: “Muoviti”. E risponde: “Mi sembra di soffocare. L’ unica cosa che puoi fare in questa condizione è sbattere la testa contro il muro”. E poi mostra delle vecchie immagini dimenticate dei manicomi».
Una prova complicata, per il giornalista e regista, anche dal punto di vista della scrittura: «La sua voce nel film è un po’ quella di un cantastorie, di una sorta di Omero che ripercorre le vicende, mantenendo sempre un registro alto, per armonizzare il suo racconto alle vite dei protagonisti».
E uno sguardo alla pandemia, che ha approfondito le disuguaglianze, le condizioni già esistenti di vulnerabilità. «Stiamo vivendo la fase della fragilità assoluta. Ora tutto è labile, in bilico, fortemente minacciato. In questo momento, allora, forse possiamo specchiarci negli altri, nelle persone più fragili, perché in qualche modo è come se riconoscessimo anche noi la nostra fragilità. Rispetto al disagio mentale, gli esseri umani hanno sempre camminato su un filo: basta pochissimo per perdere l’equilibrio e ritrovarti in una dimensione che non è tua, senza sapere neppure perché. Ora siamo tutti molto più esposti alle cadute. E tutto ciò che prima ci sembrava importante adesso non lo è più: l’ arroganza, il disprezzo degli altri, la ricerca della ricchezza… Tutto questo è come se ora si fosse sgretolato».
Più di due ore di racconto televisivo denso, drammatico, carico di emozioni. Per il giornalista L’ Odissea non è stato un lavoro semplice: Ha dovuto lottare per imporre questo tema in televisione, vincendo le resistenze. Ha lavorato con risorse scarsissime, ha dovuto girare a singhiozzi a causa del Covid. Ma non ha mai mollato, perché aveva preso un impegno con gli attori del Teatro patologico e se avesse mollato avrebbe sentito di tradirli. Per chi ha una fragilità mentale, avere degli scopi, degli obiettivi è fondamentale.
« Mi piace pensare a questo viaggio nella disabilità mentale come a una Via crucis laica, il cammino dell’ uomo nella sofferenza. La Via crucis è, in fondo, lo specchio della società di oggi, attraverso la fatica, il dolore, le cadute, ma anche, alla fine, la rinascita».
La Società per dirsi Civile, dovrebbe accettare tanto la ragione tanto la follia umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è per la ragione. (Franco Basaglia)
“Visto da vicino nessuno è normale”. 40 anni fa la rivoluzione di Franco Basaglia che chiuse i manicomi
“Visto da vicino nessuno è normale“. In questa battuta lapidaria è contenuto il pensiero rivoluzionario di Franco Basaglia, padre della legge 180, che chiuse per sempre i manicomi ed una lunga sequenza di orrori e torture. Basaglia era convinto che nessuno di noi può dirsi pienamente sano mentalmente e che, quindi, non aveva senso internare i malati psichici ma bisognava reintegarli nella società attraverso un percorso di recupero che mettesse in primo piano la dignità della persona.
Una battaglia la sua lunga quasi vent’anni che ha trasformato l’Italia in un paese più civile. Molto si sa della legge che porta il suo nome (la 180) ma poco su di lui e sul percorso (anche filosofico) che lo ha portato a questo risultato.
Gli studi giovanili: opporre la filosofia esistenzialista ai totalitarismi positivisti. Franco Basaglia, nato nel 1924 a Venezia, studiò lettere classiche al liceo e si laureò in medicina a Padova nel 1943. In questo periodo di studi, decisivo fu l’incontro con l’esistenzialismo di Jean-Paul Sartre, che impronterà tutta la sua carriera psichiatrica successiva. Al centro della filosofia esistenzialista di Sartre sta un concetto di umanismo, a promuovere la libertà radicale dell’essere umano nelle proprie scelte, avulsa da qualsivoglia tipo di imposizione dall’alto: un nucleo di pensiero fortemente avverso a quello di Cesare Lombroso, sostanzialmente positivista, che giustificava l’intervento istituzionale su chiunque mostrasse segni di devianza psichica e disadattamento sociale.
Purtroppo, allora, l’ordinamento degli ospedali psichiatrici si ispirava ancora alle teorie lombrosiane. Sartre aveva postulato l’uguaglianza degli esseri umani nella loro individualità, dunque una società paritaria; Lombroso invece aveva diviso la società gerarchicamente, in esseri umani di serie A ed esseri umani di serie B.
In particolare, Lombroso negava l’evoluzione del carattere individuale umano; con semplicità scientista, etichettava le persone secondo ben precisi caratteri fisici ereditari, da lui individuati per distinguere i criminali dai normotipi.
L’antropologia criminale lombrosiana giustificò l’emarginazione e la discriminazione delle persone socialmente svantaggiate, che furono oggetto di internamenti non solo nelle carceri, ma anche nei manicomi, data la loro presunta instabilità o pericolosità. Per decenni, la teoria positivista fu alla base di un metodo di epurazione sociale considerato normale, che consentiva, sulla base di giudizi sommari, di condannare all’internamento perenne persone innocenti o scomode. Chi non era giudicato adeguato all’ordinamento sociale imposto dall’autorità, doveva essere, in qualche modo, allontanato, isolato, neutralizzato, in modo che non potesse destabilizzare la sicurezza e l’equilibrio della società. Da notare che di impronta positivista era anche la concezione politica del totalitarismo nazista: non a caso, l’organizzazione dei lager riprese molto da vicino quella degli istituti di igiene mentale, e proprio nei lager finirono migliaia di malati di mente, bollati come “asociali”, con il triangolo nero.
Dall’Università al lavoro sul campo: i manicomi. Dopo una specializzazione in Malattie nervose e mentali, conseguita nel 1953 a Padova, nel 1958 Basaglia ottenne la libera docenza in psichiatria. Tuttavia, non riuscirà mai a inserirsi nell’ambiente accademico, a causa della sua eterodossia rivoluzionaria. Decise invece di andare a lavorare sul campo, trasferendosi a Gorizia, dove ricoprì il ruolo di direttore del manicomio cittadino. Venne in contatto con la realtà custodialistica dell’istituto, ovvero di un trattamento aberrante nei confronti dei malati, che non venivano considerate persone in difficoltà e da aiutare, bensì soggetti da controllare, reprimere, sedare.
Insomma, una vera legittimazione della tortura dell’essere umano, un comportamento giustificato dalle autorità sebbene fosse del tutto antiscientifico. Partendo dagli studi di Sigmund Freud, Basaglia portò avanti una battaglia per un rapporto tra terapeuta e paziente basato sul dialogo e non sulla repressione. Sviluppò il suo pensiero anche in ambito politico e sociale, avvicinandosi alle teorie di Michel Foucault, mettendo in crisi l’istituzione psichiatrica, ragionando sulle forme di dominazione dell’uomo sull’uomo e svolgendo una riflessione sulla condizione delle categorie deboli della società: i malati di mente, i tossicodipendenti, le prostitute, gli immigrati, ovvero tutti i “fuori-norma”, gli “outsiders” della società di riferimento. La domanda di fondo su cui ragionò Basaglia era questa: è giusto escludere?
È giusto escludere?
La risposta di Basaglia. Basaglia. Rispose alla questione sull’esclusione sociale dei malati mentali con un’idea pratica del tutto innovativa per l’ambiente medico-psichiatrico italiano dell’epoca: la comunità terapeutica. In una comunità terapeutica, i medici, gli operatori e i pazienti hanno pari dignità; i rapporti non sono più verticali, bensì orizzontali, ovvero, viene privilegiata la collaborazione tra pari, rifiutando un regime gerarchico di ordine ed esecuzione. Bambinello della comunità, il malato non viene considerato come una “scoria” della società da espellere, bensì come risorsa da aiutare e recuperare. Basaglia mise in opera questo nuovo sistema nel manicomio di Gorizia e lo diresse per tutti gli anni Sessanta. L’obiettivo era uno solo: non più l’isolamento, bensì il recupero dell’individuo.
Il dialogo come nuova terapia per l’inclusione sociale. La terapia elettroconvulsivante venne finalmente messa al bando, e quella farmacologica considerata solo come una possibilità alternativa alla rieducazione al vivere comunitario. Le contenzioni fisiche vennero eliminate e si restituì, con la libertà di movimento, anche quella dignità che gli internati (o sarebbe forse meglio dire prigionieri?) avevano perduto. Nel manicomio istituzionale si verificava una perdita di identità sia da parte del paziente, disumanizzato e ridotto a oggetto, sia da parte degli operatori, innalzati al rango di onnipotenti manipolatori di vite umane altrui. Basaglia, col suo nuovo e innovativo approccio, che suscitò inizialmente grande stupore, intendeva correggere questa deriva disumana degli istituti di igiene mentale, ponendo sullo stesso piano del dialogo malati e medici.
Dario Fo e Franco Basaglia
L’Arte come cura per i disagi psichici e sociali. Nel 1971, Basaglia divenne direttore dell’ospedale psichiatrico di Trieste. È qui che mise in opera l’idea dei laboratori di artistici di pittura e teatro per i suoi pazienti: attraverso la produzione artistica, i malati riescono a rappresentare se stessi e il rapporto con l’altro, comunicano i propri disagi interiori e le insicurezze, ritrovano dunque un’identità e uno strumento per armonizzarsi con gli altri. I malati divennero produttori di arte, ma anche artigiani: nacque una cooperativa attraverso la quale i pazienti svolgevano lavori retribuiti ed utili per quella società che, matrigna, li aveva rifiutati e respinti. Basaglia raggiunse dunque l’obiettivo della reintegrazione sociale dei malati e riuscì a dimostrare l’infondatezza di un sistema basato sulla discriminazione e l’esclusione dell’essere umano.
Le pubblicazioni e i risultati istituzionali. Le due principali pubblicazioni di Franco Basaglia, utili per comprendere non solo la condizione dei malati mentali nei decenni centrali del Novecento, ma anche il pensiero sociopolitico dell’epoca attraverso le categorie opposte di normalità-anormalità, furono Che cos’è la psichiatria? (1967) e il grande successo editoriale L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico (1968), in cui racconta la sua esperienza goriziana. Nel 1973 fondò la società Psichiatria Democratica, per guidare una rifondazione degli approcci psichiatrici in Italia. Si fece così promotore del movimento antipsichiatrico nato in quel periodo in Inghilterra. Basaglia continuò a sostenere la sua battaglia finché nel 1977 poté annunciare l’imminente chiusura dell’ospedale psichiatrico di Trieste: quell’istituzione oppressiva non serviva più, ora che i suoi “prigionieri” erano stati liberati dal nuovo sistema curativo. Sicuramente fu grazie al suo impegno indefesso che l’anno successivo, il 13 maggio, si ratificò finalmente la legge 180 di riforma psichiatrica.
Manicomi chiusi: la guerra è vinta?
La guerra di Basaglia contro l’esclusione sociale non sarà mai vinta finché, nelle nostre società, si darà adito a processi di discriminazione basati su pregiudizi e ignoranza. Leggere l’opera di Basaglia è importante non solo per medici e psichiatri, ma anche per ciascuno di noi, cittadini ed esseri umani, per imparare il vivere comunitario nonché i valori dell’empatia, del rispetto e della libertà umana. La più bella lezione che Basaglia dà non solo ai medici, ma anche a tutti noi, è infatti questa: mai considerare l’altro, specialmente se in difficoltà, come “oggetto da aggiustare” o “problema da risolvere”, bensì come nostro pari da ascoltare, comprendere e nella cui esperienza di vita immedesimarci, senza avere paura di identificarci nella sua sofferenza, perché se gli uomini sono tanti e diversi tra loro, l’Umano è unico e uno solo è il suo spirito.
Marilena Pallareti
Docente. Collaboratrice redazionale di Lavoro e Salute
Versione interattiva http://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-aprile-2021/
Archivio sito http://www.lavoroesalute.org



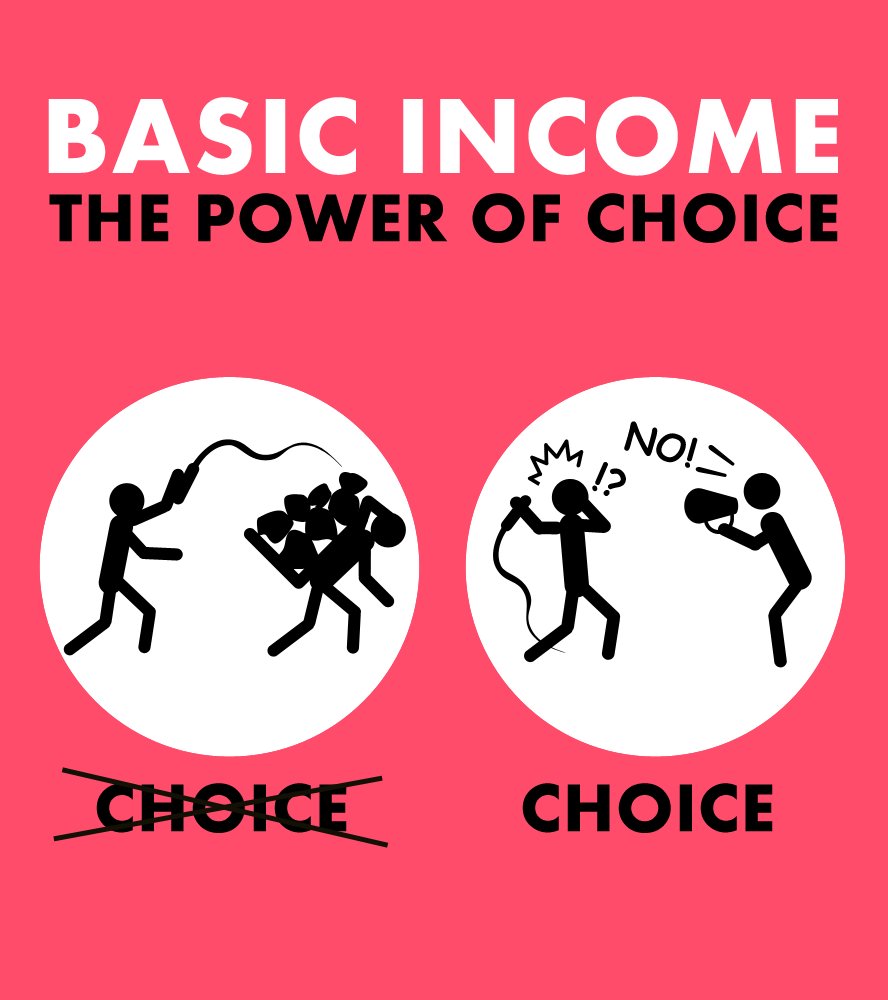






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!