Perché il Nord ha bisogno che il Sud cresca

Come è sempre accaduto nella Storia italiana, nelle fasi recessive il Mezzogiorno ha sperimentato una recessione più intensa rispetto a quella del Nord (con l’eccezione del biennio 2012-2013, nei tempi più recenti). In un’economia – quella italiana del 2019 – con un tasso di crescita prossimo allo 0%, le regioni più povere del Paese fanno registrare tassi di crescita di segno negativo, che vanno a sommarsi a una traiettoria di perdita di Pil che dura almeno dallo scoppio della prima crisi (2007-2008). SVIMEZ calcola, a riguardo, che dal 2008 al 2014 il prodotto interno lordo in termini reali si è contratto dell’8% nelle regioni del Centro-Nord e del 14% nelle regioni del Sud, con picchi di perdita di ricchezza nell’ordine del 16% in alcune aree meridionali (è un ordine di grandezza simile a quanto sperimentato nel corso della crisi greca).
Ovviamente si tratta di dati medi e va puntualizzato il fatto che il Mezzogiorno non è un’area omogenea, presentando, al suo interno, zone nelle quali sono localizzate imprese innovative e con elevata produttività del lavoro (si pensi all’area intorno a Bari o nel napoletano, o anche – seppur con molti problemi – alla possibile ripresa del polo di Casarano, nel Salento). In ogni caso, il Sud nel suo complesso ha visto contrarsi i consumi privati nell’ordine del 6% nell’ultimo decennio, ha subìto una contrazione del Pil pro-capite a prezzi correnti di circa 1.000 euro, ha sperimentato una riduzione del tasso di occupazione del 2% (320.000 unità di lavoro in meno), un’esplosione della disoccupazione giovanile (48% è il valore medio, con picchi vicini al 60% in alcune aree) e delle emigrazioni.
Il calo degli investimenti privati e soprattutto pubblici è quello che desta la maggiore preoccupazione, con una contrazione del 33% circa negli ultimi anni. La riduzione degli investimenti – pubblici in particolare – ha ridotto, contestualmente, la domanda interna e il tasso di crescita della produttività del lavoro. E, a sua volta, la contrazione della domanda interna (per il combinato del calo dei consumi e degli investimenti) ha fatto sì che il Mezzogiorno non rappresenti più un rilevante mercato di sbocco per le produzioni delle imprese del Nord.
Il progetto di ‘secessione dei ricchi’ – la cosiddetta autonomia differenziata – si inserisce in questa cornice macroeconomica. Il progetto, che formalmente si propone di consentire ad alcune regioni del Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) di essere più autonome per quanto attiene al recupero del gettito fiscale (ovvero di trattenere in loco il cosiddetto residuo fiscale – la differenza fra quanto i residenti in quelle regioni pagano e quanto ricevono) e per quanto attiene ad alcune competenze normative (istruzione in primo luogo), può essere letto come il tentativo – da parte di una frazione del capitale italiano – di disporre delle condizioni più favorevoli, in termini normativi e fiscali, per provare a recuperare margini di profitto attraverso il canale delle esportazioni. In tal senso, come è stato osservato, la secessione è dei ricchi nel senso che è secessione non solo e non tanto delle regioni più ricche ma delle famiglie (e delle imprese) con redditi più elevati.
Si tratta di un progetto che, se attuato (e l’attuale governo intende attuarlo nella sua forma meno estrema), incorrerebbe in numerosi rischi non solo per la coesione nazionale, ma anche per le stesse regioni che lo fanno proprio. Rischi così sintetizzabili.
Primo. Le regioni che richiedono maggiore autonomia sono quelle nelle quali sono localizzate imprese che producono beni intermedi per la grande impresa del centro del continente (Germania e Paesi satelliti): nel momento in cui – momento, peraltro, già in atto – l’economia tedesca comincia a intraprendere un sentiero recessivo, autonomia o meno, quelle imprese vedono ridotti i loro ordinativi e per conseguenza i loro margini di profitto. In altri termini, il progetto di autonomia differenziata può essere vantaggioso per le regioni del nord solo nelle fasi espansive del ciclo economico. Vi è di più. Quella frazione del capitale italiano che potrebbe essere interessata al progetto secessionista si identifica con la parte meno innovativa e meno esposta alla concorrenza internazionale dell’insieme delle imprese del Nord.
Secondo. L’autonomia differenziata genera incertezza, dal momento che, almeno nella fase di transizione al nuovo assetto istituzionale, si associa a una duplice produzione normativa: quella statale e quella regionale. L’incertezza è la variabile che maggiormente influenza la dinamica degli investimenti ed è pertanto ragionevole ritenere che una forte spinta secessionista produca un loro declino e, per conseguenza, una contrazione del tasso di crescita delle stesse regioni che la rivendicano.
Terzo. Le istanze secessioniste, come insegna l’esperienza spagnola (il caso della Catalogna), possono tradursi in istanze autonomistiche su scala sempre più piccola. Si consideri, a riguardo, che il 60% del Pil lombardo è prodotto nella sola città di Milano: in una ipotetica rincorsa a chi trattiene maggior gettito fiscale a ragione della sua maggiore ricchezza, la secessione lombarda potrebbe paradossalmente generare la rivendicazione di maggiore autonomia del suo capoluogo di regione, in una spirale di municipalizzazione che potrebbe non avere mai termine (sul filo del paradosso, quel 60% è generato in alcuni quartieri di Milano, che, in questa logica piuttosto perversa, avrebbero buon gioco per chiedere ulteriore secessione).
Quarto. Il calcolo del residuo fiscale – la differenza fra quanto i residenti nelle regioni che chiedono autonomia pagano per tasse e quanto ricevono in termini di trasferimenti pubblici – è pressoché impossibile sul piano tecnico. Si pensi, a titolo esemplificativo, a come computare la produzione di prodotti semilavorati provenienti da altre Regioni italiane nel Pil lombardo, o anche a come imputare il contributo del lavoro di emigrati che hanno conservato la residenza al Sud nel Pil di altre regioni. Stesse considerazioni valgono per l’imputazione della quota di titoli del debito pubblico detenuta da famiglie con residenza in Regioni del Sud o del Nord del Paese.
L’esperienza storica mostra che i maggiori tassi di crescita che l’Italia ha sperimentato si sono avuti negli anni nei quali sono stati minori i divari regionali e il Mezzogiorno è cresciuto di più. E’ il caso di ricordarlo per stabilire che il cosiddetto effetto locomotiva (l’economia italiana parte se partono le sue regioni più ricche) non ha quasi mai funzionato e semmai ha funzionato l’effetto contrario: storicamente, sono state le aree più deboli del Paese a trascinare la crescita delle aree più ricche.
Guglielmo Forges Davanzati
fonte: Nuovo Quotidiano di Puglia”, 15 ottobre 2019


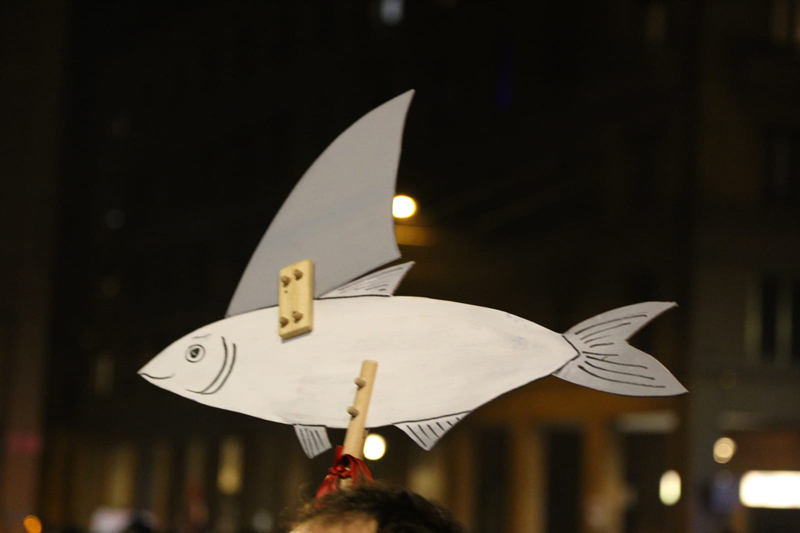


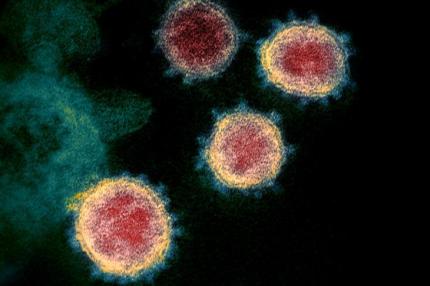




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!