Regolare la cura
In Italia, anziché come una responsabilità pubblica e collettiva, il lavoro di cura è ancora pensato come un affare di famiglia e svolto da lavoratrici immigrate, e gli strumenti per la sua regolazione continuano di fatto ad alimentare un modello basato sulle disuguaglianze. L’analisi di una sociologa
Il lavoro domestico e quello di cura sono al centro di un progressivo processo di marchettizzazione (marketization), in cui la cura è affidata in maniera sempre più preponderante a soggetti privati con e senza scopo di lucro.
In Italia, tuttavia, queste tendenze non sono del tutto consolidate, e la regolazione del lavoro domestico e di cura è ancora rivolta a mantenere quest’ultima saldamente all’interno delle famiglie. Si prediligono infatti politiche di mercificazione incentrate soprattutto sui trasferimenti monetari attraverso cui le famiglie pagano figure per l’assistenza domestica o familiare – che per la maggior parte sono donne immigrate.
Nel nostro paese, il processo di esternalizzazione della cura è stato favorito dall’utilizzo di schemi del tipo cash for care. I principali strumenti messi in campo sono due: l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura.
L’indennità è un trasferimento forfettario concesso a tutti i cittadini e le cittadine a cui viene certificata una disabilità sulla base di una valutazione medica, e che segue gli stessi criteri in tutto il paese.
L’assegno di cura, laddove esiste, è fornito dai dipartimenti di welfare locale sulla base di un “test dei mezzi” e di criteri altamente selettivi, fortemente eterogenei tra i comuni, e può essere pagato direttamente alla persona bisognosa o a quella che svolge il ruolo di caregiver.
Si tratta di misure molto limitate; in particolare, l’indennità di accompagnamento, che da sola copre circa il 45% del totale della spesa per le persone non autosufficienti e che costa 13 miliardi l’anno, è una prestazione monetaria in somma fissa, non graduata in ragione delle condizioni di salute, del reddito o del patrimonio.
È distribuita su una platea molto ampia (circa 2,2 milioni di prestazioni) e risulta quindi insufficiente a coprire completamente la condizione di non autosufficienza, che, secondo l’Istat, riguarda 3,8 milioni di persone.
In questo senso, anche la recente introduzione della “prestazione universale per le persone anziane” sembra essere uno strumento troppo selettivo, sia in ragione del fatto che interessa una platea di soli 30.000 individui, sia rispetto alla durata limitata del finanziamento, pari a due anni.
Una questione cruciale riguarda il modo in cui questi schemi influenzano il lavoro informale e la posizione dei e delle potenziali caregiver familiari: mentre nei paesi scandinavi o nell’esperienza francese tendono a essere molto regolati nelle loro possibilità di utilizzo, nel sud Europa vengono definite solo regole minime per l’utilizzo delle risorse.
Questo rafforza di fatto la centralità delle famiglie, che, dal ruolo di caregiver diretto, sono passate a ricoprire quello di care manager, cioè a dover trovare il lavoratore o la lavoratrice per svolgere il lavoro di cura e a traferire le risorse, secondo un meccanismo che ha contribuito alla creazione di un mercato informale ampio e non regolamentato.
Sul piano della regolazione, l’Italia è l’unico paese europeo ad avere una specifica rappresentanza dei datori di lavoro domestici (le famiglie), a cui si aggiunge il lavoro svolto dai sindacati.
La presenza di un vero sistema di relazioni industriali ha fatto sì che, fin dal 1974, il lavoro domestico e di cura fosse regolato attraverso un contratto collettivo nazionale (Ccnl).
Il contratto è sottoscritto da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf per le parti sindacali, e per le parti datoriali dalle due principali associazioni: la Federazione italiana datori di lavoro domestico (Fidaldo), aderente a Confedilizia, costituita da Nuova collaborazione, Assindatcolf, Adld, Adlc, e dall’Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico (Domina).
La storica funzione di ammortizzatore sociale svolta dalla famiglia e l’assenza di politiche incisive di conciliazione fra lavoro e vita privata (work-life balance) ha dunque spinto il legislatore a sostenere la possibilità, per le famiglie, di assumere personale domestico e di cura in maniera diretta.
La contrattazione collettiva, però, se da un lato ha potenzialmente aperto alla possibilità di limitare il lavoro nero e migliorare le condizioni di lavoro, dall’altro ha contribuito ad alimentare l’incapacità dello stato di affidare i servizi domestici e di assistenza alla gestione pubblica.
Infatti, nonostante la presenza del Ccnl, il settore continua a essere largamente informale e affidato prevalentemente alle lavoratrici immigrate. Seppur in aumento, l’utilizzo del contratto collettivo nazionale rimane ancora limitato e sostenuto soprattutto grazie alla pressione costante delle parti sociali.
La regolazione sconta evidentemente anche l’assenza di una politica migratoria in grado di regolare e regolarizzare maggiormente i flussi, comportando la necessità di doversi destreggiare tra una domanda di cura sempre più ampia e una tolleranza verso l’utilizzo di lavoratori e lavoratrici non regolari, che però permettono una certa flessibilità (nel salario e nelle ore lavorate), e soprattutto consentono alle famiglie di accedere a una serie di servizi.
A questo va aggiunto che, in assenza di una legge sulla rappresentanza, a oggi negli archivi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) i contratti depositati per il lavoro domestico e di cura sono 18, variamente sottoscritti da una serie di soggetti, con rappresentanza limitata, che spaziano dalle piccole associazioni imprenditoriali – la Confederazione piccole e medie imprese, l’Unione imprenditori e coltivatori, Artigianato e impresa, Assocostruttori, Federproprietà, Esercenti agricoltura, Federterziario – ai sindacati indipendenti – Confederazione autonoma lavoratori e pensionati, Assiociazione europea lavoratori e pensionati, equità fiscale, pensioni dignitose, Associazione nazionale immigrati ed emigrati, Confederazione unitaria di base, Confederazione indipendente dei sindacati europei, Federazione indipendente dei lavoratori atipici e inoccupati).
Ovviamente questi contratti presentano una serie di differenze rispetto al contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle tre sigle confederali, soprattutto per quel che riguarda la retribuzione, sensibilmente più bassa, e l’accesso ad alcune indennità, come quelle di malattia oppure alla formazione.
Nel complesso, si tratta di un sistema dinamico ma ancora sotto pressione.
Se le strategie, in parte coordinate dagli attori della rappresentanza, da un lato hanno garantito l’aumento dell’utilizzo del contratto nel corso degli anni, dall’altra hanno anche puntato a raggiungere un innalzamento dei livelli di qualificazione del comparto, nella logica di favorire occupazione formale e qualificata.
La certificazione delle competenze, formalmente riconosciuta all’interno del rinnovo del Ccnl siglato a settembre 2020, garantisce alle famiglie la possibilità di assumere risorse con competenze riconosciute, per le quali assicura a lavoratori e lavoratrici un riconoscimento economico.
Tuttavia, se almeno formalmente le condizioni di lavoro sono sicuramente migliori, la scelta di utilizzare il nuovo contratto collettivo nazionale rimane subordinata alla possibilità per le famiglie di sopportarne i costi aggiuntivi – in assenza di aiuti e in un sistema che sconta forti debolezze non solo economiche, ma anche culturali.
Pur con questi limiti, la strada del contratto collettivo nazionale può rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti – famiglie e persone impiegate per svolgere il lavoro di cura –, soprattutto perché permette a queste ultime di avere un’interlocuzione diretta con gli attori istituzionali.
Si tratta evidentemente di un modello unico nel panorama europeo, che ha la sua principale forza proprio nell’importanza assunta dalle parti sociali nei processi di regolazione.
La via italiana sembra presentare dei vantaggi anche rispetto al modello francese o belga: in questi paesi, la centralizzazione, attuata soprattutto con il ricorso ai voucher, se da una parte limita il lavoro irregolare e garantisce una certa continuità reddituale, dall’altra configura una situazione di maggiore staticità.
Il voucher, infatti, oltre a non comportare alcuna ridefinizione delle condizioni di lavoro, mantiene i lavoratori e le lavoratrici in una condizione di sostanziale isolamento.
Al contrario, in Italia il grande lavoro svolto sui territori dalle parti sociali, e in particolare dai sindacati, ha il vantaggio di fornire a lavoratori e lavoratrici, spesso immigrate e prive degli strumenti per fra sentire la propria voce, la possibilità di confrontarsi direttamente con i soggetti della rappresentanza, favorendo anche meccanismi di relazione e scambio tra pari.
Si tratta però di un modello monco, soprattutto rispetto alla gestione dei rapporti di intermediazione tra domanda e offerta, e che limitano i progressi ottenuti con il rinnovo del contratto collettivo nazionale.
I canali di reclutamento, ancora prevalentemente ancorati all’attivazione informale delle famiglie, da un lato favoriscono l’azione di soggetti privati, interessati soprattutto alle dimensioni del profitto; dall’altro, concorrono a generare ulteriori segregazioni, sia tra le persone che lavorano, sia nei servizi erogati.
Una buona soluzione potrebbe essere rappresentata dalla possibilità, per le famiglie, di detrarre totalmente o in buona parte le spese sostenute.
Accanto a questo, si fa però urgente la necessità di affidare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro all’intermediazione pubblica, o a soggetti accreditati. In questo senso, potrebbe essere strategica l’azione del terzo settore, che a oggi rappresenta l’unico attore in grado di offrire servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in contatto le famiglie con i lavoratori e lavoratrici.
Seppur non ancora pienamente sviluppate, le attività di intermediazione rappresentano un bagaglio di competenze strategico per venire incontro alle difficoltà incontrate sia dalle famiglie, nel reperire lavoro qualificato, sia dai lavoratori e lavoratrici, nel veder riconosciute le proprie competenze.
Sopperire alle carenze dei servizi pubblici per l’impiego, attivando soggetti già in possesso di una serie di canali di accesso a questo mercato, potrebbe essere una soluzione praticabile anche in tempi rapidi.
In conclusione, il vulnus principale sembra ancora essere rappresentato dall’incapacità di pensare alla cura come a una responsabilità collettiva e pubblica.
L’azione delle parti sociali, seppur articolata, si scontra con una gestione affidata alle risorse economiche e relazionali delle famiglie, sostenendo un modello che si mantiene asimmetrico e ineguale, sia per chi la cura la fa, sia per chi la riceve.
Luisa De Vita
10/4/2024 http://www.ingenere.it/
Riferimenti




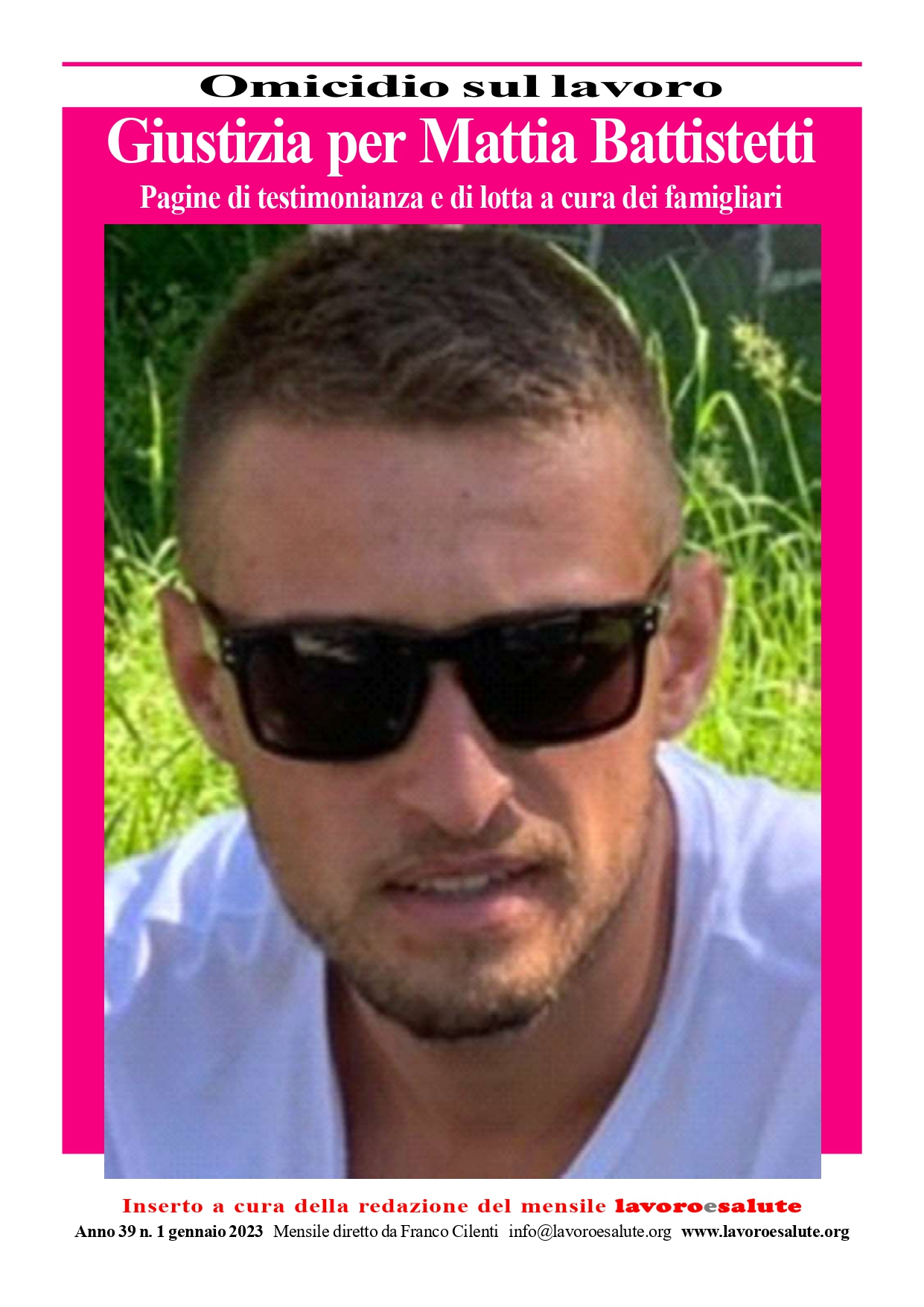

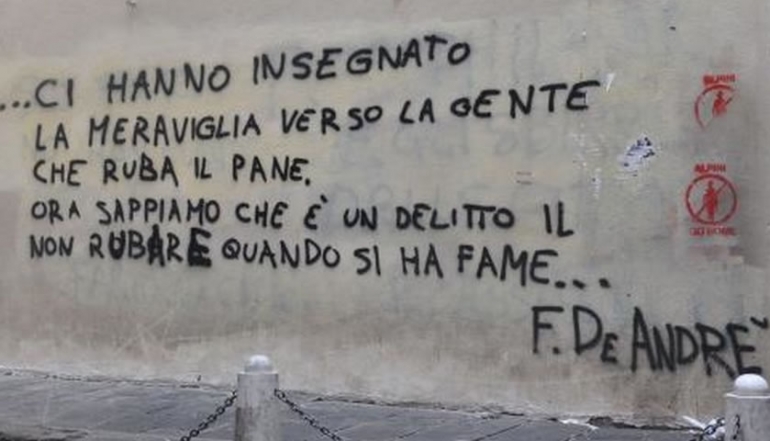



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!