Relazioni e salute mentale
Processi collettivi nella restituzione di significato delle soggettività. Evoluzioni ed involuzioni in “salute mentale”: i tre passi del “curare”
di Emanuela Bavazzano
L’assunzione di un significato che la parola “salute”, associata a “mentale”, ha da sempre comportato segna una distorsione semantica tipica di una società patologizzante (le normalità), per cui “non esiste salute senza salute mentale” ed al contempo “salute mentale” sottintende “malattia mentale”, senza neppure passare attraverso l’interrogativo in merito al disagio (interno),
quale forma di sofferenza in risposta a variabili esterne di ambiente di vita (sociale, familiare…).
Le famiglie ed, in forma più estesa, la rete di “sostegno” alle persone vulnerabili spesso si trovano sovra-esposte tra una lettura causalistica, dentro cui vive l’assunto della responsabilità individuale, di quella matrice culturale tipica di società in cerca di colpe personali, ed una lettura discolpante, facilmente assorbibile dentro una lettura organicista che, non ponendosi troppo l’interrogativo delle cause “ambientali” – collettive, finisce per divenire “attraente” e protettiva in termini di meccanismi di difesa, laddove l’alternativa sia un cilicio da indossare senza possibilità di espiazione.
Accade quindi che permane una lettura individuale di tipo quasi deterministico ed oggettivante, come se non si potesse uscire dalla traiettoria segnata per ontogenesi ed il deviare dalla stessa corrispondesse al non essere in normalità; ed anche le (apparenti) evoluzioni dentro il linguaggio della diagnosi sembrano abbassare la soglia di entrata in malattia, a partire da scostamenti da range medi – “normali”, così che trovarsi classificat* in disabilità già a partire dal primo affacciarsi alla vita di relazione (in ambiente scolastico) sembra essere un fenomeno non più così raro.
E le soggettività, che cercano risposta alla domanda di significato del proprio (o altrui) malessere, finiscono per trovarsi davanti alla diagnosi “oggettiva” fornita da un (s)oggetto “esperto”, che suppone conoscere quanto manchi al (s)oggetto “paziente” per stare nella salute mentale (benessere), e, dentro una lettura riduzionista di tipo presente / assente, conduce alla ricerca di “frammenti” mancanti o perduti, ipoteticamente supponendo di poterli ritrovare e riconsegnare (attraverso la chimica dei farmaci o la consegna di prescrizioni comportamentali) tramite“molecole” o “pillole di saggezza” che ricreino il puzzle di una identità deficitaria. Quale poi che sia, dentro questo scenario iper-semplificante (iper-normante), la psicodinamica sottesa nel processo di ricomposizione di significato globale, oltre la meccanica delle parti, non è dato sapere..
È aumentato quindi il disagio oppure si sono abbassati i cut-off per cui si esce dall’“agio” che, normando, normalizza e, di conseguenza, stigmatizza? E soprattutto rilevare il (supposto) uscire dalla norma, quale etichetta diagnostica di malattia – disabilità, facilita una inclusione oppure (anche solo dovendo sottolineare il tema della diversità in traiettorie di sviluppo, diverse modalità di funzionamento, diverse “abilità” presenti invero anche nella lettura abilista) di fatto riproduce
una divisione (di classe) in abili – disabili – non abili, ricreando ambienti separati, col presupposto di progetti “personalizzati”?
Ma siamo realmente nella convinzione che il disagio sia da leggersi in chiave individuale piuttosto che dentro un clima, in cui si sia venuto configurando un sintomo (ovvero una sindrome), quale disagio di soggettività non libere di esprimersi o costrette ad una deviazione per sopravvivenza (basti pensare alle fughe psicotiche in età giovanile, forse transitorie – di base – nel sopravvivere alle tempeste o alle mancanze di significati, per ricercare i quali i corpi e le anime delle persone entrano dentro una prospettiva all’apparenza chiusa, per ritrovarsi)? E, si badi bene, questo naturalmente non presuppone che le colpe siano da ricercare nella matrice familiare (soprattutto materna, perché – storicamente – è da lì che si suppongono derivare somiglianze – conseguenze, sovente senza neppure troppo interrogare la causa paterna, anche se gli studi psicoanalitici recenti molto si sono posti in allargamento di orizzonte di senso, che tende comunque a restare dentro – se non per una lettura transgenerazionale, che prova ad andare oltre il confine di famiglia classicamente intesa nei termini di ruoli generativi riassuntivi le responsabilità).
E se durante il tempo della chiusura le persone restano nell’isolamento (di senso), per cui si finisca per (co)determinanti – variabili – ambientali (sociali)? Come poterci riconnettere ad un benessere individuale e collettivo, che tenga insieme etica e deontologia, e rispetto delle diverse soggettività? Questo può essere l’interrogativo che apre le riflessioni (che seguono, nel presente contributo) su Quale cura per quale forma di sofferenza ovvero Quale prevenzione in risposta a
variabili di ambiente di vita che possono facilitare la creazione di un clima, in cui possa germinare un processo di trasformazione creativo che, rispettando la complessità psichica, porti ad un miglioramento (soggettivo) del proprio stare bene al Mondo.
“Curare” presuppone una persona che agisce un intervento di cura ed una che lo riceve; così, l’atto del curare sembra riprodurre il meccanismo di de-soggettivazione, tipico della divisione di classe, per cui acquisisce diritto di parola e protagonismo soltanto chi detiene il sapere e, di conseguenza, il potere (l’esperto). In questo scenario, domina una cultura paternalistica, che permea le prassi non solo in Sanità, ma anche nel Sociale, con le risposte ai bisogni che discendono da un a-priori, che deriva da ciò che conviene ai detentori del potere di acquisto e produzione di beni materiali, non sempre nell’interesse della persona (abile – disabile – non abile).
In questa lettura, il sapere e le prassi tendono a derivare da un corpus teorico, cui possono accedere solo gli “esperti”, definiti come i soggetti che hanno conoscenze e competenze apprese, che si traducono in interventi tecnici, per cui (per differenziazione di ruolo) “paziente” è colui che è “in carico” a livello individuale, separando malata/o da malattia – sofferenza e da cause – con- cause (familiari – sociali …) che la determinano, anche quando si tratterebbe di esaminare quanto l’ambiente crei fattori di rischio condizionanti la salute, le case malsane definiscano i bisogni, l’isolamento li aggravi.
In questa proposta di riflessione, si sposta l’attenzione da un modello di cura riduzionista, impostato su di una relazione diadica (tra chi cura e chi viene curata/o) ad un prendersi cura che presuppone una lettura comprensiva dei problemi ed una messa in crisi della cultura dominante, coinvolgendo la collettività, preoccupandoci prima di tutto di avviare un percorso di prevenzione che guardi alle diverse componenti di cui la lettura multidimensionale dei bisogni deve occuparsi, spostandoci dal determinismo, per scegliere la traiettoria della fiducia nel processo di evoluzione
nei cambiamenti che siano innanzitutto “desiderati” (etica della cura significa rispetto per le libere soggettività di esprimersi nel desiderio che attivamente muove le traiettorie di “bene”).
Il primo passo per rendere la persona protagonista del suo percorso di cura si suppone in realtà consistere proprio nel renderla consapevole (facilitando l’acquisizione dell’insight individuale).
Come è possibile attivare un simile processo, se non nella restituzione della soggettività, interpretando insieme (curante e curato/a) i segni (sintomi), dentro una lettura fenomenologica e comprensiva, che sposti verso una “cultura di cura” che sia anche una cura dell’interesse comune, del bene comune? “Prendersi cura” (diversamente dal curare, in termini tradizionali) presuppone infatti essere coinvolti dentro un percorso di co-partecipazione, durante la rilevazione dei bisogni
così come nella scelta delle traiettorie di risposte possibili a questi, soprattutto quando si voglia rispettare la complessità del vivere, in una lettura multidimensionale, caleidoscopica e cangiante, che osservi anche gli ambienti di vita ed i rapporti che dentro questi si vengono configurando.
Il secondo passo quindi per prendersi cura delle persone consiste nel superamento della lettura paternalistica, come pure di quella maternalistica, per cui “basta lo sguardo”, “basta il sorriso” (semmai potremmo giustapporre a quest’ultimo anche il pianto, che almeno potrebbe rispondere al dolore di chi soffre), ripensando le città e le relazioni tra le soggettività che le abitano quali Comunità di cura, superando il tema del tecnicismo specialistico (prestazionale e meccanicistico), in risposta ai bisogni, e richiamando l’etica della cura, intesa quale compito di tutte le persone che abitano il Mondo, dentro vincoli di solidarietà e di mutualismo, dove lo stesso abitare insieme può divenire parte di quella facilitazione della restituzione di un benessere che sostanzia il prendersi cura comunitario.
Il terzo passo consiste nel promuovere prassi di cura collettiva – prendersi cura comunitario, coinvolgendo le persone che possiedono conoscenze e competenze, nel metterle in comunicazione facilitando insight collettivi, attraverso meccanismi di co-partecipazione nell’intercettare i bisogni, prima che divengano “malattie” (perché ci si ammala anche di povertà, marginalità, solitudine, quando i bisogni siano psicologico-relazionali e socio-abitativi, così come ci
si ammala anche perché non si sono avuti gli strumenti necessari per curarsi). È necessario promuovere una cultura, per cui le persone siano rese consapevoli dei propri diritti, che conseguono l’essere portatrici di domande alle quali devono essere date risposte, e siano sostenute nel richiederne l’esigibilità e nell’ottenere un sostegno al vedersi riconosciute nelle proprie soggettività.
Esistono esperienze di mutualismo dal basso, dove le domande, declinate in termini di espressione di bisogni, prima ancora che di segni – sintomi, possono essere portate in modo “semplice” (diretto) e le risposte possono essere fornite sia direttamente (tramite l’ascolto consapevole) che nell’attivazione della rete dei servizi pubblici competenti – sanitari, sociosanitari, sociali; l’esperienza è ad esempio quella della Brigata Basaglia (Firenze), realtà nata già nel marzo 2020 (Milano), per rispondere durante il lockdown ai bisogni delle persone derivanti da un disagio psicologico (sportello di ascolto, orientato anche nei termini di supporto sociale per la comunità), attraverso risorse – intese nei termini di persone non caratterizzate dall’essere professioniste, partendo dal presupposto che non sia solo la clinica a curare, ma che la Cura lo faccia anche e soprattutto la comunità e che, eventualmente si presentasse un problema complesso, possa esserci una facilitazione di invio verso la rete dei servizi territoriali.
Nel prendersi cura comunitario delle persone che soffrono, particolarmente quando la sofferenza sia di difficile interpretazione nella caleidoscopica forma del dolore dell’anima (sofferenza, prima ancora che malattia mentale), la nonviolenza deve essere la base su cui ri-fondare le prassi, facendo uscire le persone dalle strutture che ri-editano i manicomi, oltre le coercizioni (anche quelle chimiche – farmacologiche) e oltre l’istituzionalizzazione (dentro le strutture residenziali), superando la gestione assistenzialistica, fornendo strumenti di consapevolezza, perché possa
essere valorizzata la capacità di auto-cura e di un prendersi cura responsabile del contesto (ambientale e relazionale – multi-familiare) dentro cui le persone abitano.
Ri-definire un’idea politica di Cura significa promuovere un’idea di Società, che sappia impegnarsi
ad assicurare standard di Giustizia per tutti e per tutte, attraverso sguardi che sappiano scorgere, oltre i propri orizzonti individuali, prassi collettive che, restituendo significato alle soggettività, trasformino le sofferenze attuando processi di prevenzione e promozione di una salute mentale che non arrivi alle soglie della “follia”, perché folle è il relegare (legando – chiudendo – destituendo valore a) il segno del disagio di una Società e colpevolizzare (“violentando”) le matrici familiari di una Collettività che ha bisogno di passare attraverso le crisi, necessarie, per giungere ad orizzonti di senso liberamente definito e raggiunto insieme.
Emanuela Bavazzano
Psicologa. Psicoterapeuta
Vice Presidente di Medicina Democratica
https://www.lavoroesalute.org/






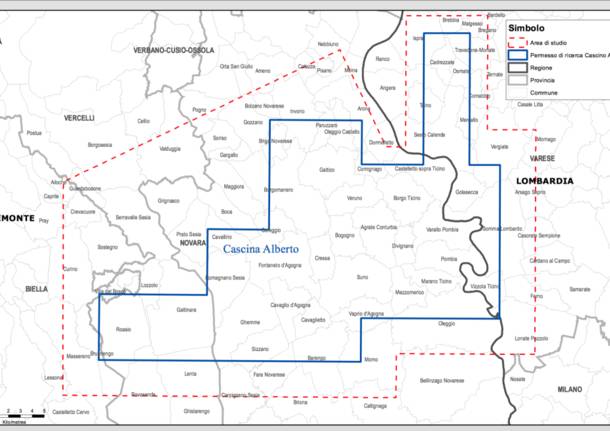




Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!