Riproduzione sociale: cosa ci dicono i dati Istat di dicembre?

Proviamo ora a rileggere questi dati: secondo l’Istat nel solo mese di dicembre vi è stato un calo degli occupati di 101.000 unità di cui 99.000 sono donne. Tra dicembre 2019 e dicembre 2020 il calo è stato di 444.000 di cui il 70% sono donne (312.000). La crisi si è verificata principalmente nel campo del lavoro precario e dei lavoratori autonomi, infatti benché i licenziamenti siano bloccati a pesare sono i contratti non rinnovati e le collaborazioni chiuse (precari -393 mila, lavoratori indipendenti – 209 mila). Tra il 2019 e il 2020 sono aumentati anche gli inattivi (cioè la forza lavoro che è sfiduciata e non cerca un’occupazione) di 482.000 unità. Ad oggi il tasso di disoccupazione è al 9% con punte del 29,7% per quanto riguarda la disoccupazione giovanile.
Complessivamente in Italia si contano, stando ai dati comunicati dall’ISTAT, qualcosa come 2.257.000 disoccupati, ai quali si vanno ad aggiungere 13.759.000 inattivi.
E’ necessario guardare anche alla situazione pre-crisi per cogliere le disparità e la profondità di questi dati:
le donne occupate nel 2019 erano meno degli uomini (il tasso di occupazione per le donne era del 50% a fronte del 69% per gli uomini); più frequentemente degli uomini inattive (il tasso di attività delle donne era 56% a fronte del 75% per gli uomini); quando lavorano sono occupate in servizi a basso valore aggiunto; hanno contratti precari o part time; hanno salari inferiori (nel 2017 i redditi complessivi guadagnati dalle donne sono stati in media del 25% inferiori a quelli degli uomini -15.373 euro rispetto a 20.453 euro).
Di cosa ci parlano dunque questi dati?
Proviamo a sviscerare le categorie di cui stiamo parlando e a guardare in controluce cosa si evidenzia. Infatti se la riduzione nel campo del lavoro dipendente precario appare a prima vista più chiaro, la sostanziale fetta di lavoratrici indipendenti colpite dalla crisi può a prima vista dare la sensazione di un effetto interclassista della perdita di occupazione. Quando si parla di lavoratori e lavoratrici autonomi in Italia si fa un grande minestrone. Per convenzione l’Istat distingue tra tre grandi raggruppamenti: autonomi con dipendenti, cioè datori di lavoro (1 milione 401mila), autonomi “puri” senza dipendenti (3milioni 314mila) e lavoratori parzialmente autonomi (338mila) [Dati 2018]. “Tra i lavoratori parzialmente autonomi sono più numerose le donne (50,2% a fronte del 24,9% tra i datori di lavoro e del 29,2 tra gli autonomi puri) così come le persone di 15-34 anni (35,5% rispetto al 10,7% dei datori di lavoro e al 15,8% degli autonomi puri). I lavoratori parzialmente autonomi comprendono quanti, generalmente in condizione di mono-committenza, presentano alcuni vincoli di subordinazione tra cui un orario di lavoro stabilito principalmente dal cliente o committente, il dover lavorare presso il cliente, l’impossibilità di assumere dipendenti, il mancato possesso degli strumenti del lavoro l’essere divenuti indipendenti a seguito di una richiesta di un precedente datore di lavoro.”
Un’altra distinzione che viene utilizzata per comprendere questo articolato mondo del lavoro degli autonomi è la dipendenza economica o meno da un committente principale (DSE). In confronto al totale degli indipendenti senza dipendenti, tra i DSE è maggiore la presenza di donne (48,9 contro 31,2%), giovani di 15-34 anni (40,5 contro 17,6%), laureati (37,3 contro 29,8%), residenti nelle regioni del Nord (58,8 contro 49,0%), stranieri (16,3 contro 6,5%)e occupati part time (45,9% contro 16,7%).
“La distribuzione degli occupati per settore di attività economica chiarisce ancora meglio le differenze tra i tre gruppi. Autonomi puri e soprattutto datori di lavoro presentano concentrazioni maggiori nei settori agricolo e industriale, in particolare nelle costruzioni (in questo comparto lavora l’11,5% degli autonomi puri, l’11,0% dei datori di lavoro e il 4,9% dei parzialmente autonomi). Nei comparti dei servizi i datori di lavoro e autonomi puri si concentrano soprattutto nel commercio, mentre tra i parzialmente autonomi si riscontrano addensamenti maggiori nei comparti servizi alle famiglie e alle persone (16,7%), sanità e assistenza sociale (15,1%), istruzione e pubblica amministrazione (10,8%), trasporti e magazzinaggio (5,2%). In particolare la concentrazione di DSE è elevata nel comparto degli alberghi e ristorazione (7,3%), in cui lavora anche il 14,1% dei datori di lavoro. […] Entrando nel dettaglio delle professioni, quote più elevate di parzialmente autonomi, rispetto agli autonomi puri, si concentrano tra istruttori sportivi non agonistici, alcune professioni sanitarie e infermieristiche e specialisti in terapie mediche e riabilitative (concentrati questi ultimi soprattutto tra i non DSE), venditori a domicilio, facchini e addetti allo spostamento merci, addetti all’informazione nei call center, conduttori di mezzi pesanti e camion, addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate. Vi sono poi quote meno consistenti anche di professioni più tipiche del lavoro dipendente nei servizi, quali commessi al dettaglio, camerieri o cuochi, addetti alle pulizie negli uffici, a dimostrazione della natura ibrida di queste figure. Tra i non DSE spiccano poi alcune professioni dello spettacolo, quali registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e i musicisti e compositori e, tra i giovani di 15-34 anni a inizio carriera, anche alcuni professionisti quali procuratori legali e avvocati e specialisti in contabilità, a indicare presumibilmente una possibile fase di apprendimento della professione in contesti di limitata autonomia.”
Sembra abbastanza evidente ad una prima occhiata che i settori più colpiti da questo calo dell’occupazione siano quelli che hanno a che fare con gli ambiti del terziario “basso”, in particolare con la cura, l’educazione e più in generale la riproduzione sociale.
In effetti questi dati del rapporto” Ripartire dalla risorsa donna” (sigh!) sembrano confermare che la tendenza era già aperta nei primi sei mesi del 2020: “La maggiore contrazione di lavoro femminile – si legge nel Focus – si registra nell’occupazione a termine (-327 mila lavoratrici per un calo del 22,7%), nel lavoro autonomo (- 5,1%.), nelle forme in part-time (-7,4%) e nel settore dei servizi, soprattutto ricettivi e ristorativi (qui le donne rappresentano il 50,6% del totale), e di assistenza domestica (le donne sono l’88,1%).”
Paradossalmente questo però non ha significato in alcun modo una diminuzione del carico di lavoro, né tra le donne occupate, né tra quelle inattive. Si legge ancora nel rapporto: “L’esperienza vissuta durante il lockdown primaverile ha visto le donne gestire un sovraccarico di lavoro senza precedenti. Da un lato, sono state più impegnate degli uomini nell’attività lavorativa (il 74% ha continuato a lavorare rispetto al 66% degli uomini), dovendo garantire servizi essenziali in settori a forte vocazione femminile: scuola, sanita`, pubblica amministrazione. Dall’altro lato, con la chiusura delle scuole, hanno dovuto garantire la presenza al lavoro e al tempo stesso assistere i figli impegnati nella didattica a distanza, con un livello di stress elevatissimo per quasi 3 milioni di lavoratrici con un figlio a carico con meno di 15 anni (30% delle occupate). “L’esperienza dell’home working unita alla scarsa flessibilità organizzativa di molte realtà lavorative e alla difficile conciliazione vita-lavoro,– rileva la Fondazione – rischiano di acuire il malessere del genere femminile. Nell’ultimo anno la tendenza ad allontanarsi dal lavoro, rinunciando anche alla ricerca di un’occupazione, è cresciuta sensibilmente, facendo registrare tra giugno 2019 e 2020 un incremento di 707 mila inattive (+8,5%), soprattutto nelle fasce giovanili”.
Questo apparente paradosso tra l’aumento del carico di lavoro e la diminuzione dell’occupazione ci parla direttamente di ciò che si intende quando si ragiona sulla crisi della riproduzione sociale. Ecco che qui si materializza in numeri (probabilmente anche sottostimati alla luce di tutto il sommerso presente in questi settori) la socializzazione dei costi di riproduzione e la privatizzazione dei profitti.
Lo shock profondo generato dalla pandemia sull’endemica organizzazione del lavoro di riproduzione si ripercuote lungo tutta la linea di classe, dove allo stesso tempo si vive lo scarico di questo lavoro e la sua mancanza e si innesta sulla discriminazione e subordinazione di genere. Il calo dell’occupazione nelle mansioni di assistenza domestica parla chiaro in questo senso. E infatti si assiste anche in questo campo ad una contemporanea deintegrazione di settori della forza lavoro che vengono espulsi, ma allo stesso tempo continuano a produrre valore, in molti casi ancora più intensamente, occupandosi delle attività di riproduzione della forza lavoro stessa che il capitale non vuole, né è in grado di assolvere. Come far pagare questa eccedenza alla controparte?
I dati di questa crisi ci devono far cogliere l’importanza di ingaggiare questa contraddizione e di elaborare gli itinerari adatti a rovesciare i rapporti di forza nella macrofabbrica della riproduzione sociale partendo tanto dal campo tradizionale del lavoro e del reddito, quanto da quello dei consumi, della discriminazione e del dominio e dell’organizzazione capitalista della cura e dell’affettività.
Per confliggere con la retorica liberista che contrappone garantit* e non garantit* dobbiamo necessariamente elaborare un discorso chiaro su questa crisi, sulla collocazione dei carichi di sfruttamento e sulle alleanze possibili in questo scenario.
Fonti:
https://www.istat.it/it/files/2018/11/Focus_indipendenti_2018.pdf
4/2/2021 https://www.infoaut.org




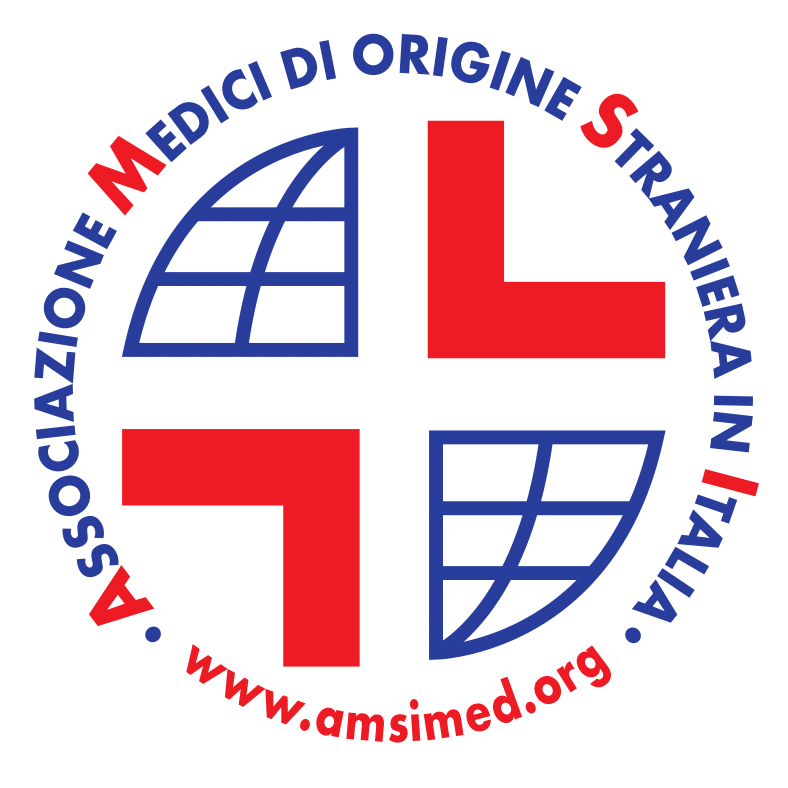


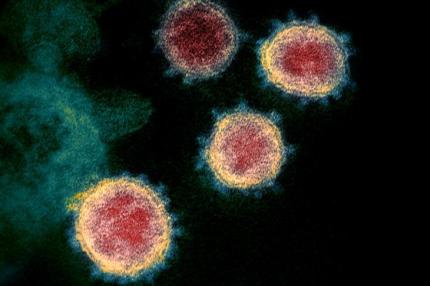


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!