Bernie Sanders in testa

Bernie Sanders è il primo candidato nella storia delle primarie americane sia democratiche che repubblicane a vincere il voto popolare in tutti e tre gli stati americani in cui si vota anticipatamente, Iowa, New Hampashire, Nevada. Le elezioni in South Carolina si terranno sabato 29 febbraio, il quarto stato chiamato a esprimersi prima del Super Tuesday che si tiene martedì 3 marzo in cui sono chiamati alle urne i democratici di altri quindici stati. Se in Iowa Sanders è arrivato quasi a un testa a testa con Pete Buttigieg, in Nevada il distacco è stato nettissimo: Sanders ha stravinto con un impressionante 46,8% contro il 20.2% di Biden, al secondo posto. La vittoria è stata dichiarata quando solo il 4% del voto era stato contato, tale era il distacco da tutti gli altri candidati. A conferma di come il voto in questi primi early states sia determinante – influenza pesantemente il voto nelle tornate che seguono e generalmente determina la posizione dei singoli candidati in gara.
Il voto in Nevada è stata seguito con attenzione per un dato in particolare: qui l’elettorato, altamente diversificato, rispecchia quello di molti degli stati in cui si vota il 3 marzo. Nello specifico, il 35% degli elettori del Nevada sono non whites – latinos, afroamericani e asioamericani. Il voto degli ispanici è stato decisivo: 53% contro il 16% di Biden, che rimane tuttavia il preferito presso la comunità afroamericana. In Nevada Biden è stato votato dal 39% di elettori afroamericani, contro il 27% di Sanders. Motivo per cui la partita che si gioca in South Carolina, dove la comunità afroamericana compone il 60% dell’elettorato democratico, sarà decisiva. Biden spera di contare su questa fetta di elettorato, nonostante l’ascesa di Sanders presso gli afroamericani sia stata costante e promettente. Se a livello nazionale Biden partiva da un distacco con Sanders di circa 30 punti, l’ultimo sondaggio mostra Biden al 31% e Sanders al 29%.
A ciò bisogna aggiungere che la comunità in questione è divisa: i giovani afroamericani propendono per Sanders – la cui base è in generale composta da giovani. In Nevada il 66% di giovani sotto i 30 anni di età ha votato Sanders, e il 48% di quanti hanno meno di 45 anni. Annunciando la vittoria in Nevada Sanders ha parlato di una «coalizione multigenerazionale e multirazziale» che vincerà perché al contrario quello che fa Donald Trump il movimento che lo sostiene «non divide, unisce». Il voto è trasversale: un dato interessante è che, stando agli entrance polls, l’elettorato del senatore socialista del Vermont è composto in Nevada da un 49% di persone che si definiscono «very liberal», da un 29% di persone che si definiscono moderatamente «liberal» e da un 25% di persone che si definiscono moderate o conservatrici – a dimostrazione del fatto che l’espressione «socialismo democratico» spaventa molto meno di quello che vorrebbero i centristi del partito democratico. Aiuta il fatto che recentemente Sanders ha spiegato come gli Stati Uniti siano un paese già socialista, nel trattamento riservato ai ricchi. La concorrenza spietata – fondamento intoccabile fino a oggi della sacrosanta libertà che permea l’ideologia americana – è infatti riservata esclusivamente ai poveri: quella degli Stati Uniti è una società che già si occupa della ridistribuzione della ricchezza verso l’alto, aiutando con incentivi e sgravi fiscali le multinazionali del paese che non pagano un centesimo di tasse federali. «Il governo dovrebbe aiutare le famiglie, non i miliardari», ha detto Sanders a Fox News, un messaggio che non sembra essere poi così spaventoso.
Il dato più interessante della prima fase delle primarie del partito democratico degli Stati Uniti è la scomparsa del centro.
Nei tre stati in cui si è votato finora al secondo posto non è riuscito ad emergere nessuno. Buttigieg, che in Iowa poteva annunciare la sua vittoria quando il conteggio non era ancora terminato – è stato poi confermato che il voto popolare è stato vinto da Sanders – ha ottenuto un mero 14,3% in Nevada. Joe Biden, dato come favorito inizialmente, è arrivato quarto in Iowa, quinto nel New Hampshire e secondo nel Nevada. A complicare lo scenario del voto che si terrà a marzo c’è l’ingresso di Bloomberg, l’ex sindaco miliardario di New York, che intende comprarsi i voti – avendo già investito quasi mezzo miliardo di dollari nella sua campagna elettorale è il candidato che ha speso di più nella storia delle elezioni americane. Se Bloomberg guadagna punti – un recente sondaggio lo dava al 14% dopo Sanders e Biden – è stato anche notato che il motivo di questa sua ascesa è quantomeno paradossale: i soldi sono stati investiti in spot pubblicitari in quegli stati in cui si vota a marzo e l’unico altro candidato che ha potuto farlo è stato Bernie Sanders, grazie al movimento che lo sostiene e che ha stabilito una serie impressionante di record consentendo a Sanders di disporre di più denaro di qualsiasi altro concorrente grazie a singole donazioni la cui media è di 18 dollari. In altre parole, se uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti ha una chance di competere con Donald Trump, questo è perché oltre a Sanders non c’è nessuno.
Durante il dibattito televisivo tenutosi il 19 febbraio è emerso quanto il frammentato voto moderato non faccia che rinforzare Sanders. Persino Bloomberg, che molti nel partito sperano emergerà come il candidato in grado di frenare la corsa di Sanders, è apparso vulnerabile agli attacchi degli altri candidati e in particolare della senatrice Warren, che a sua volta però non è stata in grado di capitalizzare quella che è stata definita la sua migliore performance della campagna elettorale – nulla della sua vittoria nel dibattito contro Bloomberg si è tradotto in voti in Nevada. Il “New Yorker” nota come la sola presenza di Bloomberg ha aiutato Sanders a far risaltare la sua visione. Il candidato socialista ha attaccato il miliardario sulle misure stop-and-frisk (le perquisizioni che prendevano di mira soprattutto neri e latinos) adottate a New York, ha ricordato come l’ex sindaco avesse opposto l’aumento del salario minimo, articolando una visione in cui la «lotta al razzismo e a favore della classe lavoratrice sono inestricabilmente connesse». A ciò si aggiunge la sanità pubblica e il cambiamento climatico, in un ragionamento «organico»: nessuna delle questioni che compongono il suo programma elettorale può essere affrontata isolatamente, e la connessione che le unisce è «radicata nella sua visione del mondo».
Una visione che chiaramente manca nei discorsi di tutti gli altri candidati. Persino Warren, considerata la candidata più “radicale” assieme a Sanders, colei che «ha un piano per tutto», ha perso gran parte della sua forza propulsiva quando ha deciso di staccarsi da Sanders e aumentare il livello dello scontro – la mancata stretta di mano al termine del dibattito televisivo tenutosi a gennaio era una mossa calcolatissima mirata a farla uscire dall’ombra di Sanders e presentarla come una candidata in competizione anche con lui. La scelta di come segnalare questo spostamento sembra averla penalizzata da subito: secondo Warren, Sanders le aveva detto che nessuna donna avrebbe potuto vincere la corsa per la Casa Bianca – lui ha ovviamente negato. L’utilizzo di un simile argomento da parte di lei – l’utilizzo strumentale della questione della discriminazione di genere, che ricorda molto il modo in cui anche Clinton cercò di aggrapparsi a un vuoto e generico concetto di “donna” – è apparso molto poco azzeccato, puramente strategico, non in linea con il tipo di contenuti che avevano invece caratterizzato la campagna elettorale di entrambi fino a quel momento. Con una seconda mossa che contraddice la prima, Warren è poi salita sul palco dopo il voto nel New Hampshire presentandosi come colei che poteva portare unità nel partito e mettere fine alla tensione tra la sua sinistra e il centro che aveva, secondo lei, rovinosamente influenzato le elezioni del 2016.
È da notare che lo scontro, in realtà appena cominciato, tra Sanders e questo disomogeneo e contraddittorio centro, è caratterizzato da una mancanza di contenuti che non siano Sanders stesso. Lo conferma il caotico dibattito del 25 febbraio, dominato dagli attacchi al senatore. Mentre il candidato socialista non usa attaccare di persona i suoi concorrenti, pare che l’assenza di un programma forte abbastanza da competere con il suo spinga i moderati tutti a ripiegare su argomenti di “realismo” tattico e vuoto di proposte – gli americani non voteranno mai un socialista, solo un moderato può sconfiggere Donald Trump – che nell’ottica dei sostenitori di Sanders è esattamente la riproduzione dello scenario che ha portato alla sconfitta dei democratici nel 2016. Per converso, Sanders è stato il primo, nel discorso pronunciato subito dopo la vittoria in Iowa, ad annunciare – in una sorta di avvertimento alla sua base teso a evitare quello spostamento che nel 2016 portò il 12% dei suoi elettori a votare Donald Trump piuttosto che a ripiegare su Hillary Clinton – che l’elettorato democratico tutto dovrà sostenere il candidato vincente, anche nell’eventualità non dovesse essere lui. La chiamata all’unità, in altre parole, è reale e non tattica, non è usata come argomento – a suo modo ricattatorio – per arrivare al potere.
Al momento l’idea più discussa riguardo al fatto che nessun contendente riesce ad affermarsi come rivale di Sanders è la necessità che alcuni candidati moderati abbandonino la corsa per far emergere e consolidare la posizione di uno sfidante solo.
Chi potrebbe essere è tutto da vedere, dati i risultati completamente disomogenei e il numero di contendenti – queste primarie sono anche quelle che vedono in assoluto il maggior numero di partecipanti alle primarie. L’attacco dei moderati è e sarà feroce, anche se per ora si è rivelato inefficace e addirittura controproducente. Hillary Clinton disse, lapidariamente, «a nessuno piace Sanders». Bill Clinton ha detto: «se lo votate perché pensate che vincerà le elezioni perché riuscirà a mobilitare quella parte dell’elettorato che è stata fin’ora dormiente, siete politicamente stupidi – e questo è un fatto». Il ragionamento è tautologico, oltre che offensivo, come spesso accade nel caso della sinistra dei grandi interessi, e si limita a dire che non bisogna votare Sanders perché nessuno lo voterà. In verità non c’è editoriale che non abbia commentato il fatto che a ogni pronostico negativo Sanders non ha fatto altro che rafforzare esponenzialmente la sua posizione. Sulle sue pagine – Twitter, Facebook, ecc. – ogni attacco viene accolto con dei veri e propri festeggiamenti da parte della base: sembra che il panico di scettici e moderati, di quella che viene percepita come l’élite bianca e benestante delle grandi metropoli progressiste, non faccia altro che contribuire alla sua causa.
Le primarie sono solo all’inizio, resta da vedere come andrà lo scontro tra Sanders e Biden in South Carolina – per ora il secondo è dato vincente con un leggero vantaggio che continua a diminuire – cosa succederà quando Bloomberg entrerà la corsa il 3 marzo e soprattutto cosa deciderà di fare l’establishment per quanto riguarda l’elezione dei cosiddetti superdelegati, scelti direttamente dal partito democratico e chiamati a votare per il candidato in caso di ballottaggio. Le regole sono cambiate proprio in seguito alle primarie del 2016 e alle proteste di Sanders, è la prima volta che i superdelegati non partecipano alla prima tornata di voti, quella in cui voteranno solamente i delegati che sono eletti direttamente da chi partecipa alle primarie. Nel caso Sanders non dovesse raggiungere la maggioranza netta i superdelegati nominati dal partito, dunque dalla maggioranza centrista, potrebbero determinare la vittoria di un candidato che non ha ottenuto la maggioranza di voti popolari. È in questo senso che bisogna tenere a mente la domanda rivolta ai partecipanti durante il dibattito televisivo del 19 febbraio: cinque su sei – l’unico a rispondere positivamente è stato Sanders – hanno detto che non sono disposti a sostenere il candidato più votato dagli elettori.
Il dato importante, nonostante le incognite, appare molto semplice ed è la risposta massiccia, importante, senza precedenti a un programma che è di sinistra.
In fondo neanche radicale, come già veniva rilevato nel 2016. Il termine“radicale” è piuttosto d’obbligo per differenziare un programma che ha come punti principali un sistema sanitario pubblico, un sistema universitario gratuito, un insieme di politiche ambientali serie, una riforma dell’economia che ridia potere ai lavoratori, da una supposta sinistra che ha fatto della moderazione e del centrismo il proprio cavallo di battaglia, percepita in queste primarie a tutti gli effetti come una «classe» che insegue l’immobilismo, il potere, e il mantenimento dei propri privilegi.
26/2/2020 www.dinamopress.it



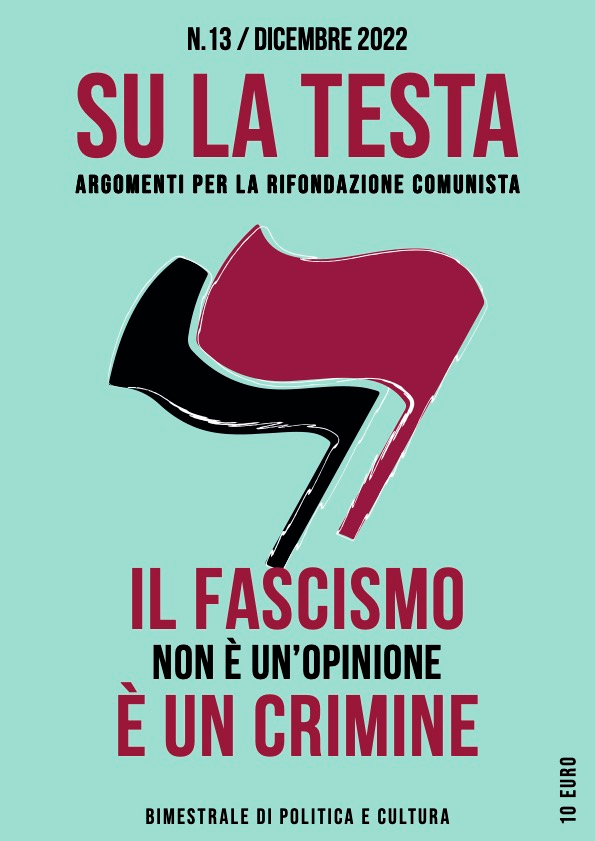
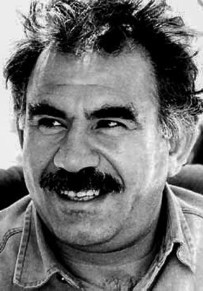





Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!