Scenari globali. Intervista a Raffaele Sciortino
Per l’edizione inglese, in uscita in questi giorni, ha scritto un capitolo di aggiornamento che tiene conto degli sviluppi nel frattempo intervenuti.
Gli abbiamo rivolto alcune domande che cercano di cogliere i dati essenziali del mutamento di quadro, a partire ovviamente dal conflitto Russo-Ucraino e dalla situazione in Medio Oriente.
Collegamenti:
Dopo due anni di conflitto l’Occidente collettivo sembra avviato ad un serio scacco in Ucraina, per quanto gli obiettivi che perseguiva l’Amministrazione Biden siano nel complesso raggiunti: logoramento della Russia, compattamento della Nato, subordinazione dell’Europa, postura minacciosa verso la Cina. Possiamo aspettarci una svolta da qui alle elezioni Usa?

Raffaele Sciortino
Bella domanda. Direi di no se per svolta si intende qualcosa che possa assomigliare anche alla lontana a un serio percorso negoziale voluto e condotto dall’attore decisivo, Washington. Non solo: neppure un’eventuale vittoria di Trump porterebbe probabilmente a una svolta effettiva, semmai a qualche mossa politica dal valore simbolico. La mostruosa macchina statale statunitense si è oramai sintonizzata sulla modalità guerra – che è riduttivo definire per procura – in quel quadrante strategico. Del resto gli obiettivi già raggiunti dagli Stati Uniti che ricordi nella tua domanda sono eloquenti di una strategia mackinderiana di lungo periodo – l’unico elemento, forse, di una Grand Strategy complessiva che per altri versi fatica a configurarsi pienamente.
Mi pare – mi rifaccio anche alle analisi di M.K. Bhadrakumar, un esperto indiano poco conosciuto qui da noi – che a Washington si siano orientati per una strategia (militare) che punta a consolidare il fronte ucraino su linee oramai divenute difensive nel mentre si proverà a ricostruire il potenziale militare di Kiev e, questo il punto essenziale, si inizierà a colpire ben oltre le linee dell’esercito di Mosca, direttamente in territorio russo. L’obiettivo è quello di passare dalla guerra di attrito a una sorta di guerriglia anti-russa di lunga durata che ne degradi le capacità e dunque, nelle speranze occidentali, la tenuta interna – ciò che non è stato possibile finora con le sole sanzioni economiche.
La recente visita a Kiev della Nuland (la mente dietro il coup di Maidan 2014?) e la conseguente defenestrazione di Zaluzhnyj (non certo un “filorusso”) dai vertici dell’esercito ucraino testimoniano di questa che se vogliamo è la vera svolta in atto. Al momento Zelensky lo ha sostituito con una figura probabilmente di transizione. Ma per Washington l’importante è stato ribadire chi comanda a Kiev confermando la fiducia nel burattino che ha oramai bruciato dietro di sé i ponti con Mosca, e preparare così la transizione. Del resto, gli attacchi diretti contro il territorio russo sono già iniziati.

Certo, non è escluso che lo stato ucraino nel frattempo tracolli del tutto. Ma al momento, al di là dell’evidente stanchezza della popolazione e della resistenza (passiva?) alla coscrizione, non credo ci siano segnali di rottura tali da mettere in seria difficoltà gli elementi nazionalisti anti-russi. E questi sono ben disponibili a una guerra permanente contro Mosca al servizio dell’Occidente. È quanto basta a Washington, che potrà così dedicarsi con più tranquillità al quadrante dell’Asia orientale e, compito non da poco, ristrutturare la catena delle forniture militari indebolita da decenni di privatizzazioni e delocalizzazioni. Per il resto, dal punto di vista dei costi, è già in corso una europeizzazione dei costi del conflitto senza neanche il bisogno di un Trump che ricordi agli alleati che d’ora in avanti dovranno sborsare secco per la difesa “collettiva”. Su questo versante non è prevedibile alcuna mossa un minimo più “autonoma” da parte di singoli imperialismi dell’Europa occidentale, la cui subordinazione non è meramente politica, culturale e militare, ma è ancorata nel profondo degli intrecci (asimmetrici) tra i capitali finanziari e industriali delle due sponde dell’Atlantico e, insieme, dal comune interesse a sfruttare il “Resto” del mondo ovvero piegarne i soggetti ricalcitranti.
Quanto a Mosca, finora la direzione politica – forte anche del sostegno cinese – si è rivelata all’altezza a fronte del rischio di perdere la capacità di deterrenza rispetto alla Nato. Ciò non toglie che il rischio è tutt’altro che cancellato mentre, nonostante il notevole successo sul terreno, sembrano mancare la capacità e le condizioni politiche interne, almeno al momento, per una spallata decisiva che potrebbe porre termine alla guerra a condizioni favorevoli. Le prospettive, dunque, non sono così rosee anche se sarà il più ampio contesto internazionale – compreso l’intreccio con la situazione mediorientale – a dire l’ultima parola nel senso di una escalation qualitativa e di scala o meno. Nell’intervista a Tucker Carlson Putin mostra di essere consapevole di ciò.
Comunque sia, per finire su questo punto, chi si attende una situazione di congelamento della guerra tipo Corea avrà probabilmente amare sorprese. Ciò non toglie che anche per l’establishment in Occidente alcuni effetti boomerang dovuti all’inaspettata resistenza russa si stanno vedendo. E vien da dire: meno male.
Collegamenti:
La Russia si è rivelata meno fragile del previsto, anche se il tempo, la demografia, le sanzioni tecnologiche giocano contro la sua tenuta strategica, ancora troppo legata ai ricavi dalle fonti fossili di energia. La Cina non ha potuto fare altro che sostenerla, nella sostanza. Insieme Russia e Cina hanno guidato una ripresa ed un allargamento dei BRICS, proponendo una rappresentanza del Sud Globale ed un modello multipolare di governance, sul piano economico, commerciale e finanziario. Come vedi questo sforzo, in prospettiva, con le sue ricadute sulla finanza mondiale e sul ruolo del dollaro?

i BRICS (fonte:Wikipedia)
L’allargamento dei Brics deciso al vertice di Johannesburg dello scorso agosto è sicuramente un passo importante (anche se dei sei nuovi membri l’Argentina di Milei si è già sfilata). Ha confermato l’asse Pechino-Mosca e sancito il rapprochement tra Arabia Saudita e Iran, clamoroso successo della diplomazia cinese, contenendo inoltre il protagonismo indiano nei confini di un multiallineamento internazionale di Dehli. Dunque ha ripreso slancio la spinta da parte di soggetti importanti non appartenenti al blocco occidentale per una riforma dell’ordine internazionale nella direzione di un multilateralismo che dovrebbe rispecchiare l’emergente multipolarismo, o almeno quello che è percepito come tale, nonché l’evidente deterioramento della pax americana. Contestualmente, sul piano finanziario e monetario, ci sono stati passi ulteriori verso una minore dipendenza dal dollaro come mezzo di pagamento internazionale e divisa principale della liquidità globale, nonché alla luce delle sempre più frequenti sanzioni economiche occidentali. Anche se non si tratta affatto di una moneta comune, allo stato difficilmente realizzabile. Tutto ciò, va da sé, non sarebbe possibile senza il crescente peso economico e diplomatico di Pechino sulla scena internazionale.
Su un altro versante, resta la persistente eterogeneità dei paesi Brics. Non si tratta solo del fatto che non siamo di fronte a un blocco geopolitico. A monte – questo non andrebbe mai dimenticato – sta la articolata configurazione dollaro-centrica che il mercato mondiale, ovvero l’imperialismo come sistema mondiale, ha assunto dopo la crisi degli anni Settanta. Scossa ma non distrutta dalla crisi globale iniziata nel 2008. Nessuno può ad oggi fare a meno dei mercati e della finanza occidentali e del dollaro. La stessa Cina è strettamente legata a questa struttura anche se la sua crescente proiezione economica esterna le ha permesso di avviare una cauta internazionalizzazione dello yuan. Insomma, la sfida “riformista” all’Occidente continua a fare passi avanti, la vicenda ucraina e il conflitto a Gaza ne hanno evidenziato l’urgenza. Il processo è oramai innescato, e rappresenta se non altro una oggettiva spina nel fianco dell’imperialismo statunitense e occidentale; l’esito multipolarista è però tutt’altro che scontato e intimamente legato alla traiettoria di crisi dell’accumulazione mondiale e allo scontro geopolitico tra Stati Uniti e Cina.
Collegamenti:
Se la Russia è ancora una potenza militare rilevante, è evidente che la Cina rappresenta il vero competitore globale degli Usa. Sia per il peso della sua economia (in moderata espansione), sia per il ruolo geo-politico che tende ad assumere nel nuovo contesto. Gli Usa hanno avviato il reshoring, cioè la dislocazione delle produzioni strategiche verso paesi più affidabili sul piano delle alleanze. A che punto è questo progetto e con quali limiti si scontra?

Farei una premessa. Il capitalismo statunitense resta il centro del mercato mondiale, posizione che ha acquisito a seguito di due guerre mondiali. Da allora ha potuto bloccare quando non invertire il rallentamento relativo della propria accumulazione solo scaricando su altri soggetti statali i costi delle crisi e delle riprese – con diverse modalità in diversi contesti, sui paesi europei occidentali negli anni Settanta, poi sull’Unione Sovietica, sul Giappone negli anni Novanta, di nuovo sull’Europa all’indomani del 2008. È questa in fondo la funzione dell’imperialismo. Ora è la volta della Cina. Ma nel capitalismo globale odierno, effettivamente internazionalizzato come finanza e come produzione, non può non scattare la contraddizione anche per Washington tra necessità di pompare plusvalore dall’intero globo e rischi di frammentazione se non di vera e propria de-globalizzazione (da cui siamo comunque ancora lontani) stante la ridefinizione dei flussi, in particolare degli investimenti esteri, secondo linee geopolitiche.
Il decoupling di Biden si situa in questo passaggio stretto. A che punto è? Il disaccoppiamento dalla Cina procede da un lato con le misure protezionistiche sul commercio e soprattutto sui trasferimenti di tecnologia – in particolare la “guerra dei semiconduttori” che può fare molto male a Pechino -, dall’altro con il disinvestimento di capitali precedentemente esportati in Cina. Sul piano dell’interscambio commerciale il rapporto non ne ha sofferto finora molto seppur con cambiamenti significativi nella composizione. Contestualmente è andata avanti la ristrutturazione delle filiere globali ridislocate verso paesi “amici” (friendshoring: Vietnam, India, Sud-Est asiatico) o “vicini” (nearshoring: Messico, diventato nel ’23 primo partner commerciale degli Stati Uniti). Sul piano del reshoring vero e proprio con rientro di produzioni sul territorio statunitense, il quadro è più sfaccettato e incerto: la cosiddetta Bidenomics, politica industriale di forte sovvenzionamento pubblico alle imprese ad alta tecnologia (con la scontata verniciatura di green), sta avendo qualche risultato con apertura di impianti soprattutto nel settore Ict, ma al momento non molto di più. Inoltre, non solo parte delle forniture di paesi come Vietnam e Messico provengono comunque da rilocalizzazioni di imprese cinesi, ma questa strategia nell’insieme rischia di innalzare i costi produttivi. Senza contare che non potrà che acuire le tensioni economiche con l’Unione Europea (in Germania si parla già del rischio de-industrializzazione), forse con la Corea del Sud e la stessa Taiwan e, ovviamente, con Pechino.
Certo, considerando il breve periodo gli Stati Uniti sono riusciti finora a evitare la recessione (messa in conto un anno fa da quasi tutti) grazie sia agli investimenti pubblici di cui si diceva sia alle esportazioni energetiche verso l’Europa (un dividendo della guerra in Ucraina). Però non solo è da vedere se questi fattori reggeranno più a lungo, ma a livello di consumi non c’è stato vero rimbalzo causa la persistente, ancorché calante, inflazione appena compensata dagli incrementi salariali seguiti ai conflitti sindacali che si sono fin qui avuti. Di qui, anche, i bassi livelli di popolarità di Biden in vista delle presidenziali del prossimo novembre, che restano comunque aperte quanto a esito (va considerato che dietro Trump non sembra esserci la spinta ampia del 2016). Più in prospettiva, c’è semmai da riflettere se il combinato tra guerra tecnologica alla Cina (v. il successo di Chip War di Chris Miller, tra gli altri) e nuova politica industriale (ipocritamente battezzata Green New Deal per la soddisfazione di liberal e radical di sinistra) non prefiguri un nuovo tipo di economia di guerra – ben al di là dell’inevitabile incremento della spesa bellica che si darà prossimamente anche alla luce delle lacune palesate sul fronte ucraino.
Collegamenti:
Si parla insistentemente di fine del “miracolo cinese”, citando ad esempio la crisi dei colossi dell’immobiliare, il rallentamento dei tassi di crescita, la difficoltà a reggere il protezionismo tecnologico e commerciale da parte degli Usa e degli alleati di Washington. Nelle tue note, tendi a ridimensionare queste preoccupazioni, facendo rilevare piuttosto una maggiore propensione allo sviluppo intensivo ed un raffreddamento programmato, dopo gli eccessi di liquidità post-crisi globale del 2009. Come può la Cina continuare a crescere per sfidare gli Usa, se ne dipende ancora così tanto come mercato di sbocco delle sue merci e se resta integrata nel sistema economico dominato dall’egemone?
È LA questione. Che si porrebbe in maniera drammatica allorché l’economia mondiale dovesse ricadere in una recessione profonda, ma che comunque si fa avanti già adesso a fronte sia di una sostanziale stagnazione delle economie occidentali sia del crescente protezionismo tecnologico anti-cinese. Non si tratta quindi di negare le criticità dello sviluppo capitalistico cinese, gli squilibri ai vari livelli, il calo tendenziale degli investimenti privati e della produttività, lo sgonfiamento della bolla immobiliare cui sono legati i livelli alti di indebitamento delle finanze locali, e ora anche una crescita congiunturale che l’anno scorso è stata la più bassa da tre decenni (ma pur sempre sul 5%). Solo, queste criticità vanno collocate nel contesto generale. Diciamo così: dopo trent’anni e passa di partecipazione al mercato mondiale, asimmetrica (ovvero in cambio di un forte prelievo occidentale) ma foriera di sviluppo, ora questa partecipazione inizia a porre limiti sempre più stringenti e lascia intravvedere probabili passaggi di rottura. A fronte di ciò la direzione del partito-stato cinese, consapevole di quanto si approssima, non può che spingere al massimo su quei limiti per entro l’attuale configurazione dell’economia internazionale procedendo con la risalita delle catene del valore, l’unica via per recuperare una parte dei prelievi imperialisti utile per uno sviluppo più intensivo e la ristrutturazione del mercato e del welfare interni. Nel mentre a Pechino ci si tiene pronti per le possibili rotture: Xi Jinping ha recentemente accusato senza giri di parole Washington di perseguire una politica di contenimento e accerchiamento invitando così a prepararsi anche allo scenario peggiore. E non è un caso che sempre più di frequente nelle dichiarazioni ufficiali sicurezza e stabilità facciano premio sulla crescita. Nell’interregno, che a Pechino sperano il più lungo possibile, non si escludono tregue con Washington come tutto sommato negli ultimi mesi (e anche il risultato elettorale a Taiwan, non un successo per gli indipendentisti, va in questa direzione) – purché senza compromessi sull’essenziale. Tutto ciò, va da sé, configura una navigazione a dir poco complessa.

In questo quadro, allo stato attuale, la Cina deve iniziare a fare i conti con un calo notevole dei finanziamenti dall’estero (altra faccia del decoupling tecnologico) complementare al sostanziale blocco delle acquisizioni cinesi di imprese occidentali (mentre si parla sempre più di misure protezionistiche anche nei confronti dei veicoli elettrici cinesi). La proiezione verso America Latina, Africa, Medio Oriente per quanto importante non può ovviamente compensare al momento i rapporti economici con l’Occidente. Più interessante la crescente integrazione con i paesi dell’Asean, la regione più dinamica al mondo, dove Pechino è in grado oramai di competere con i paesi occidentali. Ma da seguire anche la eventuale traiettoria di paesi come la Corea del Sud, stretta tra allineamento geopolitico filo-statunitense e interessi economici che puntano a rapporti stretti con il mercato cinese.
Sul piano interno, la riduzione del rischio finanziario speculativo – vedi la bolla immobiliare – sotto una più stretta supervisione centrale è fondamentale per la strategia di ribilanciamento complessivo del modello di crescita fin qui seguito. È in corso infatti un tentativo serio, almeno nei settori di punta, verso uno sviluppo intensivo (v. appunto la scalata cinese nella produzione mondiale di veicoli elettrici) il che ha altresì incrementato la parte di valore aggiunto interno di contro a quella estera nella partecipazione alle catene globali del valore. Ma ovviamente una stretta fiscale non favorisce la ripresa economica post-covid, che probabilmente i vertici cinesi si aspettavano di maggiore portata come effetto automatico delle riaperture. Lo stesso intreccio tra bolla immobiliare e finanze locali – le amministrazioni locali si finanziano in buona misura attraverso le rendite dei terreni in concessione – si sta rivelando un boomerang che restringe i margini della spesa pubblica. Difficile varare una riforma delle entrate fiscali e quindi del sistema welfaristico, di cui pure si discute da anni, in questa situazione: chi dovrebbe pagarne i costi ora che i redditi dei ceti intermedi risultano decurtati dal calo dei prezzi delle case?
Comunque sia, fintanto che resterà in sella l’attuale dirigenza Xi, non credo cambierà la strategia fin qui seguita né si andrà a un compromesso a perdere con Washington. Il che aggiungerà scintille a un quadro mondiale già surriscaldato.
Collegamenti:
Il contenimento della Cina da parte degli Usa sembra passare, almeno da 10 anni a questa parte, cioè dal “Pivot to Asia” di Obama, dal tentativo di costituire una Nato per l’Indo-Pacifico, allargando l’alleanza AUKUS a Giappone, Corea del Sud e chi ci sta, dall’India all’Asean. La risposta cinese è stata la RCEP, perché comunque la massa dell’interscambio cinese con i paesi dell’area è un dato oggettivo e invalicabile. Cosa pensi invece della recente proiezione cinese verso il Medio Oriente, con la mediazione dell’accordo Iran-Arabia Saudita e l’approfondimento della BRI verso quell’area? E cosa può significare l’esplosione dell’instabilità in questo quadrante, con le ripercussioni sulla circolazione delle merci negli stretti marittimi? Proprio quando gli Usa hanno proposto la “via del cotone” in alternativa alla BRI?
Il nesso tra la sempre più pronunciata proiezione cinese nel Medio Oriente e la guerra in corso di Gaza non è diretto. Ma c’è, è importante e fa da sfondo all’attuale crisi. Prima del sette ottobre l’equilibrio regionale complessivo si era già spostato a seguito di alcune grosse novità. La principale è quella che richiamavi tu, il rapprochement Iran-Arabia Saudita su iniziativa cinese, cui è poi seguito il viaggio di Xi Jinping nei paesi del Consiglio del Golfo di fine ’22. Inoltre, dei sei nuovi ingressi Brics di cui si diceva prima quattro sono paesi mediorientali. Si aggiungono ora le recentissime visite del presidente iraniano nella capitale saudita e di Erdogan in Egitto: due bombe diplomatiche se pensiamo anche solo a qualche anno fa.

In effetti, i maggiori investimenti cinesi degli ultimi anni nel quadro delle Nuove Vie della Seta si sono avuti proprio in Medio Oriente. La Cina può ora fare da sponda economica in particolare, appunto, per la costruzione di infrastrutture – su questo al momento non c’è confronto con l’Occidente, i cui piani sono prevalentemente legati a una costosa raccolta di capitali sui mercati finanziari (questo vale anche per il fumoso “Partenariato Globale per le Infrastrutture e gli Investimenti” ovvero il corridoio India-Medio Oriente-Europa). In più, la proiezione cinese non si configura come politicamente intrusiva e, altrettanto importante, è potenzialmente fonte di stabilità geopolitica in una regione i cui principali stati nutrono progetti di rilancio economico oltre la mera rendita petrolifera e/o la dipendenza da mercati e capitali occidentali. Cosa rivelatasi impossibile sia nell’era del bipolarismo – mancando l’Unione Sovietica dei fondamentali economici – sia nella fase neoliberista di strapotere della finanza statunitense e delle sue “guerre umanitarie”. Al contrario, è sempre più evidente per contrasto che le politiche occidentali sono fonte di destabilizzazione, sia per l’appoggio incondizionato a Israele sia – lo si è visto nella vicenda del fallito regime change in Siria, in Iraq prima e da decenni in Iran – per le ininterrotte manovre contro gli stati “scomodi”.

In merito alla guerra a Gaza ci sarebbero moltissime cose da dire, a partire dall’importanza di una prima messa in discussione della deterrenza israeliana dall’interno del territorio e ad opera di forze nazionali palestinesi – il che spiega la reazione letteralmente rabbiosa dello stato ebraico. La pulizia etnica, che è il suo obiettivo strategico, non gli sta però riuscendo perché abbisognerebbe della resa del popolo palestinese e comunque di una aperta guerra regionale, per la quale a Washington non ci si sente ancora pronti. Inoltre, sono importantissimi i primi passi – a livello di compagini statali ma specchio di sommovimenti profondi tra le popolazioni della regione – di un superamento della frattura sciiti/sunniti e all’interno degli stessi sunniti (le manovre imperialiste occidentali tramite Isis o kurdi hanno così sempre meno presa). Infine, le significative reazioni in Occidente- non mi riferisco a quelle ufficiali, tra l’ipocrita e il preoccupato – riflettono, nel subconscio di massa, la paura che se l’Occidente vuole continuare a “guidare” il mondo la guerra diventa sempre più uno strumento indispensabile (non difendiamo forse i “valori occidentali” in Ucraina?!). E, allora, il dubbio che inizia a insinuarsi è che gli ebrei israeliani stiano agendo oggi nella maniera più brutale quello che noi tutti fra un po’ dovremo fare.
Insomma, fatto salvo il ricorso alla soluzione militare allargata – non di semplice realizzazione a meno di sorprese – l’equilibrio delle forze in Medio Oriente inizia a volgere a sfavore di Washington e Tel Aviv dopo che con gli Accordi di Abramo Israele pensava di aver cancellato o almeno reso invisibile anche per il mondo arabo la questione palestinese. La pax americana si rivela oltremodo precaria. Non è poco. Il che non toglie che lungo le Vie della Seta vadano addensandosi sempre più focolai di caos geopolitico indotto, direttamente o indirettamente, dall’Occidente. Pechino è avvisata.
Collegamenti:
Torniamo ora verso i nostri lidi. Il modo in cui si è usciti dalla pandemia e lo scoppio della guerra ci hanno riportato l’inflazione: nella tua lettura, potrebbe trattarsi di un evento non episodico, bensì radicato nella nuova struttura dei costi e legato alla quota di valore, in prospettiva sempre maggiore, trattenuta dalla “fabbrica del mondo”. Per l’Occidente collettivo, e per l’Europa in particolare, si tratta di ragionare in termini nuovi. Non c’è ancora rincorsa prezzi-salari e, di conseguenza, si aggrava l’impoverimento della classe dei proletari e l’ indebolimento del ceto medio. Può saltare il compromesso sociale post-fordista, come ipotizzi nella tua analisi? Chi e come potrebbe dare rappresentanza a questo malessere sociale, nella crisi delle organizzazioni del movimento operaio? Quali forme di conflitto potranno essere messe in campo per resistere all’arretramento?
Non saprei bene come rispondere nello spazio di un’intervista, e forse non solo per questo motivo. Ma una precisazione a questo punto è doverosa. Negli scenari che si sono aperti non si tratta di essere “filocinesi” o “filorussi”: il punto è che se l’Occidente e in particolare gli Stati Uniti, ovvero gli anelli forti della catena imperialista, non incontreranno serie difficoltà economiche e resistenze sul piano geopolitico non solo non vi potrà ripartire alcun significativo conflitto di classe ma non si daranno le condizioni per riaprire, le due cose non sono separate, una prospettiva antagonista al capitalismo.
Detto questo, credo che sia solo possibile accennare ad alcune coordinate di fondo dell’attuale situazione. Pur nel quadro della montante aggressivizzazione di Washington nei confronti di Cina e Russia (ma non solo: l’economia statunitense cresce di quanto, anche, toglie a quella europea) non mi pare si sia già alla vigilia di una svolta drastica, ovvero di una ristrutturazione capitalistica radicale sulla falsariga di quella varata dagli Stati Uniti per uscire dalla crisi degli anni Settanta. Di qui una sostanziale stagnazione prolungata delle economie occidentali senza che la Cina, a questo tornante, possa e voglia contribuire a rilanciare l’economia mondiale come è stato dopo il 2008. A farne le spese in prima battuta è e sarà proprio l’Europa, con la “bolla” tedesca che potrebbe anche scoppiare in un futuro non troppo lontano. Del resto, anche sul piano politico, la divaricazione tra i principali stati europei, in primis tra Berlino e Parigi, è sotto gli occhi di tutti, l’ascesa delle forze conservatrici ne è l’effetto più che la causa.

Siamo dunque ancora in una sorta di impasse. E questo incide sulla lotta di classe, o sulla sua latitanza. Limitandoci al quadrante occidentale, questa situazione si rispecchia anche nelle reazioni fin qui diversificate sul piano del recupero salariale dell’inflazione. Mentre negli Usa e, con minori risultati, in Gran Bretagna si sono dati conflitti lavorativi, e in Germania Francia e Spagna hanno funzionato in parte gli ammortizzatori statali (ma la musica, dicevamo, sta cambiando), in Italia le classi lavoratrici sono rimaste decisamente scoperte dall’ascesa dei prezzi né hanno accennato a reazioni significative (se non a un consenso di opinione intorno alla proposta di salario minimo, peraltro lasciata subito cadere dalle “opposizioni” e di fatto ignorata dai sindacati ufficiali). Contestualmente è andata sgonfiandosi la mobilitazione green dei giovani, impulsata qualche anno fa dall’alto in funzione anti-“populista” ancorché su un terreno di criticità reale. Nè è decollata alcuna effettiva mobilitazione di massa contro le guerre in corso; anche se è emersa una certa sensibilità verso il massacro dei palestinesi (ma prevalentemente come vittime). Cosa rimane? All’immediato poco. Anche se la mobilitazione degli imprenditori e dei lavoratori autonomi del settore agricolo, a scala europea ma senza reali convergenze, e favorita dall’appuntamento elettorale di giugno, dice dei margini che vanno chiudendosi anche per i ceti medi (in questo caso produttivi) da sempre coccolati dai governi.

In termini generali scontiamo così la distanza, quando non divaricazione, tra il messaggio “riformista” per un diverso ordine internazionale, geopolitico ed economico, che proviene dal cosiddetto Sud Globale, da un lato, e l’eclisse del riformismo sindacale e politico, della “sinistra”, in Occidente. Non credo si tratti di qualcosa di contingente. Se qualcosa tornerà a muoversi sul fronte del lavoro salariato, va messo in conto che qui non abbiamo davanti a noi una possibile ripresa del “movimento operaio” in simbiosi con la “sinistra” politica. Quella fase è tramontata, il cosiddetto momento populista l’ha segnalato. Al tempo stesso, le prospettive del conflitto sociale saranno sempre più direttamente intrecciate con le vicende geopolitiche mondiali, con l’evoluzione delle istanze che provengo da “fuori” e dunque anche con la tendenza alla guerra scaturente dall’interno delle nostre società. Ma in che modo, con quali passaggi e possibilità di evoluzione potrà darsi un neo-riformismo nei paesi occidentali è al momento ancora una domanda senza sufficienti riscontri reali.
Posted in Internazionale, recensioni.
Tagged with BRICS, Guerra in Ucraina, imperialismo, Palestina, Raffaele Sciortino, USA e Cina.
By iniziativa – 1 Marzo 2024
Dal n. 6 di “Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe” in uscita nei prossimi giorni pubblichiamo in anteprima questa intervista a Raffaele Sciortino a cura di Renato Strumia.


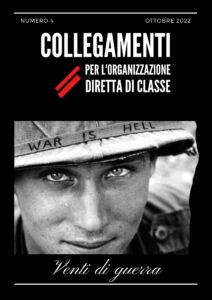








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!