Se sei giorni vi sembran pochi
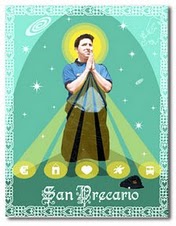
Negli ultimi mesi si è discusso vivacemente, sebbene a singhiozzo, della proposta del Governo di limitare più o meno drasticamente la possibilità di apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, incluse le domeniche. L’argomento è stato ripreso di recente per l’approssimarsi della possibile approvazione del progetto di legge. Ne è nato un interessante dibattito dominato da reazioni scomposte da parte degli alfieri del neoliberismo a oltranza, ultime delle quali la sparata a sfondo razzista dell’ineffabile sindaco piddino Sala e la netta presa di posizione del Presidente della Regione Liguria Toti.
Vediamo quali sono i termini di fondo della questione.
La liberalizzazione dei mercati, dall’ultimo decennio del secolo scorso, è divenuta un mantra ripetuto ossessivamente da economisti e politici di turno come la panacea di ogni male, la liberazione da quelle rigidità e compressioni della libertà imprenditoriale che, secondo il dogma neoliberale, avrebbero funestato i sistemi a economia mista nel trentennio post-bellico. La limitazione della libera concorrenza, in un contesto dirigista di stretta regolamentazione dei mercati era, assieme alla forte presenza dello Stato imprenditore, un pilastro essenziale del funzionamento delle politiche industriali fino ai tempi della controrivoluzione liberista.
Negli anni ’90, sotto la spinta della dottrina europea sulla concorrenza, è stato avviato un ciclo continuo di controriforme nei rapporti tra Stato e mercato che ha via via demolito quanto restava di quel dirigismo pianificatore. Mentre da un lato si disintegravano i monopoli pubblici aprendo ai privati settori prima gestiti in esclusiva da imprese statali, allo stesso tempo nell’ambito dei mercati già privati si procedeva ad un’estesa liberalizzazione e deregolamentazione, ovvero una rimozione o allentamento di quelle restrizioni che costituivano l’ossatura dei mercati regolamentati: limiti territoriali all’apertura di esercizi commerciali, divieti di cumulo di licenze, prezzi minimi e prezzi massimi su beni e servizi, limiti al ventaglio merceologico di beni o servizi vendibili, limiti alle aperture nei giorni festivi.
L’apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi è parte integrante di questa strategia. Il primo intervento risale al 1998 (Decreto Bersani) con la previsione di possibilità di apertura le domeniche limitata ad alcune tipologie di esercizi commerciali. Successivi interventi (2003 e 2006) hanno esteso la liberalizzazione sino ad arrivare al decreto Monti in vigore dal 2012 che completava il processo consentendo piena libertà di apertura a qualsivoglia tipo di esercizio commerciale nelle domeniche e nei giorni festivi, nonché una piena liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura.
La visione ottimistica della liberalizzazione ci presenta un quadro apparentemente idilliaco. Dal punto di vista dei consumatori, la possibilità di fare acquisti nei giorni festivi o ad orari tardivi o persino notturni può apparire come un’agevolazione migliorativa del proprio quotidiano. Dal punto di vista dei lavoratori dipendenti del settore commercio, il lavoro festivo viene presentato come un’opportunità. Da contratto nazionale di categoria, infatti, dovrebbero usufruire di una maggiorazione del 30% delle paghe e in ogni caso vi è la garanzia settimanale di un altro giorno di riposo. Dal punto di vista degli esercenti, visti nel loro insieme, si rimarca la possibilità di accrescere i propri profitti intercettando un maggior numero di consumatori. Ed infine dal punto di vista macroeconomico si enfatizza la possibile crescita dei consumi e dunque del prodotto nazionale.
Spesso il diavolo si nasconde nei dettagli, ma questa volta si cela nella logica generale del discorso. Ci sono infatti numerose ragioni per rifiutare fermamente l’apparente ovvietà per cui è a priori buono ciò che sembra semplicemente estendere la libertà di tutti.
L’esistenza di tempi di riposo universali, comuni a tutti o a quasi tutti è, da che mondo è mondo, un carattere permanente della socialità umana, che va ben oltre il nobile significato religioso o civile delle feste celebrate. Significa potersi ricreare in compagnia delle persone a cui si vuole bene, condividere un tempo di distacco dall’attività lavorativa, e infine percepire attorno a sé la sacralità del riposo nel riposo generale della collettività.
Violare questa sacralità del riposo condiviso è naturalmente possibile, ma lo deve essere per validi motivi. E’ evidente che vi sono alcune attività che per forze di cose non possono conoscere interruzioni (servizi medici, trasporti) oppure sono particolarmente legate proprio al giorno di festa (ristorazione in località turistica). Ma parliamo dell’eccezione e non della regola. E’ innegabile oggi che i singoli individui possano valutare positivamente la libertà di fare acquisti nel tempo libero loro concesso nei duri ritmi di vita lavorativa, percependo lo shopping festivo sempre più come un’esigenza; tuttavia questa libertà si traduce nella costrizione per milioni di altre persone a lavorare in giorni di riposo universali riducendo così il proprio tempo di libertà condivisibile. Ed allora, ciò che va messa in questione è la radice di quella esigenza che diventa tale solo nella misura in cui gli orari di lavoro medi di oggi sono sfiancanti, lasciano tempi liberi irrisori, in un’epoca in cui il progresso tecnologico, al contrario, permetterebbe di ridurli rispetto a soli pochi anni fa. Non dunque la libertà di fare la spesa alle undici di sera, la domenica, il 1 Maggio o il giorno di Natale andrebbe rivendicata, quanto piuttosto la libertà di avere tempo per gli acquisti ad un orario decente di un qualsiasi pomeriggio feriale, ovvero una riduzione significativa degli orari di lavoro a parità di salario.
Si afferma, a difesa dello status quo sancito dal decreto Monti, che i lavoratori del commercio percepiscono una paga maggiorata del 30% a fronte di una giornata festiva lavorata. Si sta così però monetizzando un diritto e una convenzione sociale secolare. Come se fosse questa la via per aumentare salari da fame, che invece dovrebbero crescere senza diritti concessi come merce di scambio. Senza dimenticare, peraltro, che in altri tipi di contratti, la maggiorazione dei festivi, usati in modo molto più sporadico rispetto al commercio, è pari a percentuali ben più alte: 50% nel settore tessile e nel settore chimico, nell’autotrasporto, nel metalmeccanico o il 60% nell’editoria.
La normalizzazione della Domenica, peraltro, emerge in modo persino più intenso anche in altri tipi di contratti diversi dal commercio nei quali la maggiorazione della paga domenicale può scendere addirittura fino al 20% (settore turistico) o al 10% (settore alimentare).
Si afferma, infine, invocando un effetto macroeconomico positivo, che i consumi crescono grazie alla maggiore flessibilità di tempi per l’acquisto da parte degli acquirenti. I dati del dopo decreto Monti sembrano smentire questa supposizione tenuto conto che gli acquisti al dettaglio dal 2012 al 2014 hanno subito al contrario una flessione, sicuramente dovuta alla crisi, ma che di certo le aperture domenicali non hanno potuto frenare in alcun modo. Sembra assai più ragionevole credere che, in tempi di domanda stagnante, a parità di consumi totali, via sia una redistribuzione degli acquisti dai giorni feriali ai giorni festivi e quindi, eventualmente, da esercizi commerciali chiusi la domenica o negli altri giorni festivi ad altri esercizi commerciali che restano aperti.
Se è così, sembra davvero strano sentir parlare di rischio di danno economico consistente a carico dei produttori con gravi conseguenze sull’occupazione, nel caso di un decreto che ristabilisca limiti alle aperture nei festivi, e addirittura di danni generati preventivamente dal solo annuncio del provvedimento. Piuttosto è assai probabile che la grande distribuzione, che ha conosciuto un processo di fortissima concentrazione oligopolistica negli ultimi anni e i cui volumi di profitti sono cresciuti in modo esponenziale, tema di dover cedere qualche briciola alla concorrenza sempre più debole della piccola distribuzione. E’ infatti evidente che la liberalizzazione di orari e giorni di apertura ha avvantaggiato le grande catene commerciali a discapito del negozio di quartiere a conduzione familiare. Quest’ultimo infatti tende a rispettare i tempi di riposo universali dato che i proprietari sono le stesse persone che prestano il proprio lavoro. Al crescere della dimensione dell’esercente, con l’impiego di manodopera dipendente si inverte invece il comportamento e aumentano le possibilità economiche di sfruttare orari e giorni in cui tradizionalmente i piccoli esercizi commerciali chiudono. La liberalizzazione di orari e giorni di apertura è stata così una delle numerose fasi di ridefinizione dei rapporti di forza tra capitali a vantaggio di un progressivo processo di accentramento che nel settore della distribuzione ha visto la chiusura di migliaia di piccole attività e negozi di quartiere a favore di supermercati e grandi catene, spesso sconvolgendo il tessuto sociale, culturale e urbano di intere aree.
La posta in gioco dunque è articolata.
Le associazioni padronali della grande distribuzione attaccano la proposta di legge del Governo definendola illiberale, timorosi di perdere quote di un mercato milionario a forte concentrazione; piccoli commercianti e sindacati dei lavoratori dipendenti per motivi diversi accolgono positivamente il possibile provvedimento.
Senza dubbio vi è in ballo un dibattito che va molto al di là delle intenzioni meschine e parziali della compagine governativa del tutto estranea a qualsiasi intenzione trasformatrice e, nel suo insieme, pienamente integrata nella visione liberista dell’economia. Tale dibattito investe indirettamente due diverse visioni del rapporto tra Stato e mercato. Da un lato, la preminenza dell’illimitata estensione della libertà imprenditoriale non solo rispetto ai diritti dei lavoratori, ma anche al cospetto di abitudini, tradizioni e modi di vita. Dall’altro, l’idea di porre un qualche tipo di freno alla libertà imprenditoriale nel rispetto dei tempi di vita e dei diritti di chi lavora, attraverso una regolamentazione della produzione. Una regolamentazione che oltre ad imporre norme a difesa del lavoro e orari, possa fissare limiti alle tipologie di prodotti/servizi offerti, tutelare le specificità del territorio, salvaguardare le sue vocazioni produttive. Solo in questo modo la produzione verrebbe parzialmente allontanata dall’anarchia di un libero mercato capace di produrre soltanto concentrazione oligopolistica e sfruttamento del lavoro.
Indipendentemente dalla grottesca parzialità di vedute e contraddittorietà con cui il Governo in carica propone alcuni provvedimenti come quello qui discusso, va auspicata una sua finalizzazione come un passo, timido, ma rilevante, verso un ridimensionamento della pura logica del profitto a favore di un progressivo ritorno del mercato sotto l’egida di un processo di direzione e pianificazione pubblica.
Coniare Rivolta – Collettivo di economisti
16/11/2018 https://coniarerivolta.org

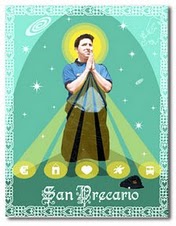







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!