Storia orale di una mediatrice culturale
Inserto a cura di Marco Gabbas
https://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-gennaio-2024/
https://www.lavoroesalute.org/
Introduzione
Dato che la storia orale è nata per dare voce a chi non ha voce (o meglio, a chi non poteva scrivere la propria storia), niente di strano che i migranti siano stati uno dei gruppi che più sono stati studiati con lo strumento della storia orale, in tanti paesi. Limitandoci all’Italia, Marco Buttino ha recentemente pubblicato un libro sui migranti di Saluzzo, Vite provvisorie, che si avvale anche dello strumento della storia orale [1]. Ma già nel 2006 Emilio Quadrelli aveva pubblicato uno stimolante e inquietante libro, Evasioni e rivolte, che sempre con lo strumento dell’intervista orale indagava la questione delle rivolte e delle evasioni dai Cpt (oggi Cpr) [2]. Quando si parla di migrazioni si parla certamente di culture che si incontrano e talvolta si scontrano. Questi incontri-scontri sono inevitabili, sono sempre esistiti nella storia e sempre esisteranno, con buona pace degli odierni dietrologi paranoici che temono lo spettro della sostituzione etnica.
Eppure, si parla forse troppo poco di quelle figure professionali il cui mestiere è proprio quello di facilitare, tra mille difficoltà, l’incontro fra culture diverse: si tratta delle mediatrici e dei mediatori culturali. Benché esistano degli studi sulla mediazione culturale, che di fatto esiste in Italia da alcuni decenni, non risulta che si sia mai provato a studiare questa figura professionale attraverso lo strumento della storia orale [3]. In questo contributo, voglio appunto proporre la storia orale di una mediatrice culturale italiana che opera da diversi anni in una cittadina del Sud Italia. La presentazione di una storia così piccola e addirittura individuale è in realtà compatibile con la storia orale, che è molto soggettiva e che spesso non permette di raccogliere numerose interviste sullo stesso tema (soprattutto se il ricercatore è indipendente e fa storia orale per passione e militanza, senza essere finanziato da nessuno). Naturalmente, delle storie individuali o micro-storie, per quanto esemplari, possono acquisire un significato maggiore se messe in un contesto più ampio, paragonandole con studi analoghi già esistenti, ecc. [4]. Inoltre, possono essere da stimolo per ricerche di più ampio respiro sullo stesso tema.
Dalle case popolari alla scuola divisa
Per capire perché Barbara abbia deciso di fare la mediatrice culturale, è interessante accennare al contesto in cui è nata e in cui ha passato l’infanzia. Barbara è nata nel 1984 in una piccola cittadina, e dei suoi primi anni di vita racconta:
Quando sono nata purtroppo la mia famiglia non era in buone condizioni. Nel senso che mio padre aveva un lavoro come muratore e mia madre lavorava come bidella, però ancora non era di ruolo, eccetera, quindi viaggiava moltissimo. Infatti, io i primi due anni di vita sono stata affidata di fatto alla mia madrinache abitava in un paese del circondario. Infatti, Barbara è stata «allattata dalla famosa mamma di quartiere»,
dato che non poteva stare con i suoi genitori.
Ho due sorelle più grandi, e abbiamo sempre vissuto in casa con mia nonna, quindi in casa siamo sempre stati sei. Parliamo di case, sempre case popolari. La prima casa in cui sono stata.
la chiamavano la casa degli sfrattati, perché appunto i miei genitori erano stati sfrattatidai padroni di casa ed eravamo in quattro in una stanza, più i miei genitori che ovviamente stavano nella loro stanza da soli. Barbara ricorda che la casa popolare in cui abitava era «una palazzina che dava su un […] cortile gigante». Nonostante questo, però, Barbara dice di aver avuto «un’infanzia molto felice. Ho sempre giocato con i bambini del mio quartiere e ho avuto tra l’altro questa inclinazione a stare con i bambini che poi… con cui nessuno voleva mai stare. Infatti, mi prendevano in giro, mi dicevano che a me piacevano i bambini poveri». Curiosamente, sembra che già da quando era molto piccola Barbara non amasse le divisioni. Benché lei fosse nata in un contesto di case popolari, sembra comunque che ci fossero dei bambini considerati troppo poveri con i quali lei e altri bambini non avrebbero dovuto giocare:
Perché addirittura anche tra case popolari ci sono case popolari dove ci sono quelli che stanno un po’ meglio, e ci sono quelli che stanno un po’ peggio […] Allora se non li potevo portare da me, cercavo di dedicare metà del pomeriggio ai miei amichetti, però metà del pomeriggio andare a giocare anche con quegli altri. Uno dei complessi di case popolari nei quali Barbara ha abitato (ne cambiò due a causa di un trasloco dei genitori) esiste ancora, ed è poi anche la casa dove vivono tutt’oggi i genitori di Barbara.
Barbara ricorda ironicamente come altri abitanti della città considerassero la zona periferica dove lei abitava: «Vi dicevano sempre: non andate lì che ci sono gli zingari che vi rubano!». Non è chiaro se gli «zingari» fossero effettivamente delle persone rom che abitavano lì, o se venivano così chiamati gli abitanti del quartiere in generale. Barbara ricorda anche che per raggiungere
il centro della città doveva passare sotto due ponti, o meglio sottopassaggi o cavalcavia, i quali sono stati oggi abbelliti da «dei disegni molto carini» fatti dai writers. In un certo senso, questi cavalcavia suggeriscono l’idea del confine fra una parte della città e un’altra, tra quella in qui vivono persone più fortunate e quella periferica e delle case popolari dove è meglio che i bambini non si avventurino per non essere rapiti dagli zingari [5]. Come vedremo, il concetto di confine avrà una grande importanza nella vita di Barbara.
Barbara ha un ricordo molto nitido dei suoi studi elementari che sono stati caratterizzati da una sorta di divisione molto chiara ed esplicita, e che infatti le è rimasta impressa. Lei ha fatto la scuola elementare
in un tempo in cui i maestri dividevano i gruppi, dividevano le classi in gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Il gruppo C era costituito dai bambini più mascalzoni, quelli che non studiavano. Ma guarda caso la divisione in gruppi corrispondeva alla divisione in classi sociali. Perché nel terzo gruppo c’erano i bambini poveri, nel secondo gruppo c’erano i bambini medio-borghesi.Nel primo gruppo, invece, «c’erano i figli di dottori, ingegneri, avvocati eccetera».
E quindi questa cosa ricordo che mi traumatizzò molto, perché io arrivai ed ero nel terzo gruppo, ed ero felicissima, perché figurati, ero con quelli del mio vicinato […] E poi però ero brava, quindi mi spostarono al secondo gruppo. E mi ricordo che ero arrabbiatissima per questa cosa. Perché eravamo divisi così e io volevo stare con i miei amici e non capivo perché i miei amici facesserola ricreazione diversa. Barbara precisa come funzionava questa divisione che lei considera «terribile» e assurda. Le maestre avevano deciso di dividere i gruppi classe in sottogruppi, «per facilità», cioè per dividere i programmi:
con quelli del terzo gruppo facevano, che so, le basi delle addizioni e sottrazioni, al secondo si
facevano cose più complesse, e al primo ancora di più. Di fatto chi andava veramente avanti erano i bambini ricchi. Quelli medi rimanevano medi e quelli poveri rimanevano scemi. Questa era la situazione. Anche perché questi tre gruppi sembrava fossero inespugnabili. Nessuno era mai passato da un gruppo all’altro. Solo io sono riuscita a un certo punto, ma perché ero veramente secchiona a livelli incredibili – e non potevano più chiudere gli occhi – a passare al primo gruppo. Che era il posto ovviamente dove mi trovavo peggio. Anche se era ancora una bambina, non solo Barbara non si rivelò contenta di vedere riconosciuto il suo impegno e la sua intelligenza, che in un certo senso fu anche una sorta di scalata sociale, ma le mancavano le persone con le quali era abituata a stare, le altre persone del suo quartiere che vedeva tutti i giorni: «Addirittura, quelli del terzo gruppo facevano la ricreazione in un orario diverso. Perché dicevano che erano delinquenti e quindi non dovevano stare» con gli altri.
Alle medie invece Barbara non ricorda particolari episodi di questo tipo. Un’esperienza davvero molto formativa per la vita di Barbara, invece, furono i suoi studi superiori: «Io scelsi il Liceo delle scienze sociali, che era in quell’anno, e quindi ti sto parlando, oddio, non ne ho la più pallida idea! Avevo quattordici anni, quindi nel ‘98. In quell’anno c’era un liceo sperimentale, che si stava provando in due sole città d’Italia». Per l’esattezza, il corso fatto da Barbara era ospitato all’interno del locale istituto magistrale.
Per l’appunto, le materie di studio
erano soprattutto le scienze sociali. Facevo antropologia, etologia, sociologia, psicologia. È stato […] molto, molto bello. E in realtà inizialmente l’avevo scelto perché […] attratta dalle materie umanistiche, ma perché non c’era il latino. Perché ovviamente a quattordici’anni ti basi su certe cose. Con il senno di poi sono molto felice. Perché ho scoperto delle materie che non mi sarei sognata di studiare al liceo.
E soprattutto ho avuto docenti, quello di sociologia e quella di letteratura soprattutto, che sono stati più maestri di vita che altro. In particolare, pare che la professoressa di letteratura di Barbara proponesse un vero e proprio programma alternativo, diverso da quello
normale. Ci fece studiare – lei era molto appassionata all’argomento del carcere – e quindi ci fece studiare Foucault, ci fece studiare Beccaria. E quindi questa è stata forse l’esperienza più bella per me, del liceo. Cioè, non stare su Manzoni, i sonetti e queste cose qui. Ma appassionarsi a un argomento davvero […] Facevamo anche le altre cose, però questi erano gli argomenti principali che ci faceva trattare, e collegarli. E quindi sì, sono molto contenta di questa scelta. E poi la sociologia sicuramente mi aperto un sacco […] di finestrelle. Mi ha anche un po’ aiutato a scegliere, no? Quella che è stata l’università.La cosa che colpisce è sicuramente il carattere innovativo di questo corso di scuola superiore, con materie che in effetti si scoprono solitamente all’università e in facoltà specifiche, per non parlare di un autore come Foucault. La professoressa di letteratura di Barbara, inoltre, era alternativa anche nel fatto che «rigorosamente si faceva chiamare per nome», Martina, tant’è che Barbara non ne ricorda il cognome.
Barbara è stata particolarmente fortunata a poter frequentare questo tipo di corso superiore, anche perché ha «poi […] saputo che l’esperimento purtroppo […] non è proseguito. Li hanno accorpati a […] scienze umane, però non c’entrava assolutamente nulla. L’esperimento era volto probabilmente […] a far sì che gli studenti potessero poi accedere […] a università più diversificate». Oltre a determinare in un certo senso la scelta di Barbara per gli studi universitari, come vedremo, la scuola fatta da Barbara l’ha anche aiutata al loro interno: «Io infatti sono partita avvantaggiata all’università. Cioè, sono arrivata all’università che ero l’unica che sapesse almeno cosa fosse la sociologia. I miei colleghi, tabula rasa totale».
Studentessa ribelle
Barbara precisa anche che dopo le difficoltà iniziali la situazione della sua famiglia era fortunatamente migliorata: «Poi mia madre ha avuto un lavoro statale, quindi questo ha permesso a tutte e tre le […] sorelle […] “anche a me” di studiare, e non ci è mai mancato assolutamente niente. Quindi da questo punto di vista mi ritengo molto, molto, molto fortunata». Nonostante questo, quando ha poi deciso di iscriversi all’università, Barbara ha preferito farlo nel capoluogo di regione, anziché andare in qualche università del Nord come fanno molti altri giovani meridionali. La sua decisione era dettata dal fatto che non voleva «pesare più di tanto sulla famiglia […] Sapevo che magari sarebbe stato difficile cercare un lavoro mentre studiavo […] Ho sempre cercato di fare scelte nella mia vita che non pesassero troppo». Certamente, lo studiare in una città lontana sarebbe costato molto di più.
All’università, Barbara decise di studiare Scienze sociali per lo sviluppo. In realtà, l’università è stata per Barbara «una grande delusione […] L’avevo idealizzata, probabilmente […] Mi aspettavo di trovare la versione 2.0 dei miei mentori del liceo, no? Persone che davvero con te vogliono parlare, che tengono alla tua crescita professionale». In particolare, Barbara aveva presentato alla triennale una tesi che lei definisce «molto provocatoria», nella quale cercava di rivedere radicalmente il concetto di sviluppo. Secondo Barbara, lo sviluppo non è necessariamente portato da multinazionali e grandi ONG internazionali, che rischiano invece di perpetrare un vizioso meccanismo di dipendenza. Durante la discussione, Barbara fu «duramente criticata» da una commissaria che le disse:
«Lei non può assolutamente venire qui e dire che le multinazionali sfruttano il lavoro minorile […] e che sono tutti cattivi». A parte sottolineare la presenza della bibliografia, Barbara insistette sulla necessità di «de-svilupparci». Comunque, la discussione durò 40 anzi che 10 minuti, nella quale Barbara fu tra l’altro accusata di buttar «via anni di storia della cultura occidentale»
La scena si ripeté simile alla laurea specialistica, nella quale Barbara portò una tesi su un caso specifico, quello del Kenya, in cui delle pompe d’acqua date dall’FMI a dei villaggi risultarono inservibili dopo dieci anni a causa della mancata manutenzione. Reazione della commissione: «Quindi lei sta criticando tutto quello che le abbiamo fatto studiare in questi anni?». Risposta di Barbara: «Sì, la cooperazione allo sviluppo come è pensata oggi non serve. Anzi, serve solo a far girare soldi qui […] in Europa […] quello che ci state insegnando è entrare a far parte di queste grandi organizzazioni non governative che non» hanno
mai risolto neanche un problema. Non abbiamo prove effettive di azioni di grandi organizzazioni non governative o governative che abbiamo veramente inciso, se non momentaneamente,sulla situazione di un paese. Perché non ci interessa che le situazioni vengano risolte davvero. E purtroppo il mondo della cooperazione quasi quasi è più sporco di quello della politica.Mediare
Anche a causa della sua opinione in materia, dopo la laurea specialistica Barbara non è entrata nel mondo della cooperazione, preferendo fare un corso di qualifica in mediazione interculturale, della durata di sei mesi, offerto dalla regione. Per l’esattezza, Barbara ha ottenuto la qualifica di
facilitatore dell’accesso ai servizi e all’attività di mediazione. Cioè, la mia figura lavora insieme al mediatore culturale barra linguistico per creare un team che aiuti la persona immigrata a tutto tondo. Quindi […] sia con la lingua, che con i documenti, che con l’ospedale, la ricerca della casa, la ricerca del lavoro. E quindi tutti gli aspetti della vita.Barbara precisa che nei suoi corsi di laurea non si parlò di mediazione, ma che lei preferì questa strada anche a causa della «delusione di non voler lavorare nella cooperazione allo sviluppo […] Non è che non volessi fare cooperazione, non la volevo fare in quel modo. E quindi ho pensato, forse potrei essere più utile lavorando qui, stando in loco», con «le mie competenze, per far star bene le persone che vengono qui. Aiutarle anche a […] scambiare qualcosa […] in piccolo», senza «chissà quali grandi progetti […] chissà quali soldi». Naturalmente, in una piccola comunità non si può fare tanto, ma Barbara è comunque contenta di un progetto con il quale si sono aiutati centinaia di ragazzi. Si è trattato di una casa in cui degli immigrati venivano ospitati
per un periodo […] senza troppe preoccupazioni di bollette o che, per potersi […] dedicare a studiare l’italiano, far un corso di formazione per un lavoro e cose così. Ed è questo che a me interessa. È il piccolo, è l’aiutare anche solo la singola persona. Non mi interessa fare un progetto di tre milioni di dollari nel villaggetto in Kenya. Che poi […] sto andando a trivellare per fare dei pozzi che poi non sapranno utilizzare. Non capisco quale sia il senso.Com’è nata questa esperienza? Dopo essere tornata nella città natale e dopo aver fatto un tirocinio di un mese e mezzo presso l’Ufficio immigrazione della prefettura, Barbara si rese conto guardandosi «attorno che era un periodo in cui arrivavano veramente un numero infinito» di stranieri. «Stavano aprendo i primi Cas, e i ragazzi che non volevano restare nei Cas, che si ritrovavano lì, scappavano. Scappavano, e venivano tutti» nel capoluogo di provincia, «perché i pullman li portavano nella città principale. C’è stato un periodo in cui c’erano tredici somali in giro per la città a dormire per strada, c’era il caos più totale. Quindi, ho conosciuto un po’ di persone. Ho messo insieme questo gruppo di persone, tra cui c’era» anche un avvocato, «persone degli scout […] tutti abbastanza grandi di età […] a parte me. E ci siamo detti: ci serve un posto dove ospitarli. Prima abbiamo chiesto» a una parrocchia locale che ha fornito una stanza.
Barbara precisa che i Cas (Centri di accoglienza straordinaria) «sono praticamente i luoghi dove dopo la prima identificazione vengono stazionate le persone che richiedono asilo. Quindi, in attesa della risposta della commissione stanno» in questi centri
finanziati da prefettura […] – quindi dal Ministero dell’interno, per una cifra che corrisponde a 3 euro e 50 a persona al giorno. E vengono dati in gestione a chiunque di fatto abbia un posto. Perché poi […] è successo che li hanno messi negli ex agriturismi, agriturismi magari chiusi perché erano andati in fallimento, hotel, soprattutto posti così.In seguito, Barbara fu aiutata da un prete detto «il prete rosso» (in seguito trasferito), a causa della sua partecipazione a manifestazioni di studenti e lavoratori. Questo prete «si affeziona alla nostra causa, quindi gli diciamo: “Perché non chiede a messa se c’è qualcuno, qualche famiglia che ha una casa chiusa, che al momento non utilizza, o che è vendita, che ce la può dare in comodato d’uso gratuito? Noi la sistemiamo e la utilizziamo”». Una famiglia «decise di accogliere questo appello, tra l’altro una casa esattamente a fianco» alla stanza della parrocchia.
E a darci per cinque anni in comodato d’uso gratuito la sua casa. L’abbiano arredata, l’abbiamo sistemata, e aveva sette posti letto. E lì ospitavamo i ragazzi che […] o uscivano dai Cas (poi la regola che non puoi stare più di due notti via, non potevano rientrare quindi si ritrovavano per strada), oppure altri erano di passaggio e ci dicevano: no guarda, io devo stare una settimana, poi vado in Germania. E quindi […] qualcuno è stato qualche mese, qualcuno pochi giorni. Nel giro di due anni, sono state ospitate circa 150 persone, dal 2016 al 2018. L’esperienza è stata poi continuata con un’altra casa, dato che la precedente era stata richiesta indietro prima del tempo pattuito, in «un periodo in cui c’erano le elezioni politiche». Pertanto, secondo Barbara, è probabile che ci sia «stata qualche pressione politica». È anche vero che il «prete rosso», che «era uno di quelli che ci aiutava di più», assieme a un altro, furono trasferiti dal nuovo vescovo. Di fatto, «erano gli unici due che si impegnavano davvero, perché» uno di essi «aveva aperto i dormitori che in teoria erano aperti solo ai» locali. «Invece lui li aveva aperti anche» agli stranieri ai ragazzi. «Quando non avevamo posto» nella casa, ci pensava lui. Anche l’altro prete
era sempre lì che ci portava cose, che ci veniva a trovare, che organizzava le gite, i ragazzi lo aiutavano a pulire la chiesa, era molto impegnato […] Fu una brutta coincidenza, diciamo, che vennero trasferiti tutti e due […] E infatti poi […] è subentrato un prete […] chenon ha più aperto a niente […] I dormitori non sono assolutamente disponibili […] Sì, l’idillio con i preti è finito.Quando ho chiesto a Barbara se le sia stato facile trovare lavoro come mediatrice culturale, lei ha anzi risposto: «Me lo sono dovuta assolutamente inventare il lavoro». Delle tredici persone che avevano fatto il corso di qualifica con lei, solo due continuano a fare i mediatori culturali: «Gli altri hanno gettato la spugna». Barbara invece ha avuto la fortuna di trovare una associazione che la pagava 400 euro al mese per occuparsi «di tutto: dei ragazzi, della casa, dei documenti, di accompagnarli ovunque». Poi un’altra associazione le «propose […] di aprire uno sportello di segretariato sociale […] e di mediazione culturale» sempre pagata 400 euro al mese.
Barbara è «andata avanti così per molti anni». È riuscita poi ad «arrotondare» grazie ai progetti regionali, «ma ce n’è uno ogni anno, ogni due anni. Sono veramente pochi». Per giunta, «il governo Meloni con il decreto Cutro, per il quale tra l’altro siamo stati nuovamente sgridati dall’Unione europea, ha diminuito drasticamente questo tipo di interventi, sia l’assistenza sanitaria che tutti i progetti nelle scuole o di insegnamento di lingua italiana». Barbara ha avuto con le suddette associazioni sempre dei contratti di collaborazione occasionale. Dato che Barbara aveva lavorato per una di queste associazioni per «addirittura quattro anni» ha «sempre» tentato di spingere «per avere un contratto regolare, ma dicevano che non c’erano soldi».
Ovviamente poi a un certo punto ho anche mollato la spugna perché non si può andare avanti a collaborazioni occasionali. Quando è arrivata la pandemia io era come se non avessi lavorato per quattro anni. Quindi non mi spettava nulla, disoccupazione, aiuti di nessun tipo. Quindi anche lì […] ennesima delusione anche da parte di associazioni Onlus che ti dicono: aiutiamo gli altri, aiutiamo gli altri. Si,ma prima ci […] siamo […] noi. Ci siamo anche noi, facciamo le cose, facciamo bene. Ogni anno per essere la seconda associazionedella regione, questa associazione riceveva più di 70.000 euro di contributi pubblici. Indice anche questo, secondo Barbara, di una «mala gestione nel terzo settore».
Dato che Barbara esercita la professione di mediatrice dal 2016, le ho chiesto di fare un bilancio complessivo della sua esperienza. Di fatto, secondo lei, la figura del mediatore linguistico-culturale è importante (senza dimenticarsi dei mediatori culturali e linguistici stranieri che sono importantissimi e che necessiterebbero di più corsi): «La nostra società è sempre più multiculturale, deve esserlo assolutamente. Ma non siamo assolutamente attrezzati […] Purtroppo non c’è a volontà di investire». Per esempio, adesso Barbara sta facendo mediazione in una scuola, «ma mentre alla psicologa e alla psicoterapeuta sono state date 80 ore, a me solo 20 […] Non capisco. C’è sempre questa tendenza a considerare il nostro lavoro […]: eh sì, è volontariato, lo fa perché è buona… No, è importante. È importante anche per i datori di lavoro che assumono un lavoratore straniero», che sappiano cos’è un permesso di soggiorno, «che cosa succede se arriva un controllo», ecc. «Nessuno mi hai chiesto: qual è la sua parcella? Come faresti con un avvocato […] A me dispiace, perché poter essere in grado di avere gli strumenti per lavorare, lavorare bene, molto volentieri, nelle scuole, negli ospedali, nei comuni, nelle istituzioni» sarebbe importante. «Purtroppo, sono qui che devo aspettare che si sveglino loro, perché se io adesso mi aprissi una partita Iva e mi proponessi, probabilmente nessuno risponderebbe che ha bisogno di me», nessuno «mi pagherebbe. Nessun privato, o comunque nessuna istituzione che non abbia soldi dall’alto per farlo». Per continuare l’esempio della mediazione che sta facendo a scuola, a Barbara sono state date 20 ore in tutto, non 20 ore alla settimana, per lavorare con due famiglie straniere. Mi fa piacere sapere che le insegnanti che per la prima quest’anno hanno visto un mediatore a scuola, hanno detto: sì, se ci fossi stata io gli altri anni avremmo avuto molti meno problemi. Quindi, magari col tempo c’è speranza che si apra gli occhi e che si capisca che le nostre figure devono essere […] un po’ più considerate […] Comunque questo lavoro mi piace, sono contenta di farlo perché mi fa piacere. E poi ci trovo un grande scambio. Non mi sento Madre Teresa di Calcutta che aiuta nessuno […] C’è sempre un arricchimento, e secondo me c’è più per me che non per gli altri. E quindi non vorrei abbandonarlo. Purtroppo, mi trovo poi a dover fare anche altre cose, perché non mi può bastare assolutamente […] ma va bene così. Questa professione ha scelto me. Non l’ho scelta io.
Quando ho chiesto a Barbara se abbia mai ricevuto dei commenti da parte degli italiani che conosce per la sua professione, ha risposto:
Ma, sinceramente nessuno ha mai avuto forse il coraggio, non lo so, di dirmi […] qualcosa che non va con il mio lavoro. Forse qualcuno mi fa le battutine, […] che andiamo aiutati prima noi, o qualcosa del genere. «Eh sì, se non ci aiutiamo noi, cosa stiamo ad aiutare gli altri?». Io dico sempre che innanzitutto io non sono una persona che sbatte la porta al vicino di casa. Quindi se hanno bisogno di aiuto me lo possono anche venire a chiedere, e poi […] che non si tratta di noi e voi. Che tutto il mondo è paese. Tutto qua. Diciamo che poi […] non si aprono neanche grandi discussioni […] perché non ce n’è bisogno. È possibile mediare con il razzismo di stato?
Ho ritenuto quindi opportuno chiedere a Barbara come coniuga la sua professione con delle sue eventuali opinioni politiche. Barbara ritiene di vivere in un regime di «finta democrazia».
Cioè, io non […] sento che noi veramente abbiamo un potere, che noi abbiamo qualche potere decisionale. Di fatto c’è molta separazione tra noi e la classe politica. E misembra anche che appunto, quando vado a lavorare nelle istituzioni io non mi sentoprotetta, non mi sento capita. E non […] sento che quelle persone sono lì al mio servizio, perché […] di questo dovrebbe trattarsi. Ma soprattutto quando si tratta del mio mestiere c’è sempre molta ostilità. E questa non è democrazia per me. E […] non […] sento di poter dire sempre la mia.Al di là delle considerazioni più generali sulla democrazia, è importante il fatto che Barbara si senta trattata con ostilità dalle istituzioni quando fa il suo lavoro. Perché? Innanzitutto, viene ostacolata dagli uffici immigrazione delle questure, che secondo una visione illusa e idilliaca dovrebbero aiutare gli immigrati fornendo loro un servizio. Eppure, Barbara racconta una storia diversa, che può sembrare strana solo a chi non ha mai messo piede in un ufficio immigrazione.
Assolutamente, io sono stata ostacolata. Cioè,ti faccio esempi banali […] Ufficiali dell’Ufficio immigrazione che gli porti tutti i documenti, arrivi col ragazzo, è tutto a posto. Ci hai messo magari un mese a racimolare tutto. E lei decide che no, che manca un documento. E tu gli dici: «No, il documento non manca». «Allora la mediatrice deve scendere, non può più stare qui». Già questa cosa… Io non posso dire: non è vero, non c’è niente che le impedisca effettivamente di farmi scendere [ricordiamo che stiamo parlando di poliziotti in divisa, M.G.] Quindi mi fa scendere giù, resta sola col ragazzo, quindi manca […] completamente la comunicazione tra loro due. E […] ci manda via inventandosi un documento che in realtà non esiste. Dopo di che tu torni dopo due giorni, ti sei sbattuto, […]ti devi far fare una lettera da qualcuno che dica:no, guardi, questo documento non esiste. Cioè, ho dovuto fare questo. Ho dovuto farmi dire da un avvocato: per favore, me lo scrivi che questo documento non glie lo devo portare? Perché se no non gli fanno rinnovare il permesso di soggiorno. Cioè, questo è. Tu non mi stai facilitando il lavoro.Il lettore che pensasse si tratti di un caso di idiotismo burocratico o di una barzelletta sui carabinieri mancherebbe completamente il bersaglio. Studi risalenti a oltre trent’anni fa, infatti, dimostrano che l’arbitrio delle questure e delle prefetture nel trattare gli immigrati non è altro che una tecnica precisa per discriminarli [6]. Esasperare le persone all’infinito, rendere loro la vita impossibile, è una precisa strategia del razzismo di stato [7].
Per tornare allo scandaloso caso raccontato da Barbara (che si noti bene, è ben lontano dall’essere l’unico o dall’essere il peggiore), notare che si trattava per di più di un rinnovo, e non della richiesta di un nuovo permesso. Barbara è stata sostanzialmente buttata fuori dalla polizia mentre faceva il suo lavoro. Più in generale, negli uffici immigrazione si ottiene o meno il documento a cui si ha diritto in base al «buon umore o a mal umore» del poliziotto di turno. Per non parlare dei «modi di rivolgersi che sono sempre maleducati». Oltre al dare «sempre dare del tu», anche «cercare di scandire le parole male», evidentemente per sfottere l’immigrato [8]. Insomma, Barbara ha avuto «molti scontri» proprio con coloro che a qualcuno piace pomposamente chiamare “servitori dello stato” (e infatti non c’è dubbio che servano lo stato, a scapito di una minoranza razziale discriminata). Sempre nel caso specifico, non è servito a nulla che Barbara dicesse: «Ma io sono qui perché lui non parla italiano. Cioè, nel senso, è inutile che vi lascio soli».
E l’immigrato è stato mandato via senza il documento di cui aveva bisogno.
Del resto, Barbara deve ammettere di aver sentito «ancora peggio» di altre questure nelle quali non ha lavorato direttamente: di mediatori culturali perquisiti come fossero dei delinquenti, «o persone a cui veniva dato l’appuntamento dopo un anno». Insomma, «cose dell’altro mondo». A una mia ulteriore domanda, Barbara ribadisce che le questure non forniscono i loro servizi «nella maniera in cui andrebbe fatto». Intanto, secondo Barbara i mediatori culturali dovrebbero «esistere già dentro le questure […] Loro» dovrebbero occuparsi
di essere nell’ufficio, di interfacciarsi. Non il pubblico ufficiale che è stato spostato dall’ufficio porto d’armi o dall’ufficio passaporti. Perché poi vengono continuamente spostati. Quindi, non sono mai neanche totalmente preparati. Ti fanno perdere un sacco di tempo. Tu ovviamente non ti devi azzardare a dirgli: guarda, devi fare così e così. Dire tu al poliziotto cosa deve fare. Per quello ti dico: c’è poca serietà nel considerare la nostra professione, perché sarebbe tutto molto più semplice se ci fossero dei mediatori nelle istituzioni. Anche negli uffici anagrafe, nei comuni, negli ospedali […] Invece mettono a gestire delle persone che non sanno assolutamente gestire né il diverso, né situazioni complicate. E non ne hanno voglia, non gli interessa. Per cui ovviamente lo fai male, se una cosa non ti piace.
Devo aggiungere che ovviamente criminalizzare delle persone facendole vessare da poliziotti in divisa non è certamente un modo per gestirle, ma per discriminarle. Del resto, in altri paesi europei (v. Svizzera, Slovacchia, persino la “fascista” Ungheria) gli uffici immigrazione dipendono sì dal ministero dell’interno (cosa di per sé discutibile), ma non sono gestiti da poliziotti in divisa. Per aggiungere un altro caso scandaloso, Barbara ha da «poco […] chiamato la prefettura» locale
per chiedere un’informazione per far venire un ragazzo con le […] quote lavorative. E mi sono ritrovata a parlare con una che mi ha detto: «Guarda, noi siamo state spostate qualche mese fa dal nostro ufficio, perché sono andati tutti in pensione. Ma ancora non abbiamo capito nulla di quello che dobbiamo fare, perché nessuno ci ha fatto la formazione».Viva la sincerità, come si suol dire. Al che Barbara: «Vabbè, lei mi sta dicendo una cosa gravissima. Cioè io come faccio? Mi servono queste informazioni. Non è che il ragazzo non arriva» per colpa vostra.
“Chiedete che vi venga fatta la formazione […] Ma te lo devo dire io?” E mi fa: guardi, non lo so, provi a richiamare tra una settimana perché magari siamo messe meglio, perché ci sono un sacco di scartoffie da sistemare… Alla fine per fortuna ci siamo arrangiate da sole con la datrice di lavoro. Il quadro scandaloso fatto da Barbara può in realtà sorprendere solo qualcuno che non ha la più pallida idea di come siano discriminati gli immigrati in Italia. Una delle solite obiezioni del negazionismo italico, però, è: ma dai, è evidente che si comportano così solo in un posto, non è così dappertutto. Per vedere come ciò sia falso e riduttivo, sentiamo Barbara raccontare cosa è successo con «la famosa emersione 2020 dal lavoro irregolare, quella per gli agricoli e i lavoratori domestici», tanto strombazzata da una ministra di sinistra.
In città come Milano, ancora stanno chiudendo le pratiche. Sono passati tre anni. O ancora alcune pratiche non sono state chiuse. Poi sicuramente hanno numeri assurdi. Però probabilmente in quegli uffici non ci sono abbastanza funzionari. Perché non ci vogliono tre anni a chiudere una partica di emersione. Ci vogliono pochi minuti in realtà. Quindi puoi avere anche numeri assurdi, ma tre anni son tantissimi. Quindi comunque lentezza. Permessi di soggiorno che arrivano scaduti [ride] Arrivano da Roma. È capitato che fossero arrivati i permessi di sei mesi […] già scaduti.Assolutamente, Barbara ritiene che sarebbe meglio se gli uffici immigrazione non fossero gestiti da poliziotti in divisa, ma aggiunge:
Ma già io vedo la differenza da quando i ragazzi vanno da soli in questura o quando invece li accompagno io. Hanno anche una serenità diversa. Perché appunto comunque ti trovi davanti a un ufficiale. E tra l’altro, secondo dal paese in cui vieni, la divisa non è che ti mette esattamente a tuo agio. Se poi l’atteggiamento dall’altra parte è quelli di: dai, fai, questo non va bene, questo…!!! […] Sempre con questi modi. Ci dimentichiamo anche che ci sono dei traumi piscologici dietro. Per fare un esempio paradossale, Barbara ricorda che nella questura locale
l’anno scorso, per un anno intero, erano stati assunti due ragazzi […] presi da un’agenzia interinale […] per mancanza di personale, e quindi avevano necessità di persone esterne […] Erano due ragazzi che avevano studiato scienze politiche […] Comunque, da quando c’erano loro li potevi mandare da soli, era tutta un’altra cosa […] Tu mediatore non avevi necessità di accompagnare. Potevi tranquillamente spiegare alla persona cosa doveva fare, e quando arrivava lì trovava davanti uno che facilitava. E che se eventualmente ti mancava qualcosa non te lo urlava addosso, ma diceva: guarda, manca questo, vai a farlo adesso, ci vediamo tra un’ora. Quindi è stato un periodo molto bello. In altre parole, l’ennesimo paradosso: per avere qualcuno di competente e che non si comporti da aguzzino con gli immigrati, c’è stato bisogno di mancanza di personale per assumere qualcuno che non fosse un poliziotto! Barbara non ricorda di aver sentito veri e propri insulti da parte della polizia in sua presenza, «però sicuramente modi molto bruschi e molto maleducati, quelli sì […] fin troppo spesso». Quando ho chiesto se gli immigrati si lamentino talvolta di questo comportamento, Barbara ha detto di sì, «anche in mia presenza. Ma anche io sono stata a dire: “Cioè, non c’è bisogno […] di agitarsi. Adesso rivediamo […] le carte e cerchiamo di capire che cosa […] manca e che cosa dobbiamo fare”». Dopo, però, «continuano […] a fare quello che vogliono». Detto questo, «ovviamente» gli immigrati «hanno paura. E quindi non che c’è mai stato un: no, però voi non dovete fare…! Cioè, sono sempre state lamentele molto velate, molto tranquille». Tornando alla volta in cui Barbara era stata buttata fuori, ricorda di aver «proprio reagito male». Infatti, dopo che l’immigrato era stato cacciato senza documento con una scusa idiota, le era stato anche vietato di risalire a parlare con la poliziotta. Pertanto, diceva al poliziotto all’ingresso:
«Dica alla sua collega di scendere perché voglio parlare con lei». E lo dicevo proprio con un tono di voce altissimo, ero arrabbiatissima. E lui mi diceva: si calmi, si calmi. E io dicevo: ma, ma stiamo scherzando? Cioè, alla fine hanno vinto loro e me ne sono dovuta andare via. Avessi avuto un altro carattere avrei spaccato tutto […] È che mi trattengo sempre perché mi devo ricordare che sono lì per altri, non per me. E non voglio mai compromettere, ovviamente. Non vorrei mai che poi appunto i ragazzi venissero compromessi per colpa mia. Però a volte è difficile.Questo è ciò che deve passare una mediatrice culturale che cerca solo di fare il proprio dovere.
Che cos’è la politica?
Quando ho chiesto a Barbara più nel dettaglio se lei avesse delle opinioni politiche, ha precisato che la politica partitica e istituzionale non l’ha mai interessata, caratterizzata com’è dal «compromesso» e dal «dialogo con chi non vuoi», dall’«Ok, io ti do questo tu mi dai quello». Detto questo, è sempre «andata a votare. Mi sono sempre informata, ho sempre letto i giornali. E ho sempre cercato di votare chi fosse […] più vicino alle mie corde. Mai […] nessun partito che ho votato ha vinto». Il fatto che Barbara sia lontana dalla politica partitica non significa che sia priva di idee politiche in senso lato, che per lei sono quella della multiculturalità, dell’anti-sessismo, delle questioni di genere. Ma anche l’antifascismo, l’anticapitalismo, il femminismo.
Nello specifico, quando Barbara faceva attività di sportello con la associazione, si è avvicinata a un piccolo gruppo antifascista locale. Benché fosse molto impegnata con l’associazione e avesse paura di non avere tempo per ulteriori impegni, si era comunque
avvicinata a loro soprattutto per dire: […] «Voi siete un bel gruppo di persone. Io sono sola e so che […] quello che faccio […] interessa tutti» […] Sono andata a presentarmi per dire: c’è questa realtà, ci sono io, però sono sola, mi piacerebbe fare le cose con voi. E quindi è stato molto bello perché hanno risposto bene. Quindi hanno iniziato a venire di più da me, e poi viceversa hanno iniziato ad organizzare loro delle attività con i ragazzi. Avevano fatto un laboratorio di pasta […] Abbiamo iniziato un po’ a frequentarci, anche come persone. Barbara però ha «volutamente deciso di non far» direttamente «parte del gruppo», per evitare «dinamiche personali» che in una piccola comunità «si vanno a mischiare con quelle politiche». Quindi, Barbara ha fatto un po’ da «satellite», girovagando intorno ed essendo sempre presente «per aiutare a organizzare le attività. Ma non […] ho mai fatto parte delle riunioni o questo genere di cose». Nel 2020, poi, questo gruppo antifascista ha iniziato un nuovo esperimento, quello di un podcast, proprio a causa del lockdown che «ci stava facendo perdere di vista i contatti umani»: c’era «bisogno di dire, di esprimerci». Adesso c’è ancora un’altra attività, «il tè delle donne […] Una cosa bellissima, […] un incontro settimanale tra noi» del gruppo «antifascista e donne straniere. In cui scambiamo, parliamo, ci aiutiamo a vicenda, ci raccontiamo, facciamo giochi, mangiamo molto [ride] Queste le attività che facciamo al momento. Le attività politiche che mi piacciono».
Un’attività politica in piccolo che è comunque interessante dato che sembra diversa dall’attività professionale di Barbara propriamente detta. Barbara, però, nota che
fa anche parte del mio lavoro far conoscere le varie realtà ai ragazzi e viceversa. E come li ho sempre istruiti, invogliati a frequentare, a vedere i musei, ad andare agli eventi eccetera, li ho voluti anche fare incontrare con questa realtà e dirgli: c’è anche questo. E ci sono stati ragazzi che poi hanno continuato ad andare perché si sono incuriositi e sono stati bene, altri no. Però, il mio dovere è anche quello di far conoscere la realtà che hanno intorno. Perché sei finito qui, c’è questo, questo e questo. Poi vedrai tu cosa è nelle tue corde. E mi sembrava importante che questo gruppo «antifascista venisse conosciuto». Barbara pensa che quello le è sempre sembrato il gruppo «più affine a me, con cui potessi fare delle attività insieme. Poi io ero davvero completamente sola. E a un certo punto è diventato davvero pesante fare tutto. Comunque, hai anche bisogno di scambiare […] idee, di un gruppo che ti invogli, che proponga». Pensare che Barbara era sola in città come rappresentante della sua associazione, e non poteva certo mandare i verbali delle assemblee alla sede centrale, come le chiedevano dal capoluogo di regione. «Gli ho detto: sì, dovrei mettere dei pupazzi sulle sedie, o mi metto davanti allo specchio a fare le assemblee».
Questa solitudine di Barbara era diversa dalle altre città della regione, dove i membri di ogni sede potevano arrivare anche a quindici persone. «Avevo a un certo punto bisogno veramente di socialità e che i ragazzi vedessero anche che c’era un viavai, anche in sede, insomma che ci fossero più cose. Infatti, organizzammo una bella festa di autofinanziamento con l’aiuto» del gruppo «antifascista. E abbiamo anche raccolto un bel po’ di soldi. È stato molto bello, la comunità […] risponde sempre quando ci sono iniziative di solidarietà». Eppure, nella cittadina di Barbara è presente una sezione nell’Anpi (in realtà fondata solo di recente e stranamente, dato che in zona non c’è stata lotta partigiana): Barbara non ha mai pensato di collaborare con l’Anpi?
«Ho avuto contatti con l’Anpi, ovviamente, negli anni. Nella fattispecie» a livello locale
l’età media è veramente alta. E quindi io in realtà per i ragazzi volevo più che frequentassero persone un po’ più giovani, […] che facessero cose con persone un po’ più giovani, perché la tendenza dell’Anpi è quella di fare […] degli eventi che stanno dentro il solito stereotipo […] Facciamo degli esempi […]: la giornata internazionale dell’immigrato […] Faccio cucinare i ragazzi, faccio l’invito, gli faccio dire due cose. Non lo so, […] mi è sempre sembrata una realtà […] con cui io non potessi collaborare molto. Però li ho sempre appoggiati, e insomma, sono a contatto con alcune «personalità dell’Anpi» locale «che rispetto moltissimo» [9].
Tornando invece al suddetto gruppo antifascista, è anche capitato che Barbara mettesse in contatto con questo gruppo delle persone discriminate che lei non aveva modo di aiutare professionalmente. Il gruppo antifascista ha però potuto parlarne nel suo podcast e mettere in contatto queste persone con dei giornalisti cattolici locali che hanno parlato della questione (mentre la sinistra istituzionale non solo non ha fatto nulla, ma addirittura insultato gli immigrati che chiedevano aiuto dicendo che dovevano rivolgersi «agli assistenti sociali»). Si tratta insomma di casi di razzismo di stato che non possono essere rimandati «a chissà quale ufficio» e che rappresentano pertanto «un problema politico di fatto». Non si tratta solo di una «burocrazia […] difficile da superare», ma di «istituzioni che non ci vengono incontro» e che «spesso ci creano ancora più problemi di quello che dovrebbero». Gli immigrati «non vanno lasciati soli». Barbara ritiene che le famiglie miste, pure criminalmente discriminate dallo stato, siano un po’ più fortunate. Il membro italiano della famiglia, soprattutto se ha studiato, può fare più cose, rivolgersi a più persone. «Immaginiamoci quando sono completamente soli e non hanno nessuno che li accompagna, che gli spiega le cose».
Mediazione, non assistenzialismo
Per concludere, Barbara precisa che la mediazione culturale come la intende lei è ben diversa da un «modello assistenzialistico», che lei critica
«dall’università», e che è
l’impostazione che hanno altre associazioni […] (non nessun problema a dire il nome), tra cui ad esempio la Caritas. Che è quello di: ti do l’aiuto momentaneo, ti do il soldino, ti do la bombola del gas, la pasta. Ma poi di fatto se una persona gli va a chiedere […] dei soldi per un corso di formazione allora no, allora lì non si possono più dare. E allora che cosa stiamo facendo? La mia impostazione è: tu vieni da me, e io ti do, ovviamente ti metto a disposizione le mie competenze, ma lo sforzo deve essere settanta-trenta. Nel senso che settanta è tua, quindi io ti aiuto a ritrovare un attimino di equilibrio che ovviamente hai perso dopo un viaggio del genere. E il fatto che sei spaesato. Quindi ti accompagno nella prima parte. Ma poi è giusto che ti dia gli strumenti affinché tu possa vivere da solo, trovare un lavoro, trovare una casa, fare una famiglia. E purtroppo questa non è l’impostazione che si ha di solito. Questo è perché Barbara ha lasciato la casa di cui parlava prima,
perché anziché […] l’impostazione «arriva questa persona, gli facciamo fare un percorso» […], ci sono stati dei ragazzi che son stati anni. Sono diventati boss che occupavano stanze letto che altri non occupavano. Selezioni all’ingresso: i nigeriani no, quegli altri sì. I ragazzi entrano dall’altra porta, non posso entrare dall’ingresso principale del palazzo perché danno fastidio alle signore. Cioè, questo tipo di cose non aiuta nessuno. Non stai facendo assolutamente niente. E non che io gli do una casa e gli pago le bollette per anni […] Non ha nessun senso. A un certo punto, Barbara propose anche di non andare a pagare le bollette della casa, ma di dare i soldi agli immigrati perché lo potessero fare loro stessi: «Responsabilizziamoli, glieli diamo a loro […] Non sapevano neanche come era fatta una bolletta». Inutile poi stupirsi che si dimenticavano le stufe accese (Barbara ricorda che anche «i ragazzi della» sua «casa dello studente» si dimenticassero «le luci accese, perché non le pagavano loro le bollette. E funziona così»). Insomma, sarebbe stato meglio accompagnargli, insegnare loro a «gestire una casa. Che può sembrare ridicolo, ma non era assolutamente scontato».
Questa mancanza di progettualità sul lungo periodo, infatti, ha creato situazioni difficilmente gestibili a livello di «rapporti interpersonali. Loro non si riescono a gestire perché di fatto tu hai preso delle persone che non si conoscevano e le hai messe in una casa. E gli hai detto: eh beh, state qui» per chissà quanto, senza dare loro
nessun progetto, nessun seguito […] Finché c’ero io facevo questo. Però poi non mi è bastato più […] Volevo proporre altre cose, non sono state ascoltate. C’era questa cosa della selezione: i nigeriani non li accettiamo più. Io ‘ste cose non le posso sentire. Restiamo umani,diceva Vittorio Arrigoni […] Puntualmente arrivavano dei nigeriani in casa e si creavano dei problemi. Ma […] si chiama anche un po’ profezia che si auto-adempie. Perché se tutti i ragazzi, tutto il mondo è convinto che i nigeriani sono tutti cattivi, e appena quello entra in casa e già gli stai rompendo le balle, quello ti risponde male, no? Se la vogliamo spiegare proprio in termini molto […] terra terra. Però di fatto era quello che succedeva. E io credo che non fosse questo il nostro ruolo. Di decidere chi poteva entrare e chi non poteva entrare, ma di dargli almeno dei binari. Ed è questo che a me piace fare. Chiunque mi venga a chiedere un aiuto io gli do l’aiuto, ma sempre con la prospettiva di: «Tu devi camminare da solo. Ti porto una-due volte in questura. Alla terza sai benissimo cosa fare, hai l’elenco dei documenti, hai imparato l’italiano, adesso tocca a te». È così, perché dovrebbero dipendere da me per sempre? È terribile questa cosa.Conclusione
Cosa dire in conclusione di un excursus così esplicito?
In realtà, le parole di Barbara sono così chiare che parlano da sole. Posso solo cercare di enucleare e riassumere alcuni punti fondamentali che dovrebbero essere spunto per ulteriori riflessioni. Intanto, ciò che è interessante nella storia di Barbara è che è una storia di vocazione, che nella sua intensità ricorda quasi quella religiosa: «Questa professione ha scelto me. Non l’ho scelta io». La storia di Barbara permette anche di riflettere sul rapporto sui concetti di razza e classe. Nel suo libro La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, lo storico marxista Domenico Losurdo (1941-2018) notava che Marx intendeva il concetto di classe in senso più ampio di quello che si potrebbe pensare [10]. Secondo Marx, anche le lotte anticoloniali e per l’emancipazione razziale erano un esempio di lotta di classe. Di più: secondo Marcus Green, il concetto di subalterni usato da Gramsci nei Quaderni era ugualmente inclusivo di più concetti come appunto quello etnico [11]. In questo senso, Barbara rappresenta una proletaria italiana che ha deciso di spendere la sua vita per aiutare i subalterni razziali, gli immigrati che arrivano in Italia. Ciò è tanto più interessante in quanto secondo una recente vulgata, i problemi dell’Italia sarebbero causati dal populismo degli italiani poveri (“il popolo bue”) che sono razzisti con gli immigrati.
Se l’ostilità di molti lavoratori italiani verso gli immigrati è oggi un dato di fatto, la storia di Barbara dovrebbe insegnare che essenzializzare non è forse l’approccio più giusto. Se molti italiani poveri sono contro gli immigrati, è perché sono ontologicamente ignoranti e xenofobi, o perché sono stati bombardati per anni da una propaganda che li ha spinti a essere tali (e una propaganda proveniente dall’alto, dalle principali forze politiche, ecc.)? Certamente, nel clima attuale la scelta di Barbara è ancora più coraggiosa: chi legge si chiederà perché una donna italiana debba campare con collaborazioni occasionali da 400 euro al mese per aiutare gli immigrati, essendo costretta a fare altri lavori ed essendo tra l’altro «ostacolata» e sabotata proprio dalle istituzioni. Sì, perché di questo stiamo parlando: la storia raccontata da Barbara esemplifica perfettamente il razzismo di stato contro gli immigrati, concetto difficile da capire per gli italiani che pensano, sbagliando, che il razzismo sia solo quello popolare, nella società. In realtà, il razzismo delle istituzioni (in primo luogo questure, prefetture, ecc.), è molto peggiore di quello popolare perché è legale, insormontabile, condiziona la vita di una persona fino a renderla impossibile. La storia di Barbara trasuda
Fanon: in un mondo compartimentalizzato e rigidamente diviso in razze diverse, il membro della razza dei signori (herrenvolk) che sta dalla parte di quella inferiore viene considerato un rinnegato e un traditore, e in quanto tale deve essere punito.
Un altro dato interessante è il rapporto avuto da Barbara con la Chiesa cattolica. Mentre alcuni preti sensibili sono stati importanti per organizzare una vera accoglienza, resta il dubbio del perché siano stati entrambi trasferiti. Secondo il succitato Losurdo, il cristianesimo nella storia ha anche significato la nascita «di un pensiero universalistico» [12]. Ma restano le dure critiche di Barbara a un sistema assistenzialistico che manca di progettualità sul lungo periodo, che pensa solo al dare un pezzo di pane tutti i giorni senza pensare a come fare guadagnare il pane autonomamente.
Altra preziosa riflessione fatta da Barbara è quella su una sinistra istituzionale che vede gli immigrati in modo stereotipato anche quando in teoria li starebbe aiutando (ma succede anche di peggio, vedere la fallimentare sanatoria fatta da una ministra di sinistra). Interessante invece che a livello locale le persone che sono state più vicine ai migranti facevano parte di un piccolo e informale gruppo antifascista (quello che qualcuno chiamerebbe “setta”, “facinorosi”, ecc.).
Infine, ugualmente preziosa è la riflessione di Barbara sul razzismo istituzionale che costituisce un problema politico, e non certo “burocratico”. Nel sistema italiano, la burocrazia è solo l’apparenza superficiale di una discriminazione sistematica. Del resto, basterebbe seguire questa semplice regola: se la data “burocrazia” esiste solo per un gruppo, allora non è burocrazia ma discriminazione.
Note
[1] Marco Buttino, Vite provvisorie (Roma: Viella, 2022).
[2] Emio Quadrelli, Evasioni e rivolte (Milano: Agenzia X, 2006).
[3] Raymond Siebetcheu Youmbi, “Identità e ruolo del mediatore linguistico-culturale in Italia,” The Journal of Cultural Mediation 1 (2011): 7-16.
[4] Carlo Ginzburg, “Microstoria: due o tre cose che so di lei,” Quaderni storici 29/86 (2) (1994): 511-539.
[5] Andrea Mubi Brighenti, “Periferie italiane,” Rassegna italiana di Sociologia 51/3 (2010): 511-518.
[6] Salvatore Palidda, Migranti. Devianza e vittimizzazione (Milano: Franco Angeli, 2010), edizione elettronica.
[7] Questo forse spiega anche azioni violente attribuite a “immigrati folli”, come quella di un dominicano che nel
2019 uccise due poliziotti a colpi di pistola all’interno della questura di Trieste, v. https://www.triesteallnews.it/
2023/04/omicidio-rotta-e-demenego-alejandro-meranassolto-anche-in-appello-per-vizio-di-mente/ V. anche: Pietro Basso (a cura di), Razzismo di stato (Milano: Franco Angeli, 201).
[8] Essendo stato un discreto frequentatore di questure e prefetture in quanto membro di una famiglia mista, vorrei aggiungere in una nota che i corsi di italiano servirebbe in primo luogo ai semi-analfabeti che vi lavorano, che spesso non sono in grado di parlare né tanto meno di scrivere un italiano comprensibile.
[9] Purtroppo, ci sono anche cose più gravi che si potrebbero dire del rapporto dell’Anpi con gli immigrati, v. https://www.pclavoratori.it/files/ index.php?obj=NEWS&oid=6977
[10] Domenico Losurdo, La lotta di classe. Una storia politica e filosofica (Roma-Bari, Laterza, 2013).
[11] Marcus E. Green, “Rethinking the Subaltern and the Question of Censorship in Gramsci’s Prison Notebooks,” Postcolonial Studies, Vol. 14, no. 4 (2011), 387-404.
[12] Domenico Losurdo, Fuga dalla storia? (Napoli: La scuola di Pitagora, 2012): 29.
https://www.blog-lavoroesalute.org/lavoro-e-salute-gennaio-2024/
https://www.lavoroesalute.org/




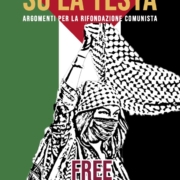






Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!