Sul diritto del lavoro nella Seconda Repubblica
Comprendere l’evoluzione (in peggio) del diritto del lavoro negli ultimi trent’anni costituisce un fondamentale strumento di comprensione della situazione presente e un importante bagaglio teorico per qualunque militante rivoluzionario. Questo articolo di Simone Bisacca, pubblicato sul n. 6/2024 di “Collegamenti” ne delinea un quadro sintetico ma efficace
La produzione legislativa in materia di diritto e processo del lavoro dal 1997 (c.d. Pacchetto Treu – governo Prodi I) al 2023 (decreto lavoro del 1 maggio 2023 – governo Meloni) ha ratificato lo spostamento dei rapporti di forza tra capitale e lavoro a favore del capitale avvenuta a partire dagli anni ’80 e ne ha accresciuto la dinamica.
Secondo i dettami del liberismo, compito dello Stato è rimuovere ogni impedimento alla libera determinazione dei prezzi anche nel mercato del lavoro e alla possibilità dell’impresa di soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera con la massima flessibilità.
Flessibilità declinata sia in entrata che in uscita, con effetto di precarizzare la condizione dei lavoratori; la contropartita teorica della flessibilità avrebbe dovuto essere l’aumento di occasioni di lavoro e quindi la diminuzione della disoccupazione, ma la relazione tra i due fattori resta indimostrata e gli unici effetti certi sono stati l’aumento delle diseguaglianze sociali e la diminuzione della conflittualità sul posto di lavoro.
Il mercato del lavoro, del resto, è componente dell’economia che, banalmente, sconta gli andamenti macroeconomici ed è mistificatorio attribuirvi poteri taumaturgici rispetto al benessere complessivo della società.
L’insistenza sulla flessibilità ha avuto la funzione, attraverso la precarizzazione, di frantumare e disciplinare i lavoratori, comprimendo i salari e consentendo quindi il mantenimento di un certo margine di profitti per le imprese anche in periodi di crisi.
La normativa nazionale approvata a partire dal 1997 di cui trattiamo va inoltre letta e interpretata alla luce della legislazione dell’Unione Europea, da cui spesso trova fonte e con la quale deve necessariamente entrare in relazione quando interpretata da avvocati e giudici.
Se i regolamenti sono direttamente efficaci nel nostro ordinamento, le direttive necessitano di recepimento attraverso apposita legge nazionale. Le direttive, per loro natura, offrono un quadro di tutela minima, lasciando spazi teorici per norme nazionali di miglior favore.
All’interno quindi di un orizzonte macroeconomico e di normazione eurounitario va letta la precarizzazione del nostro mercato del lavoro avvenuta negli ultimi decenni.
La produzione normativa di cui parliamo ha in primo luogo avuto lo scopo di creare una pluralità di forme contrattuali accanto ed in concorrenza al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tra di esse spiccano la scissione tra datore di lavoro e utilizzatore della forza lavoro, che è il sogno di ogni padrone, e l’ipocrita figura della collaborazione anziché della subordinazione: nel 1997 il c.d. pacchetto Treu (legge delega n. 196/1997) introduce così nel nostro ordinamento il lavoro interinale e la collaborazione coordinata e continuativa.
Di particolare valore simbolico l’introduzione del lavoro interinale, perché cancella quell’assoluto divieto dell’intermediazione nel mercato del lavoro contenuto nella legge n. 1369/1960, frutto della storica lotta al c.d. caporalato.
Altrettanto valore va dato alla creazione della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), figura di apparente lavoratore autonomo, che è in realtà un subordinato senza diritti.
Il Decreto Legislativo n. 368/2001 (governo Berlusconi II) recepisce la Direttiva UE sul lavoro a termine, mandando in soffitta un’altra fondamentale legge degli anni ’60, la n. 230/1962, che dettava norme molto rigide sul contratto di lavoro a termine.
Ma sarà con la c.d. legge Biagi, il Decreto Legislativo n. 276/2003 (ancora governo Berlusconi II) che avviene un ridisegno complessivo del mercato del lavoro nel senso della flessibilità: abrogato l’istituto del lavoro interinale, viene introdotta la somministrazione di lavoro e la regolamentazione delle relative agenzie per il lavoro; e poi le nuove tipologie di contratti di lavoro, come quella del co.co.pro (contratto a progetto), del contratto di lavoro ripartito, al contratto di lavoro intermittente, del lavoro accessorio, del lavoro occasionale; anche il contratto di apprendistato viene modificato, ampliandone i confini.
Contemporaneamente, la c.d. legge Biagi allarga le tutele dei lavoratori in caso di cessione di azienda o di un suo ramo e nel caso di lavoro nell’ambito di appalti.
La legge n. 183/2010, il c.d. collegato lavoro (governo Berlusconi IV) segna un’altra tappa fondamentale del percorso che stiamo descrivendo. Vengono infatti imposti termini di decadenza molto stretti (60 gg.) per l’impugnazione stragiudiziale dei contratti a termine, in materia di appalti e somministrazione irregolari e in altri casi, nonché un termine di 180 gg. per la proposizione della causa; viene determinato un risarcimento-standard per il caso di nullità del termine apposto al contratto a termine illegittimo; viene ridefinito lo spazio della possibile impugnazione delle clausole contrattuali.
La c.d. legge Biagi, infatti, con il vertiginoso aumento dei contratti atipici e precari, aveva avuto l’effetto di moltiplicare anche il contenzioso in materia: i datori di lavoro si erano sentiti liberi di applicare in modo brutale e su larga scala i multiformi contratti di lavoro che il legislatore offriva loro, ma l’effetto di una sentenza di nullità di detti contratti era pur sempre la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con il pagamento delle relative retribuzioni e contribuzioni fin dall’inizio del rapporto di lavoro; il contenzioso giudiziale in materia era diventato vastissimo, con pesanti costi per le aziende, ed il governo quindi corse ai ripari con la l. 183/2010.
Con la legge n. 92/2012, c.d. legge Fornero (governo Monti) “finalmente” viene riformato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e quindi la reintegra nel posto di lavoro non diventa più l’effetto automatico della dichiarazione di illegittimità di un licenziamento.
Come noto, il governo Monti subentra al governo Berlusconi in un momento di grave compromissione dei conti pubblici: accanto alla riforma delle pensioni, la modifica dell’art. 18 St. Lav. viene gabellata come misura anti-crisi, finalizzata all’aumento dell’occupazione, in base all’indimostrato teorema che l’imprenditore che può licenziare con un costo certo ha la tendenza ad assumere più facilmente. La realtà è che l’art. 18 St. Lav., prevedendo sempre la reintegra in caso di licenziamento illegittimo, aveva una forte natura deterrente, più che sanzionatoria, dall’effettuare licenziamenti illegittimi.
Ricordiamo che esattamente dieci anni prima, il 22.3.2002 la CGIL di Cofferati aveva portato in piazza tre milioni di lavoratori (secondo gli organizzatori) contro il tentativo del governo Berlusconi di riforma dell’art. 18: in piazza c’era anche tutto lo stato maggiore degli allora Democratici di Sinistra; nel 2012 il Partito Democratico (segretario Bersani) faceva parte della maggioranza che appoggiava il governo Monti e che riformò l’art. 18.
Nel 2014 il governo Renzi ha come Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, presidente di Legacoop da dodici anni: uno dei primi atti del nuovo governo (nato a febbraio 2014) è il c.d. decreto Poletti (decreto legge 20.3.2014 n. 34) che liberalizza totalmente i contratti a termine (non necessità di alcuna causale per la stipula di un contratto a termine) per una lunghezza massima di 36 mesi.
Nel 2015 lo stesso governo approverà il c.d. Jobs Act, composto da una serie di decreti che, da un lato, portano a compimento la flessibilità in uscita avviata con la riforma dell’art. 18 St. lav. nel 2012, con la nascita del c.d. contratto a tutele crescenti per i neoassunti delle aziende dove è ancora applicato ai vecchi assunti l’art. 18 stesso: lo scopo dichiarato è monetizzare i licenziamenti a costi certi per le aziende.
Sotto altro punto di vista, con il Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015) vengono ulteriormente affinate le norme che precarizzano i rapporti di lavoro e consentono la massima flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro (ad es. in materia di part-time).
Ma è la modifica di una norma di carattere processuale che assesta un altro colpo decisivo alla tutela dei lavoratori. Infatti, in base al testo originario dell’art. 92, comma 2, codice di procedura civile, era invalsa la prassi di compensare le spese legali in caso di soccombenza in giudizio del lavoratore: i lavoratori che facevano causa e la perdevano erano condannati al pagamento a controparte delle spese legali (secondo la norma generale dell’art. 91 c.p.c.) in rari casi; veniva data rilevanza alla posizione di “parte debole” del lavoratore e alla differenza di status economico tra le parti, al diverso impatto che una condanna al pagamento di alcune migliaia di euro poteva avere su una parte processuale piuttosto che sull’altra.
La legge n. 162/2014 (governo Renzi, ministro della giustizia Orlando) modifica l’art. 92, c. 2 c.p.c. limitando la possibilità di compensare le spese legali a rari casi specificamente indicati: le pesanti condanne alle spese legali che iniziano a colpire i lavoratori hanno un effetto deterrente immediato sulla richiesta di tutela in sede giudiziaria. Nemmeno l’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 77/2018 amplia leggermente la possibilità della compensazione, modificherà la situazione venutasi a creare.
Il primo governo Conte, con il decreto legge n. 87/2018, c.d. decreto dignità, reintrodusse alcuni limiti alla stipula e rinnovo dei contratti a termine oltre dodici mesi, ponendo un freno alla stipula indiscriminata di contratti a termine.
Lo stesso governo, quasi al termine della sua esperienza, approvò il decreto legge n. 101/2019 che per la prima volta approntava una qualche tutela per i lavoratori su piattaforma.
L’attuale governo, con il decreto legge approvato simbolicamente il 1.5.2023, ha cancellato i limiti introdotti al contratto a termine nel 2018.
Gli interventi di diritto sostanziale e processuale fino a qui descritti hanno peggiorato la condizione normativa dei lavoratori e diminuito la possibilità di tutela, contribuendo al mantenimento di bassi salari.
Secondo i dati del Ministero della Giustizia, dal 2012 al 2021 le cause in materia di contratti a termine sono diminuite del 91%; quelle di impugnazione di licenziamento per motivi economici del 66%; quelle di impugnazione di licenziamento per motivi disciplinari dell’80%; quelle di impugnazione di licenziamento per giusta causa del 52%.
Per l’insieme normativo tutto sbilanciato a favore del datore di lavoro, con il rischio concreto di condanna alle spese per non essere riusciti a dimostrare le proprie ragioni (spesso le prove documentali sono nell’esclusiva disponibilità dei datori di lavoro; non sempre si trovano testi disposti a esporsi), si fanno meno cause e quelle che si fanno si cerca di conciliarle più che un tempo.
A questo punto vale la pena ricordare, per completezza, altre due vicende di questi anni relative alla normazione in materia di lavoro.
La prima è il referendum abrogativo promosso dalla CGIL nel 2016 su tre quesiti e che avrebbe dovuto tenersi su due quesiti nel 2017: la Corte Costituzionale non ammise il quesito sull’art. 18 St. Lav., farraginoso e oscuro, ammettendo i quesiti relativi alla tutela dei crediti dei lavoratori in materia di appalti e di voucher. Il governo Gentiloni, subentrato alla fine del 2016 al governo Renzi, provvide a recepire con una norma di legge il contenuto del quesito sulla solidarietà negli appalti e ad abrogare le norme sui voucher, per immediatamente approvarne di nuove, cosicché il referendum non si tenne.
Di referendum abrogativo in materia di lavoro la CGIL ha ricominciato a parlare nel corso del 2023, ma allo stato non vi è nulla di definito. La circostanza che si parli della cosa è però significativa.
La seconda è il ruolo avuto in questi anni dalla magistratura: Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, giudici di merito. E’ vero che si fanno molte meno cause di un tempo, ma indubbiamente il ricorso alla magistratura può risultare utile ed efficace; la questione merita un approfondimento articolato, che potrà essere materia di un prossimo articolo.
Ma fin da ora va detto che sull’art. 18 St. Lav. riformato nel 2012 e sulle tutele crescenti introdotte dal Jobs Act nel 2015 sono intervenute più sentenze della Corte Costituzionale, che ne hanno abrogato parti significative, ampliando la tutela dei licenziati; anche la Corte di Cassazione ha emanato diverse decisioni che mitigano l’impatto negativo sui lavoratori delle normative citate.
Consolidata, poi, è la giurisprudenza di merito che riconosce la natura subordinata dei rider, andando quindi oltre l’intervento legislativo del 2019.
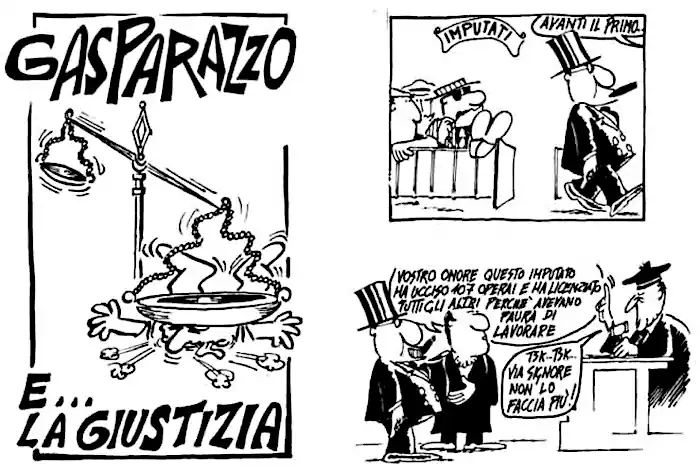
Infine, merita un capitolo a parte la serie di interventi della magistratura in quella che potremmo definire la materia del “salario minimo”. Come noto, l’art. 36 della Costituzione prevede che “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La norma è direttamente efficace e da sempre utilizzata dalla magistratura per applicare le retribuzioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro a rapporti di lavoro che non vi facevano direttamente riferimento.
A partire dagli anni intorno al 2010, i giudici del lavoro hanno iniziato a ritenere contrari all’art. 36 Cost. anche i minimi previsti da alcuni CCNL come quello sottoscritto dall’UNCI, un’organizzazione cooperativistica, con CISAL e altri sindacati autonomi: la forbice tra questi minimi e quelli previsti dai CCNL sottoscritti da CGIL CISL UIL era tale (circa il 30%) da costringere la magistratura a intervenire.
La grossa novità di questi ultimi anni è stata che anche le retribuzioni previste in CCNL sottoscritti dalle organizzazioni di categoria delle più grandi confederazioni sono state considerate, in certi casi, incompatibili con l’art. 36 Cost. La vicenda del CCNL Servizi Fiduciari sottoscritto da CISL e CGIL è arrivata fino in Cassazione e questa nell’ottobre 2023 ha definitivamente sancito l’illegittimità ed insufficienza dei minimi previsti da questo CCNL, confrontandoli con le statistiche ISTAT sulla soglia di povertà, l’ammontare del reddito di cittadinanza, le retribuzioni previste da altri CCNL regolanti settori analoghi e identiche mansioni.
Il diritto, la sua interpretazione e applicazione, si conferma nella sua doppia natura di pharmakon, medicina e veleno: rafforza o indebolisce, protegge o danneggia, a seconda di chi lo usi e per quali scopi; strumento ancora potente, con cui dobbiamo fare tuttora i conti.
28/3/2024 https://collegamenti.noblogs.org/










Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!