Umiliati sulla rotta balcanica

XII RAPPORTO (viaggio del 17-22 dicembre 2019)
(leggi anche La speranza degli uomini scalzi)
Da tempo, per chi voglia informarsi, i dati sulla situazione bosniaca sono numerosi e precisi, dotati anche di sistematicità e progressione temporale, mentre la situazione peggiora costantemente con l’inesorabilità di una frana. I nostri rapporti non possono aggiungere nulla di nuovo se non nei dettagli, ma, come è noto, il diavolo sta nel dettaglio. Per conoscere i dettagli bisogna andare sul posto. Diamo subito degli esempi.
Abbiamo noi stessi involontariamente prodotto proprio un esempio del comportamento “arbitrario” della “security” del campo Bira, a Bihac, che ritiene opportuno punire un ragazzo, perché è uscito con noi volontari la sera del 20 dicembre, giorno del suo compleanno. Lo ha lasciato all’aperto nella notte di pioggia, malgrado si fosse presentato in orario e avesse il tesserino per entrare. Un arbitrio di due o tre poliziotti privati di guardia al cancello, pagati dall’IOM, cioè anche da noi. Sappiamo benissimo che l’arbitrio è una modalità abituale di esercizio del potere, in particolare del piccolo potere subalterno: una specie di salario sadico per i subalterni. Ormai chi vuol sapere, e anche chi non vuole, sa che la polizia croata agisce normalmente con metodi di violenza anche estrema. Lo sanno perfettamente le istituzioni preposte, europee, UNHCR, IOM – ma nulla cambia, se non in peggio.
Ancora davanti al Bira, un incontro particolarmente doloroso: un ragazzo afghano sedicenne in carrozzella, con piedi fasciati per i colpi di manganello della solita polizia croata. È chiaro e preciso l’intento di colpire le gambe, il corpo in movimento. Un migrante in carrozzella, privato della possibilità di camminare è una di quelle condizioni insieme dolorosamente individuali ma significative di una condizione umana e di una politica sciagurata, miserabile, dell’Unione Europea. Ricordiamo in carrozzella Alì, poi morto per le conseguenze del game; e l’estate scorsa, al campo spontaneo di Velika Kladuša ora scomparso, un altro ragazzo in quelle condizioni.
Davanti all’ex hotel Sedra, a una quindicina di chilometri da Bihac, il padre di una famiglia iraniana ci mostra i segni evidenti di colpi fortissimi proprio alle articolazioni delle gambe ricevuti durante un respingimento il 21 dicembre.
È invece del 27 dicembre 2019 l’ennesima testimonianza, che leggiamo, di migranti catturati in Croazia e ricacciati senza scarpe in Bosnia: “…ero a Zagabria, ho chiesto asilo ma loro non hanno accettato… hanno preso il mio zaino e giacca, ci hanno tolto le scarpe e ci hanno respinto in Bosnia “(traduzione dall’inglese).

_____________________________________
Uno dei compiti del nostro ultimo viaggio in Bosnia era, appunto, di andare all’ospedale di Bihac a ritirare i documenti del ricovero di Benham Jebraelli, avvenuto un anno fa, migrante iraniano accolto in Germania, che intende sporgere denuncia per i danni subiti durante uno dei molti respingimenti che ha dovuto “vivere” (uso questo verbo perché i pushback violenti fanno ormai parte della vita – mi viene da dire della ‘carriera’ – di ogni migrante).
Nei dintorni di Bihac, di Kladuša, lungo la strada fra le due cittadine, che distano una cinquantina di chilometri, si vedono sempre i gruppi che vanno o tornano dal game…
E poi, qui, a Trieste capolinea della rotta, cerchiamo di accogliere, come possiamo, anche con interventi di tipo infermieristico, quelli che ce la fanno, soprattutto quelli che vogliono andare oltre per continuare il viaggio della vita. Si è formato infatti, finalmente, dopo lunghi tentativi, un gruppo consistente che con regolarità interviene due o tre volte alla settimana con i migranti che non vogliono far domanda d’asilo in Italia.
Siamo arrivati a Bihac la sera del 17 dicembre, insieme al fotografo romano, Andrea Sabbadini e agli attivisti Chiara Lauvergnac di Trieste e Franco Casagrande di Genova. Ormai, dopo tanti viaggi, la cittadina ci è diventata familiare – con i suoi edifici storici, come l’alto campanile dell’antica chiesa abbandonata, che spicca da lontano sul centro storico e il minareto del XVI° secolo, inserito nella chiesa medioevale di Sant’Antonio; con le sue vecchie case che portano ancora i segni della guerra e, soprattutto, con il suo bellissimo fiume: paesisticamente è l’elemento più vitale, con le sue anatre felici (tralasciamo i brutti edifici postbellici, cresciuti caoticamente qua e là, segno di uno sviluppo economico che non c’è stato).
“A Bihac al momento situazione “festiva” con luminarie e un sacco di gente in città, i migranti sono o dentro i campi ufficiali o in tre squat (stadio, pensionato, fabbrica) e chi ha il passaporto e la richiesta di asilo e paga può stare legalmente in appartamento privato” (comunicazione di un operatore internazionale a Bihac, fine dicembre 2019).
Il clima è mite: l’ecocidio può avere questa minima ricaduta vantaggiosa per chi deve percorrere a piedi la distanza fra la Bosnia e l’Italia. Comincerà a guastarsi quando saremo a Kladuša, con piogge desolanti sul terreno fradicio. Il freddo verrà sicuramente verso gennaio.
La mattina del 18 siamo andati all’ospedale per ritirare i documenti sanitari cui abbiamo accennato prima: che ci sono stati consegnati subito con gentilezza, sventando i nostri timori di lungaggini burocratiche. Così abbiamo avuto il tempo di fare un giro nei dintorni del Borici, dove abbiamo incontrato un gruppo di afghani respinti che vivono in un piccolissimo edificio abbandonato subito sotto l’ex-studentato. La loro presenza e anche di altri è evidente: la polizia quindi sembra tollerarli. Si tollera quando non si riesce a controllare.
A loro abbiamo consegnato scarpe e sacchi a pelo. Il numero degli abitanti dei cosiddetti squat è ovviamente incerto – alcune centinaia, pensiamo -; comunque si vedono in giro non solo in periferia e nei dintorni. Poco dopo abbiamo fatto lo stesso con alcuni ospiti del Borici, comunque bisognosi e altri che partivano per il game.
Alle 14,30 siamo arrivati di fronte al grande capannone del campo Bira, ormai parte integrante della nostra iconografia mentale quale immagine del campo ufficiale dell’UNHCR-IOM-UE, contrapposto al campo comunale di Vucjak, ora disfatto.
“In questo momento al campo che dovrebbe ospitare 1.500 persone ce ne sono 2.000. Il motivo per cui le persone dormono per terra o nelle tende dentro il campo è perché ufficialmente (politica bosniaca e decisioni cantonali) non si può superare le 1500 persone. Nonostante questo e senza pubblicizzarlo, IOM sta facendo comunque entrare le persone al campo quantomeno per dormire. Non possono però dare loro il cibo perché il cibo viene dato solo a chi è registrato nel campo (id card IOM). Ogni martedì mattina da sempre si fa la disinfestazione e derattizzazione del campo. Quando le persone rientrano devono fare vedere il tesserino del campo. Per questo motivo non entrano quelli non registrati che però dopo entrano dalle entrate laterali e tutti fanno finta di niente” (comunicazione citata).
Qui, fra i numerosi gruppetti di ragazzi che sostano fuori del campo – usciti con tesserino, “ospiti” semiclandestini o sopravviventi fuori – abbiamo incontrato il nostro amico ventunenne, che il giorno dopo porteremo a cena con le conseguenze punitive di cui sopra. E qui incontriamo anche il ragazzo afgano in carrozzella con i piedi fasciati…
Parliamo anche con un gruppetto di una quindicina di minori (14-16 anni), alcuni provenienti dall’Egitto. Si allarga la tragica platea di chi è costretto ad andarsene dalla propria terra. È del 29 dicembre la notizia dello sbarco a Pozzallo, dalla nave Alan Kurdi, di famiglie libiche, definite dai telegiornali “benestanti” o “borghesi”, in seguito al peggioramento della situazione in Libia, dove la guerra fra le due principali opposte fazioni di Serraj e Haftar sta precipitando con l’apporto sciacallesco di varie potenze europee e non!
Alcuni di noi si mettono a curare piedi, i piedi del game, di cui siamo diventati specialisti. sembra una battuta: ma lo dico con grande tristezza…
Davanti al Bira incontriamo anche la troupe televisiva di Tv 2000, con la quale avevamo fatto a Roma un’intervista nell’aprile di quest’anno. È venuta a incontrarci, guidata dal giornalista Vito D’Ettore, che intervista noi due e Franco Casagrande. Dobbiamo riconoscere a quest’azienda televisiva vescovile un interesse genuino e non strumentale per la problematica delle migrazioni, intervistando senza diaframmi operatori di cultura laica come noi. È questo un sostegno indiretto alla petizione fatta da Lorena, indirizzata alle istituzioni europee, che ha raggiunto quasi 55.000 firme e che non ha sortito altri effetti oltre a quello di coinvolgere per un momento i firmatari – ovviamente. Non siamo ingenui credenti nel carattere democratico dell’UE. Una petizione è solo un modesto strumento per agitare un problema, insistendo nella denuncia di una politica scellerata, che tuttavia continua indifferente.
Il 19 facciamo l’ennesima spesa di scarpe, al Bingo con una volontaria bosniaca. Più tardi incontriamo un ragazzo ferito in una rissa, a quanto ci dicono provocata da afghani. Il ragazzo è stato dimesso dall’ospedale con la ferita ancora aperta, cioè con una semplice disinfettazione, senza i punti che sarebbero stati necessari e con la prescrizione medica di un antibiotico generico: evidentemente il medico che l’ha visitato non lo ha ritenuto degno di un intervento completo.
Dopo un’altra distribuzione dell’oggetto più importante, le preziose scarpe (ci ricordiamo della figura del “greco” di Primo Levi nella Tregua che insegnava sulle scarpe come base vitale per chi affida la sua vita a un cammino?), verso le due, partiamo per Kljuc, a trovare la bravissima Sanella.
Arriviamo a Velečevo, il piccolo paese vallivo sul fiume Sana, al confine cantonale, dove vive e opera Sanella. È già buio sullo sterrato al margine della strada per Sarajevo, attraverso un tratto della Repubblica srpska, ostile ai migranti. Possiamo vedere per la prima volta un container appena montato e una struttura in legno, che rendono meno intollerabile lo scarico dei migranti dalle corriere da Tuzla e da Sarajevo, che due poliziotti, in sosta lì giorno e notte, provvedono a scaricare. Aspettiamo tre pullman. Questa volta nessuno. Andiamo in un locale di Kljuc a mangiare qualcosa con Sanella, cui abbiamo lasciato delle scarpe. Poco dopo le arriva una telefonata: c’è qualcuno che ha bisogno, sulla strada di Velečevo. Sanella ci saluta e corre via.
Il giorno dopo (20) incontriamo un’altra bravissima volontaria bosniaca, che ben conosciamo, cui lasciamo una somma di denaro. Ci accoglie nella sua casa ordinata e pulitissima. Una scrivania con il computer, piena di carte ben ordinate, testimonia della serietà e complessità del suo impegno.
I volontari locali devono stare attenti: un’altra donna, seriamente impegnata, con cui ci siamo incontrati la sera, ci racconta che, per aver permesso a un migrante di fare una doccia in casa sua, aveva ricevuto una multa altissima, sproporzionata rispetto alle condizioni di vita “normali” in Bosnia.
Più tardi, andiamo davanti all’edificio abbandonato sul fiume, dove parliamo con due ragazzi afghani che stavano in cima a uno dei terrazzi del rudere. Promettiamo di tornare la sera con delle scarpe. Promessa che non riusciamo a mantenere, perché i ragazzi di sera non si mostrano o non ci sono, forse per la presenza di un gruppo di magrebini, che si mostrano con noi troppo disinvolti.
Il pomeriggio ritorniamo davanti al Bira a parlare con i ragazzi. Distribuiamo scarpe e ci occupiamo anche un poco di curare piedi provati dal game. Molti i minorenni, soprattutto egiziani e marocchini che mostrano i segni dei colpi polizieschi (croati) sempre negli stessi punti, articolazioni e piedi, con l’evidente scopo di impedire il camminare. Qui incontriamo anche il ragazzo afghano minorenne con i piedi seviziati dalla polizia croata tanto da dover stare in carrozzella, cui abbiamo accennato prima.

A sera, infine, andiamo a cena con il nostro giovane amico in un albergo sul fiume: una bella serata per lui, che non si accorge degli sguardi non amichevoli di una famiglia bosniaca al tavolo accanto (colui che appariva come il capofamiglia addirittura si sposta per non doverlo avere sotto gli occhi). Ci ricordiamo di un altro sguardo poco simpatico, quello del padrone del nostro albergo a Bihac, quando ci ha visto in compagnia di migranti. Queste sono le emozioni sociali più diffuse o comunque più visibili a Bihac e nel Cantone. Soltanto la sera dopo, il nostro amico ci avvertirà al cellulare che la security gli aveva impedito di entrare, malgrado ne avesse il diritto e che lo avrebbe lasciato fuori anche per quella notte. Così la bella serata, che avevamo creduto di offrirgli, si era conclusa per lui nella pioggia e nel vento, a ribadire che un profugo non può esser felice neppure per una sera.
Sabato 21 partiamo per Velika Kladuša. Una frana che blocca la strada principale ci costringe a un giro tortuoso, lungo la strada per Bouzin per poi arrivare a Kladuša. In una vallata fra alti colli, su cui passa il confine, incontriamo gruppi che tornano dal game, nella sera che scende rapida sotto la pioggia battente: almeno una quindicina di persone.
A Kladuša andiamo a incontrare i volontari di NoNameKitchen, nell’appartamentino dove vivono: una decina di ragazzi, spagnoli, italiani, tedeschi, anche un americano. Il coordinatore, con nostro stupore data la lunga pratica con l’associazione, ci sembra avere qualche resistenza a parlare liberamente con noi. Indubbiamente, NoNameKitchen vive difficoltà crescenti, anche sotto il profilo organizzativo, per il continuo ricambio delle persone.
Arrivano, poi, anche i volontari di “Ospiti in arrivo” di Udine, con cui abbiamo coordinato in nostri aiuti in denaro a Kladuša, e una bravissima volontaria locale che ben conosciamo.
NNK ha problemi con la polizia, che ha tentato una perquisizione pur senza un mandato: evidentemente a scopo intimidatorio. La polizia ferma i volontari e chiede spesso i documenti. NNK ha dovuto chiudere la distribuzione regolare dei vestiti e dovrà chiudere anche la lavanderia. Senza dare nell’occhio, raggiunge quotidianamente 80-100 persone migranti fra punti concordati e “squat” (ci sono molti più “squat” di quanto si sappia). NNK paga anche cure mediche.
I volontari di “Ospiti in arrivo” sono stati fermati al confine e poi, a Kladuša, portati alla polizia per un controllo. Una settimana fa, un camion in arrivo dalla Spagna è stato fermato dai croati, costretto a scaricare il materiale, che arriva a Kladuša a piccoli blocchi e con difficoltà.
Parliamo della situazione locale. Sopravvivono 800 persone nel campo Miral e circa 600 in giro. Medici senza frontiere ha una clinica mobile tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì), per una quarantina di persone assistite al giorno. Fra le situazioni problematiche, ci parlano d’un ragazzo rimasto cieco d’un occhio e d’un altro con il braccio rotto. Sul versante dei rapporti con la popolazione, due locali sono stati chiusi perché servivano i migranti. Peggiorano anche i rapporti fra le diverse aree culturali: il piccolo ristorante Albanian restaurant, il locale dei migranti, dove si consumano cibi tradizionali e non si vendono alcolici, non accetta magrebini.
Veniamo informati che adesso, contrariamente a qualche tempo fa, i migranti possono viaggiare in autobus, se muniti di biglietto.
Ovviamente il problema maggiore è il freddo, che pure non è ancora arrivato in forze. In questi giorni piove insistentemente e i campi nei dintorni sono pieni di fango. Le nuvole basse, l’atmosfera umida e grigia danno un aspetto triste alla cittadina, proiettata verso il confine non solo per i migranti, ma anche per molti bosniaci che lavorano in Unione Europea, come ci costringe a capire la lunghissima fila di automobili, tutte le volte che abbiamo varcato il confine domenica sera – noi che possiamo.
Per concludere, la situazione è desolante perché affonda dentro il fango di ciò che appare come una mancanza di progettualità da parte di chi istituzionalmente dovrebbe occuparsene. Sembra tutto delegato alle polizie, quella croata in primis, pagata per questo, anche con il prossimo ingresso nell’Europa di Schengen e poi anche a quella slovena, che comincia a incattivirsi, alla serba, per non parlare di paesi come l’Ungheria. Cominciano a farsi avanti anche organizzazioni private paramilitari.
Le organizzazioni ufficiali presenti gestiscono l’esistente in termini di mera sopravvivenza, anzi un poco al di sotto. Infatti, i migranti soffrono, si ammalano e anche muoiono. Questa mancanza diventa di fatto un progetto: quello di umiliare, avvilire, stancare una sotto-umanità. E se ci scappa il morto – più di trenta nel solo cantone bosniaco – pazienza…
Non dimentichiamo, però, un dato importante – questo si che è un progetto implicito, ma anche esplicito e spiega tante cose: migliaia di persone che si muovono continuamente verso i confini d’Europa e vi si accalcano e comunque riescono a passare, sono anche un serbatoio di mano d’opera a costi minimi, servile e semischiavistica. Questo è un punto che va sottolineato, dato che il criterio economico, politico, culturale dello sfruttamento, è alla base delle nostre società delle merci e del denaro. L’apparente disordine sotto il cielo di Bosnia rimanda a un ordine inesorabile.
Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi
8/1/2020 comune-info.net




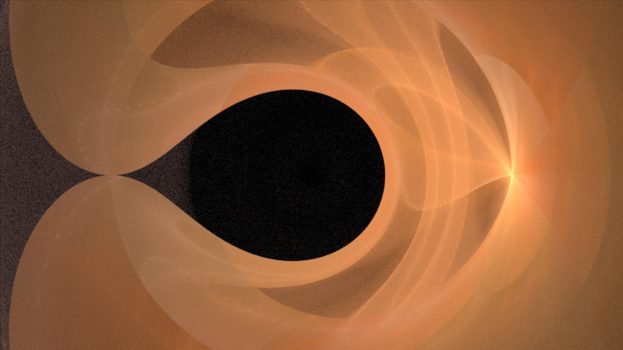





Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!