Walking Dead Quarticciolo
Il modello Caivano sbarca alla periferia di Roma. In nome della sicurezza si annuncia guerra alla criminalità organizzata ma anche alle esperienze sociali del quartiere. Un intervento calato dall’alto che rischia di accanirsi sulle alternative allo spaccio costruite faticosamente dagli abitanti
“Pensiamo, insieme a George A. Romero, che, in un’apocalisse zombi, la brutalità più folle sarebbe opera della civiltà sopravvissuta, non dei morti che camminano” Subcomandante Marcos
Lo scorso 23 dicembre la presidenza del consiglio ha emanato un decreto che estende il cosiddetto modello Caivano ad altri 6 luoghi in Italia. Posti diversi tra loro: periferie urbane e slum di braccianti; piazze di spaccio e paesi in via di spopolamento – sorteggiati secondo l’arbitrio e le pressioni interne a Fratelli d’Italia. Dal pallottoliere dell’emergenza è stato estratto anche il Quarticciolo, quartiere di 4 mila anime nella periferia est di Roma, devastato dal commercio e dal consumo del crack. A spingere per quest’esito è stato in particolare Don Coluccia, ennesimo epigono di Brumotti e Cicalone in abito talare, prete che si autodefinisce «antispaccio» ma che, tra la gestione di una comunità di recupero e le comparsate a fianco degli esponenti di Fratelli d’Italia, si batte per la chiusura del doposcuola e per lo sgombero delle famiglie che vivono nell’ex questura.
Il punto è sempre lo stesso. La destra propone un’idea di sicurezza che coincide con la criminalizzazione di ogni pratica extralegale. Non importa se si tratti di commerciare tonnellate di eroina o abitare in uno scantinato per mancanza di alternative: la risposta prevista è identica ed esemplare, affinché la dimostrazione di forza dello Stato educhi i devianti. Una mannaia che si abbatte su chi non è in grado di scansarsi, come testimoniano le operazioni «alto impatto» andate in scena negli ultimi mesi al Quarticciolo: sequestri di stupefacenti irrisori e persecuzione di laboratori abusivi di ceramica, ricoveri di fortuna e famiglie in emergenza abitativa.
Il modello Caivano rappresenta un salto di qualità di questa strategia: a finire sotto attacco sono direttamente quelle realtà sociali che allo spaccio e alla criminalità hanno fatto da argine, creando un’alternativa per gli abitanti del quartiere e preservando spazi liberi dal commercio e dal consumo di sostanze stupefacenti. Un attacco condotto con uno strumento sproporzionato e pericoloso: l’intervento diretto della presidenza del Consiglio con un portafoglio milionario e i poteri commissariali. Nessuna limitazione, al netto del Codice penale e della normativa antimafia.
Cosa effettivamente verrà fatto con questi poteri illimitati è ancora difficile da capire: il primo marzo scadrà il termine di 60 giorni per l’individuazione degli interventi da realizzare nel triennio successivo e per la nomina del sub commissario che ne coordinerà l’implementazione. Per quella data, le realtà sociali del territorio invitano a partecipare a una manifestazione per i lotti della borgata, per difendere il Quarticciolo e chiedere che i fondi stanziati vengano spesi per cambiarlo davvero, ma in meglio. Il rischio concreto, infatti, è che l’intervento governativo parta proprio dalla chiusura del doposcuola di quartiere. Per combattere il «disagio giovanile» e la «dispersione scolastica» – obiettivi che il decreto enuncia – si vorrebbe cancellare uno dei pochi presidi attivi su questi temi nel quartiere. Un paradosso? Purtroppo in linea con quanto avviene sul fronte dell’istruzione pubblica, dove l’unica scuola del quartiere è stata infatti dimensionata.
Zombieland e il crack
Piazza di spaccio dagli anni Ottanta, il Quarticciolo postCovid ha cambiato pelle, subendo gli effetti della trasformazione del mercato degli stupefacenti. Fino a pochi anni fa, il mercato della cocaina in queste strade non conosceva pausa. Non è un caso che a Roma la cocaina si chiami gergalmente «merce», perché effettivamente è la merce per eccellenza – contemporaneamente bene d’uso, oggettivazione del valore e feticcio. Al Quarticciolo, a fornire la merce erano postazioni stile drive in, a cui accostare la macchina per acquistare i «pezzi»: sempre operative, anche durante le operazioni di polizia o il lockdown. Ora però, la distribuzione ha scoperto le piattaforme e viaggia su Telegram. Da un giorno all’altro, l’industria più importante del quartiere è diventata invisibile. I capannelli agli incroci sono diventati obsoleti, come le agenzie di viaggio o le pagine gialle: ora, pony express insospettabili consegnano direttamente fuori al pub ciò che serve per continuare la serata, a prova di sguardi indiscreti, mentre un intero settore deve reinventarsi. Non è cambiato molto nel segmento della filiera che gestisce l’arrivo dei container nei porti – un oligopolio, con ben poche possibilità di entrata per nuovi attori. Al contrario, in basso per le strade di tutte le Quarticciolo del mondo, le cose si possono muovere abbastanza velocemente. La borgata dagli anni Ottanta è una One Company Town dei narcotici: il segmento specializzato della sua forza lavoro ha goduto dei benefit e del welfare aziendale, degli investimenti in eventi e concerti, nel branding che ha legato il territorio all’impresa e viceversa. Quando il mondo è cambiato, chi è stato rapido si è posizionato a monte del cambiamento, ha innovato il processo di distribuzione, si è garantito ancora lustri di alte retribuzioni. Fuori o dentro la galera.
Chi non è stato al passo dell’innovazione è piombato nella competizione con un esercito industriale di riserva violento e affamato, dove la componente migrante è egemone e dove un mercato di nicchia ha trovato una formidabile espansione. Crack, eroina e farmaci hanno consentito il recupero dell’archeologia industriale del precedente ciclo di vendita al dettaglio. I gazebo nei lotti sono tornati attivi, gli sportelli dei contatori di nuovo aperti, gli androni dei palazzi al buio con le lampadine svitate. A chi non abita lì potrebbe sembrare che tutto sia tornato come prima, ma invece è cambiato tutto.
Il crack è un’epidemia sociale, come il fentanyl negli Stati uniti, per fortuna con una diffusione ancora meno massiccia. Un’epidemia che fatichiamo anche a nominare e per cui non abbiamo strumenti. Per capirci: non abbiamo l’equivalente del metadone da dare a chi sta troppo fatto; non sappiamo quante persone lo consumano e che effetti produce sui disagi cronici che i consumatori hanno; i Serd sono ingolfati da migliaia di persone che hanno perso la patente di guida; non abbiamo operatori di strada; non facciamo riduzione del danno. Vediamo le persone annichilirsi nell’arco di due settimane. All’inizio vengono una volta al giorno, ma già alla fine della prima settimana devono venire mattina, pomeriggio e sera. Dopo dieci giorni, in molti casi, non sono più in grado di spostarsi. Devono essere vicino a dove sta la sostanza, devono trovare i 5€ – questo è il prezzo – che gli consentono di farsi un tiro. Per trovare i soldi, fanno ciò che nella vecchia piazza di spaccio non succedeva: rubano, aprono le macchine, rompono i tergicristalli per pulire le pipette, fanno commenti alle ragazze, mendicano, a volte tutte queste cose insieme. Non hanno un luogo dove stare e quindi si accampano, si accoppano, si accoppiano, si prostituiscono in ogni spazio che trovano. I giornali li chiamano zombie, l’azienda del trasporto pubblico locale cancella la fermata dell’autobus, i vigili urbani chiedono il trasferimento: hanno paura perché si buttano sotto le macchine.
Chi non può chiedere il trasferimento, però, sono gli abitanti del quartiere. O meglio: chi ha potuto se ne è già andato, ha chiuso il negozio se lo aveva, o dorme sul divano di un parente al paese. Alla scuola del quartiere, come al catechismo, non si iscrive più nessuno, e la sera non c’è una luce accesa.
Badate bene: non rimpiangiamo la fabbrica fordista, figuratevi i vecchi tempi in cui la vendita di cocaina regalava al quartiere concerti neomelodici e aiuole curate. Ma qualcosa è cambiato, e la velocità con cui questo avviene amplifica lo straniamento di fronte alla nuova manodopera del settore: ragazzi sempre più giovani, sempre meno autoctoni, che tra loro parlano una lingua che non capisci, di cui non fai in tempo a imparare il nome perché sono già altrove. Come al solito, il capitale non ha ideologia e segue la legge del mercato. La famiglia in questa industria è un costo e un vincolo: va mantenuta quando c’è un arresto, gli va garantito un alloggio, ne vanno ascoltati i malumori. Nessuno di questi problemi affligge minori non accompagnati, transitanti, richiedenti asilo, ospiti dei centri di accoglienza. La nuova forza lavoro non ha radici nel territorio e ambisce a starci il meno possibile – cioè, costa meno e non crea problemi. Anche nelle piazze di spaccio si afferma il caporalato come modello di organizzazione del lavoro Made in Italy.
Non è il Quarticciolo: questo è il mondo. In Messico i narcos, dopo aver sparso terrore tra la gente, aver vinto le elezioni ed essersi comprati tutti i ruoli che contano, hanno inondato di cocaina gli Stati uniti. Saturato il mercato hanno avuto necessità di diversificare il prodotto offerto: il Fentanyl, come il crack, è il prodotto perfetto per rilanciare un settore in crisi da sovrapproduzione, inducendo un consumo praticamente permanente che rilancia l’accumulazione. Global Value Chain e innovazione di prodotto.
C’è poi, come in ogni processo di mercato, la funzionalità alla fase storica, al momento che viviamo: il crack è una droga della crisi. Nell’alternanza tra sostanze di annichilimento (eroina) e sostanze per l’iperproduttività (psicofarmaci, ecstasy, cocaina) siamo di nuovo in una fase in cui masse di persone non sanno di che campare, le prospettive non sono radiose, la coperta si fa corta e l’evasione non deve consentirci di reggere ritmi più intensi. L’evasione deve gestire la sottoccupazione e i bassi salari. Una interpretazione di questo tipo rischia di ridurre tutto a una stilizzazione economicista, eppure una lettura materialista di cosa è oggi il mercato del consumo autodistruttivo prima o poi andrà fatta.
Scavare una buca e riempirla di polizia
La forma del legno, per esempio, viene trasformata e si fa di essa un tavolo. Ciò non di meno un tavolo resta legno, una cosa comune e percepibile. Ma appena si presenta come merce, esso si trasforma in una cosa sensibile-sovrasensibile. Non soltanto si appoggia con le sue gambe al terreno, ma si contrappone a tutte quante le merci e tira fuori dalla sua testa di legno storie molto più stravaganti che se cominciasse spontaneamente a ballare. Karl Marx
Marx, per descrivere un oggetto che diventa merce, evoca la magia: parla di un tavolo stravagante, più stravagante di un tavolo che balla. Impossibile non pensare a Mago Merlino che fa vedere a Semola come sistemare casa. Anche la cocaina quando diventa merce smette di essere solo una sostanza psicotropa e diventa «oscura», se ne parla come di un oggetto avvolto dal mistero la cui circolazione è guidata da leggi non immediatamente osservabili, qualcosa che vola e balla pur stando poggiata con le gambe sul terreno.
Si dice che occorre «fare luce», intere carriere mediatiche si costruiscono sul «coraggio di fare luce». La si tratta come un arcano da svelare. Eppure questo è paradossale perché l’industria del commercio di droga è tutto meno che clandestina in questa città come altrove.
Non si nasconde, non camuffa i suoi comportamenti, i suoi esponenti sono sui giornali tutti i giorni e su Tik Tok ogni minuto. Mappe, cognomi, nascondigli: ogni giorno si fa luce su quello che già è illuminato. A Ponza, allo stadio, a Ponte Milvio. Ovunque ci sia possibilità di mostrarsi, l’intera filiera della merce fa vanto di sé. Ormai la situazione è paradossale, da noi come nel resto di Roma: ci sono gli speciali televisivi, i libri, le deposizioni in tribunale, gli audio delle deposizioni a disposizione di tutti, le recensioni su internet su dove si vende cosa. È un gioco di prestigio di cui è universalmente conosciuto il trucco – quindi, esattamente, su cosa occorre far luce? Certo sappiamo poco di come si muovono i container e dei rapporti che sono necessari e inevitabili perché la circolazione non si fermi mai. Ma in fondo questo non sembra interessare chi va a far luce nelle piazze di spaccio.
È evidente che la povertà è la precondizione per accettare la prospettiva del carcere come un orizzonte non solo plausibile, ma per alcuni versi ineluttabile. Un rito di iniziazione per chi vive contesti marginalizzati che consente il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, da fare il palo a confezionare dosi e poi magari arrivare ad avere una sala slot o un solarium.
Gli interventi proposti non mirano ad affrontare le condizioni strutturali che contribuiscono alla pervasività dell’economia criminale ma si concentrano sull’eliminare ogni forma di opacità, a far luce nelle presunte tenebre. Tendenzialmente spianando tutto quello che incontrano.
L’obbiettivo diventa quindi fare un deserto a forza di una pesca a strascico tra i più disperati per poi riempirla di polizia. Nonostante sia evidente che questo non potrà essere fatto in ogni quartiere in un paese in cui già oggi i detenuti sono 3 volte quelli del 1990, anche l’intervento proposto dal modello Caivano bypassa il tema di come affrontare la povertà assoluta nei quartieri di edilizia residenziale pubblica.
Sbagliamo a pensare però che sia un approccio che non dà risultati: se non serve a nulla per limitare lo spaccio, agisce però ferocemente contro le realtà sociali e le forme di solidarietà nei quartieri e genera consenso tra il pubblico a casa che può apprezzare l’inflessibilità di chi governa.
Un risultato concreto, ad esempio, lo ottiene quando il personaggio mediatico di turno individua un palazzo o la casa di un «abusivo»: si procede allo sfratto, allo sgombero o ai distacchi dell’acqua e della corrente, senza che nessuno si preoccupi neanche di verificare se le sue illazioni hanno qualche fondamento. L’illegalità viene presentata come un dogma astratto e omogeneo, il presunto comportamento illecito è messo sotto i riflettori, non importa se si occupa per necessità o per costruire la base di appoggio di un racket criminale, lo Stato interviene e ripristina la sua autorità spaccando i lavandini e saldando piastre di alluminio agli ingressi degli alloggi per tenerli vuoti.
Ma allora perché non parliamo di questo: Fratelli d’Italia a Roma sta portando avanti una campagna per sfrattare le famiglie dalle case popolari, annichilire le esperienze politiche in periferia, e raccogliere consensi sull’insicurezza che vivono le persone nei quartieri in cui si vende e consuma crack.
Per farlo manda avanti Don Coluccia, e raccoglie i frutti sfruttando le postazioni guadagnate alle elezioni e con lo spoil system nelle aziende regionali: presidenza del municipio VI, presidenza della Regione, vicepresidenza della Camera, direzione generale e dirigenti apicali di Ater. È giusto tutto questo? Risolverà il problema della fatiscenza del patrimonio pubblico o contribuirà a rendere più eque ed efficaci le politiche per la casa? Avrà risultati differenti dallo spostare da una parte all’altra della città i luoghi in cui si vende crack? Ha qualcosa a che fare con il contrasto alla pervasività della criminalità organizzata? Sinceramente gli atti degli apostoli letti ai ragazzini maghrebini che fanno i pali ci sembrano solo una cortina fumogena. Qualcosa di simile alle formule degli incantesimi.
Poniamo provocatoriamente una domanda: quanto è comodo? Per la politica in particolare. Una città che paga un prezzo altissimo alla mancanza di pianificazione e governo del territorio, una contingenza economica segnata da una nuova stagione di tagli alla spesa sociale. Un territorio in cui si accumulano come fossili i tentativi andati a vuoto, le promesse non mantenute, le millanterie più sfacciate. Un asilo che non è mai stato più di una gettata di cemento, una piscina che conserva le tracce di vite passate tra la vegetazione spontanea che oggi sostituisce le corsie, un consultorio che apre sempre meno, con sempre meno personale, con sempre meno strumentazioni. Quartieri in cui è laureato il 6 o 7% degli abitanti, a essere occupati siamo il 30 o al massimo il 40% di chi ci vive. Luoghi in cui non si ha letteralmente idea di cosa debbano campare e in cui si sta scegliendo di chiudere le scuole, i presidi sanitari, gli impianti sportivi, di abbandonare gli spazi pubblici. Non siamo scemi: lo sappiamo che non basta riaprire il campo da calcio per fermare l’epidemia di crack in corso, ma quanto è più facile per tutti parlare solo di quanta gente va cacciata di casa e quanta va messa in galera senza doversi prendere mezza responsabilità su quanto si è detto e fatto in questi anni? In questi decenni?
Sicuramente non è affatto comodo per chi ci abita e per chi ci fa attività sociale. Non solo per noi che siamo allergici alle regole e pieni di pregiudizi perché «riconducibili agli ambienti della sinistra radicale». Anche per i parroci che hanno gli oratori, per le associazioni che fanno i doposcuola, per gli operatori sociali, per le associazioni antimafia, per gli scout. Gente che in modi molto diversi accompagna i ragazzi e le ragazze nella loro crescita e quando li vede diventare adulti deve scegliere se aiutarli ad andarsene o se avere buone probabilità di vederli all’angolo di una via.
Questa è la destra che inizia la sua campagna elettorale per le comunali. Nella sua forma più pura, quasi didascalica: criminalizzazione della povertà, individuazione di nemici pubblici, gesti eclatanti, esibizioni muscolari. Questa gente mette in conto le contestazioni e non subisce la razionalità delle argomentazioni: non gli importa nulla che sia semplicemente falso sostenere che sfrattare una famiglia aiuti la lotta allo spaccio, non gli importa nulla dell’insostenibilità sociale, economica e politica di una forma di governo che prevede come unico strumento l’intervento dei reparti celere e la carcerazione, non gli interessa di cosa pensano operatori sociali, insegnanti di scuola, amministratori di prossimità.
Ha un solo argomento: il fatto che agisce, questo è il messaggio dell’inquietante vicenda del Quarticciolo. «Nessuno fa niente, noi qua veniamo e mostriamo il pugno di ferro». Ora è su questo terreno che saremo chiamati alla risposta, sulla prova muscolare annunciata, faremo la nostra parte con intelligenza e determinazione in primo luogo per sottrarci, per non regalargli nulla, per non consentirgli di agire indisturbati, per disertare uno scontro impari. Su questo dal primo minuto abbiamo chiesto aiuto, serve tutta la città questa volta per ottenere che gli interventi finanziati dal decreto Caivano non diventino cattedrali nel deserto, per difendere il Quarticciolo dallo sgombero dell’ex questura, per cambiare veramente questo quartiere.
Non si tratta di resistere, perché non c’è nulla da difendere in una borgata devastata dall’abbandono istituzionale e dalla monocultura del crack. Si tratta di affermare un nostro modello, il modello Quarticciolo, che parta dalle esperienze che animano nonostante tutto questa borgata. Si tratta di convergere il primo marzo perché al di là dei dieci cortili della borgata romana, da qualche parte occorre fermarli. Si tratta di saperci ascoltare e di sapere agire.
Mario Pinceta è l’anagramma di Remo Capitani, personaggio mitologico del Quarticciolo, partigiano e stuntman, espropriatore di nazisti e cattivo in Lo chiamavano Trinità; con questa firma gli attivisti del quartiere hanno scelto di firmare questo intervento. C’è qualcosa di ricorrente nel rapporto tra l’impegno politico in borgata e i b-movie, a cui questa firma vuole alludere.
17/272025 https://jacobinitalia.it/


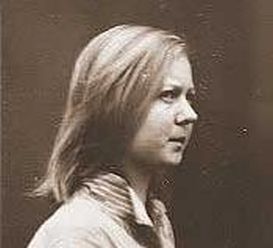







Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!